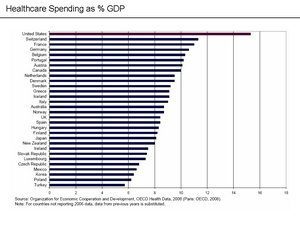Una storia africana, un Paese di cui non si parla mai ma che è emblematico delle problematiche che affliggono buona parte del continente. Dalle promesse mancate alle speranze per il futuro
L’ACCORDO MANCATO – Se si guarda oggi alla drammatica situazione in cui versa la Repubblica Centrafricana (RCA), non si può fare a meno di sentirsi attraversati da un unico, grande interrogativo: che ne è stato degli accordi di pace del dicembre 2008? O meglio, dove è finita la buona volontà che aveva animato il cosiddetto Inclusive Political Dialogue (IPD)? Quando il generale François Bozizé depose con un colpo di stato il governo civile retto da Patassé (nel 2003), il gigante centrafricano precipitò in una spirale di violenza apparentemente priva di vie d’uscita. Eppure fu proprio lo stesso Bozizé (confermatosi alla guida del paese in seguito alle elezioni del 2005) ad escogitare un’eccellente way out. L’IPD sembrò un piano pieno di speranza, dal quale nessuno sarebbe stato escluso. La fazione sostenitrice del Presidente, l’opposizione capeggiata da Patassé, i ribelli delle province nord-orientali e svariati gruppi di attivisti della società civile furono chiamati a lavorare insieme per ridefinire i delicati equilibri politici del paese. Tutto ciò accadeva nel 2007. Dopo una breve fase di stallo, i diversi interlocutori divennero meno rigidi, abbandonando pretese di dominio e volgendosi piuttosto alla via del compromesso. Nel giro di un anno si giunse ad un accordo che prometteva a ciascun gruppo una fetta di potere e responsabilità in RCA: Bozizé si rese protagonista di una storica apertura all’opposizione e i ribelli acconsentirono a far tacere le armi in cambio di incarichi all’interno delle istituzioni nazionali.Sulla carta, la RCA appariva allora come fulgido esempio di una riconciliazione nazionale possibile, come modello da esportare nei disastrati paesi confinanti (Sudan, Ciad, Repubblica Democratica del Congo). Fin quando qualcosa si ruppe. Oggi non possiamo che constatare che l’IPD è stato un accordo mancato. Alla luce dell’instabilità politica che ha segnato tutto il 2009, il traguardo dell’organizzazione di elezioni presidenziali nel 2010 pare ormai distante anni luce. Governo e opposizione si sono aggrediti senza sosta nel corso dei lavori per la creazione di una Commissione Elettorale Indipendente, rendendo impossibile qualsiasi passo in avanti. A ciò deve aggiungersi il fatto che i ribelli hanno imbracciato nuovamente le armi, scagliandosi contro le truppe governative e creando malintesi di carattere territoriale che hanno addirittura risvegliato antiche rivalità tribali nelle regioni nordorientali.

UN ARGINE ALLA CRISI – Per evitare che un documento prezioso come l’IPD diventi lettera morta, è necessario un impegno coordinato del governo centrafricano e della comunità internazionale. Sul fronte sicurezza, i nuovi gruppi ribelli e tribali sorti nel corso dello scorso anno devono essere inquadrati nel framework dell’IPD, evitando così che le loro voci inascoltate generino altra violenza. In secondo luogo, il governo dovrebbe beneficiare dell’expertise di UNDP (agenzia ONU che coordina i programmi di sviluppo) per accelerare i tempi di disarmo e reintegrazione degli ex combattenti nella vita civile del paese. Ad esempio, molti di essi potrebbero rivelarsi una risorsa per l’esercito e le forze di polizia nazionali. Sul fronte umanitario, la RCA potrebbe diventare il banco di prova della Peacebuilding Commission delle Nazioni Unite. Quest’ultima potrebbe fungere da arbitro imparziale per i problemi di coordinamento che attualmente rendono impossibile una gestione fluida degli aiuti internazionali. La situazione è grave, poiché la cattiva amministrazione dei fondi donati alla RCA ha creato immense sacche di corruzione.Solo dopo aver sanato queste ferite sarà possibile parlare di elezioni free and fair a Bangui. Magari non avranno luogo nell’aprile 2010, come annunciato, ma forse sarà meglio così.
Anna Bulzomi 3 febbraio 2010 [email protected]