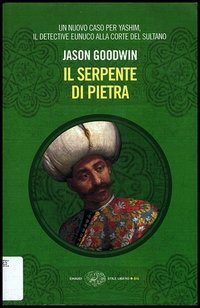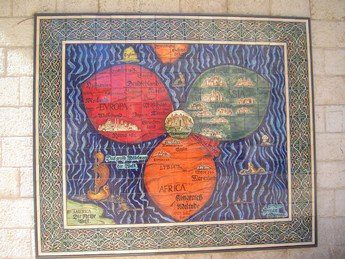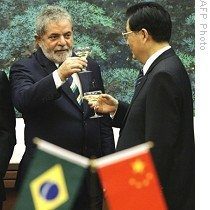Il premier Karamanlis si dimette e indice elezioni immediate (4 ottobre), consegnando quasi sicuramente la Grecia all’opposizione socialista, mentre il Paese sprofonda sempre più nel caos
FINE DELLA CORSA – L’agonia degli ultimi mesi è giunta a compimento mercoledì 2 Settembre. Kostas Karamanlis, Primo Ministro greco, ha preso la fatidica decisione. All in, direbbero gli appassionati di poker. Tutte le fiches su un solo numero, gli amanti del casinò. Dimissioni, ed elezioni anticipate. Anzi, immediate. Speranze di successo? Nessuna, o quasi. Tanti suoi ministri hanno già definito tale decisione un vero e proprio suicidio politico. Tutti alle urne, dunque, il 4 Ottobre, due anni prima della scadenza naturale della legislatura, con il Movimento Socialista Panellenico (Pasok) a giocare il ruolo di ultrafavorito. Anche il nuovo Governo, però, potrebbe avere vita breve: a marzo 2010 il Parlamento deve eleggere il Presidente greco. Se non si raggiunge una maggioranza di 3/5 (ed è possibile che il Pasok non arrivi ad avere una simile quota di rappresentanza parlamentare) si dovrebbe tornare a nuove, ulteriori elezioni. Ma perché si è giunti a questa situazione?
CONTROTENDENZA EUROPEA – Agonia, si diceva. Già le elezioni europee di giugno sottolineavano l’anomalia greca: mentre nel resto del continente è “soffiato il vento di destra”, in Grecia si è registrata una decisa affermazione del Pasok, che con il 36,65% (+2,62%) ha scavalcato il Partito di centrodestra al governo Nea Demokratia (32,39%, -10,69). Perché una disfatta così sonora?

CORRUZIONE, ECONOMIA, TENSIONI SOCIALI – Nelle elezioni legislative del 2007 la ND si è riconfermata al Governo con un programma avente tra i punti cardine l’aumento del tenore di vita, la diminuzione della corruzione, il miglioramento dei disastrati conti statali. Due anni dopo, nulla di tutto ciò ha visto la luce. Le divisioni interne di una maggioranza fragilissima (un solo parlamentare in più rispetto all’opposizione), e i manifesti episodi di corruzione (diversi scandali finanziari hanno portato alle dimissioni due Ministri e un Viceministro; e un sondaggio rivela che il 73% dei cittadini ritiene il Governo incapace di contrastare la corruzione, il 50% lo ritiene il principale artefice della stessa), hanno di fatto smembrato qualsiasi possibilità di azione dell’esecutivo. Inoltre, la crisi economica ha peggiorato ingentemente una situazione tutt’altro che florida. Il 14% dei lavoratori greci vive sotto la soglia di povertà, percependo un reddito inferiore al 60% della media nazionale (la media Ue si attesta all’8%). Limitando tale statistica ai minorenni, scopriamo che il dato sale sino al 25% (contro la media Ue del 19%). Tale povertà non è però dovuta alla disoccupazione, quanto all’insufficienza del reddito familiare. Da questi dati emerge chiaramente come in Grecia la distribuzione della ricchezza è una tra le più ineguali in Europa. E l’altissimo livello di debito pubblico (93,3% del Pil) ha reso impossibili efficaci contromisure.Tutto questo si somma all’ingente livello di tensione sociale, innalzatosi a livelli estremi dopo l’uccisione di Alexandros Grigoropoulos, un quindicenne ucciso da un poliziotto durante una manifestazione del dicembre 2008. Mobilitazione giovanile per la riforma universitaria, crescente opposizione dei sindacati, maxi-scioperi di lavoratori portuali e agricoltori: ce n’è abbastanza per una crisi di Governo, nonostante Karamanlis le avesse provate tutte per invertire la rotta: rimpasto di governo, nuovi reparti speciali di polizia per arginare la guerriglia urbana dei gruppi anarchici, nuove forme di controllo di spesa pubblica per una “tolleranza zero” contro la corruzione, ingenti investimenti per garantire liquidità e credito alle piccole e medie imprese. Non è bastato.
SCENARI POLITICI – Il risultato elettorale, come si diceva, sembra segnato. Dopo la gestione assai criticata dell’incendio che ha devastato l’Attica, bruciando 21.000 ettari di foreste, assediando Atene per tre giorni e costringendo migliaia di persone ad evacuare le proprie abitazioni, i sondaggi mostrano un’ingente distanza tra le parti. Il Pasok è attualmente dato tra il 31,7 e il 33,7%, mentre la ND tra il 25,7 e il 27,5%. Sei punti di distacco, quasi incolmabili in un mese di campagna elettorale. La distanza tra i leader è minore: il socialista Papandreou Capo del Governo è preferito dal 33,7% dei Greci, contro il 32,5% di Karamanlis, per la prima volta scavalcato personalmente nei sondaggi. L’attuale premier ha così deciso di giocarsi tutte le fiches in un mese esatto. Il rischio, però, è altissimo. Il 4 ottobre, giorno del rien ne va plus, potrebbe seriamente decretare la fine della sua avventura di governo.
Alberto Rossi [email protected]
Foto: in alto, un'immagine degli scontri avvenuti in Grecia
Sotto: il premier Kostas Karamanlis