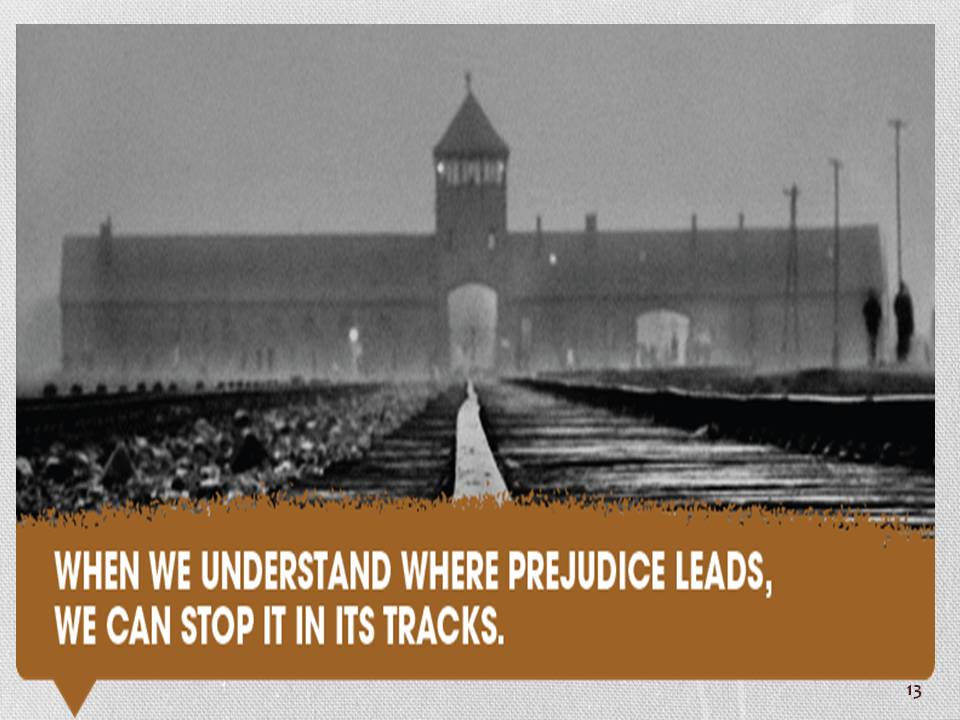Intervista al Prof. Mohammed Dajani, che ha organizzato la “storica” visita di un gruppo di studenti palestinesi ad Auschwitz. Pagandone anche le conseguenze
Elezioni Kosovo: il ritorno di Haradinaj
Le elezioni politiche svolte 8 giugno, hanno decretato come primo partito il PDK del Premier uscente Thaçi. L’opposizione si raggruppa in una grande coalizione per non andare ad un Thaçi III. Le elezioni hanno superato la prova di maturità democratica ma e caos per definire il nuovo Governo kosovaro.
Israele, gli scenari dopo l’operazione “Guardiano di mio fratello”
Il ritrovamento dei corpi senza vita dei tre ragazzi israeliani rapiti il 12 giugno scorso costituisce il termine dell’operazione Brother’s Keeper
L’Est europeista
Venerdì 27 giugno la Georgia, la Moldavia e l’Ucraina hanno siglato i rispettivi accordi di associazione con l’Unione Europea, portando ad una svolta un percorso travagliato. In 3 sorsi, uno per Paese.
La Svezia e la NATO dopo l’Ucraina
Il conflitto in Ucraina tra Russia e Occidente ha messo seriamente in discussione la sicurezza regionale nel Mar Baltico, costringendo i Paesi dell’area ad incrementare le proprie spese militari o a cercare maggiori garanzie internazionali in difesa della propria sovranità territoriale.
Da questo punto di vista la Svezia si trova in una difficile situazione, divisa tra tradizionali desideri di neutralità e la tentazione di entrare a far parte in modo permanente dell’Alleanza Atlantica.
UN RAPPORTO SPECIALE – Stoccolma ha stabilito legami stretti con la NATO sin dal 1994, come Paese membro del programma Partnership for Peace (PfP) organizzato dall’Alleanza Atlantica in risposta alle prime grandi trasformazioni geopolitiche del post-Guerra Fredda. Il programma è di tipo bilaterale e consente un’interazione flessibile tra la NATO e diversi Paesi non membri della sua tradizionale struttura politico-militare, dando spesso particolare enfasi a problematiche di tipo civile ed ambientale. Queste caratteristiche sono certamente alla base della decisione svedese di entrare a far parte del PfP, così come del suo significativo attivismo all’interno dell’iniziativa negli ultimi vent’anni. Truppe svedesi hanno infatti partecipato alle operazioni di peacekeeping NATO nei Balcani e Stoccolma ha anche fornito assistenza logistica e finanziaria alla recente campagna in Afghanistan contro i Talebani. Nel 2011 l’aviazione svedese ha persino partecipato direttamente alla campagna militare dell’Allenza Atlantica contro il regime di Gheddafi in Libia, conducendo alcune operazioni di pattugliamento aereo dalla base siciliana di Sigonella.
Nonostante questo rapporto speciale, però, la Svezia ha sempre rifiutato di diventare membro effettivo della NATO e questo suo atteggiamento reticente ha suscitato non poche perplessità in Occidente, specialmente dopo il conflitto russo-georgiano del 2008. In quella drammatica occasione il Governo svedese si è accontentato infatti di lanciare solo qualche vago ammonimento verbale contro la Russia, nonostante la sincera preoccupazione per la propria sicurezza nazionale, ed una sua successiva dichiarazione unilaterale di solidarietà agli altri Paesi baltici – con la promessa implicita di sostegno militare in caso di aggressione armata – ha provocato solo qualche risatina di scherno nelle principali cancellerie europee. Più di recente, la risposta pacata di Stoccolma alla crisi ucraina è stata duramente criticata dall’ambasciatore americano Mark Brzezinski, figlio del celebre stratega geopolitico Zbigniew, che ha ricordato pubblicamente agli svedesi il loro relativo isolamento internazionale e l’impossiblità per gli Stati Uniti di proteggerli efficacemente da un possibile attacco russo al di fuori dalla struttura formale della NATO.

UN DIBATTITO ACCESO – Le dichiarazioni di Brzezinski hanno causato non pochi malumori sulla stampa svedese e riacceso un vecchio dibattito che sembrava sopito ormai da tempo. Già tentata dall’opzione NATO alla fine degli anni Quaranta, la Svezia ha sempre finito per scegliere la sua tradizionale neutralità internazionale, vista come il miglior strumento per la sicurezza militare ed il progresso socio-economico del Paese. Tale neutralità è stata seguita fedelmente sino alla fine della Guerra Fredda, nonostante regolari contatti militari segreti con l’Occidente, ed è stata solo parzialmente scalfita dall’adesione formale della Svezia all’Unione Europea nel 1995. Grazie ad essa lo stato svedese ha messo in piedi un sistema di welfare sociale invidiato da tutto il mondo ed ha goduto di una considerevole reputazione diplomatica all’estero, venendo spesso coinvolto in negoziati di pace tra vari stati belligeranti in Africa ed Asia. La neutralità ha poi consentito un facile adattamento delle forze armate svedesi ai complessi scenari internazionali del post-Guerra Fredda, rimpiazzando in pochi anni un antiquato sistema di difesa territoriale con una struttura militare flessibile ed altamente tecnologica capace di intervenire rapidamente in ogni angolo del globo. Cosa ben più difficile per diversi Paesi NATO, costretti a coordinare il riadattamento delle rispettive forze di difesa con tutti gli altri partner dell’Alleanza Atlantica. Per tutti questi motivi il fronte “neutralista” è parecchio forte nell’attuale panorama politico svedese, potendo contare sul sostegno trasversale sia di conservatori che di progressisti. Aperti sostenitori di un’adesione alla NATO come il ministro degli esteri Carl Bildt sono parecchio attivi ma le loro argomentazioni filo-atlantiche non sembrano aver fatto breccia nell’opinione pubblica svedese persino dopo l’annessione russa della Crimea lo scorso marzo. Un recente sondaggio condotto dal quotidiano conservatore Svenska Dagbladet ha infatti rivelato che solo il 31% degli svedesi vuole il proprio Paese nell’Alleanza Atlantica, mentre oltre il 50% preferisce mantenere la tradizionale neutralità internazionale di Stoccolma. Visti tali risultati, una futura adesione svedese alla NATO appare assai improbabile, almeno per i prossimi anni.
NORDEFCO – La crisi ucraina e la politica estera “muscolare” di Vladimir Putin hanno comunque scosso la precedente apatia di Stoccolma verso la sicurezza baltica, vista in un’ottica prevalentemente ottimistica dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, ed hanno rilanciato le fortune politiche della Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), organizzazione per la difesa regionale creata congiuntamente da tutti i Paesi scandinavi nel 2009. Erede ideale della progettata unione di difesa scandinava degli anni Quaranta, la NORDEFCO ha una struttura flessibile e bilaterale simile a quella del PfP, consentendo ai vari Paesi membri un certa libertà diplomatica in cambio dell’impegno comune per la sicurezza del Nord Europa. Finora l’organizzazione ha mancato molti dei suoi principali obiettivi politico-militari ed è apparsa generalmente come una debole copia della NATO, messa su dalle nazioni scandinave per contenere le proprie crescenti spese militari.
Tuttavia la NORDEFCO sembra offrire la possibilità a Paesi neutrali come Svezia e Finlandia di difendere la propria sovranità nazionale senza i rischi politici, economici e militari di un’adesione aperta allo schieramento occidentale, che conplicherebbe non poco i loro equilibri interni e le loro relazioni esterne con Russia e Cina. Fino a che punto quest’opzione è percorribile nel nuovo acceso clima di confronto tra Russia e Occidente dopo l’annessione della Crimea? Difficile a dirsi, ma la Svezia sembra voler attualmente puntare le sue carte su di essa, mettendo da parte la più facile ma scomoda alternativa della NATO.
Simone Pelizza
Mentre l’Iraq collassa, il Kurdistan emerge
Approfittando del caos in cui è precipitato lo stato iracheno dopo l’offensiva dell’ISIS nel nord del Paese, il Kurdistan, già regione parzialmente svincolata dal controllo di Baghdad, accelera la sua corsa verso l’indipendenza finanziaria
Il nuovo sogno cinese
Le recensioni del Caffè – Giornalista e saggista, fondatore nel 2009 dell’agenzia editoriale China files, Simone Pieranni conosce bene le lunghe e intricate vicende del potere del Partito comunista cinese. Con la sua ultima fatica, il saggio edito per Manifesto libri nel 2013 dal titolo “Il nuovo sogno cinese”, cerca di raccontare gli anni complicati del passaggio del testimone dall’amministrazione Hu-Wen a quella Xi-Li, avvenuto non senza turbolenze, misteri e manovre sotto banco.
La vicenda di Bo Xilai, uno dei “principini” e governatore della municipalità di Chongqing, è l’esempio più significativo del magma ribollente che scorre sotto la superficie politica cinese, forse il caso politico più eclatante dalla repressione di venticinque anni fa in Piazza Tiananmen. Allo stesso tempo la lotta alla corruzione, sostenuta con vigore da Xi Jinping subito dopo la sua elezione, la volontà di colpire “le tigri e le mosche”, senza esclusione di colpi, e il coinvolgimento di Zhou Yongkang, ex membro del Comitato Centrale del Partito comunista cinese, hanno rappresentato una situazione interna al partito fluida, in mutamento.
Pieranni si sofferma in particolare sulle figure centrali della Cina del Diciottesimo Congresso del Partito comunista cinese, lo shibada, che hanno lavorato a un grande compromesso:il vecchio Jiang Zemin, il Presidente uscente Hu Jintao e il nuovo numero uno della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping. La transizione del 2012 è avvenuta grazie a questi tre uomini e le rispettive “correnti” interne al Partito, legate, come afferma l’autore, più da legami di affinità famigliari, storiche e di amicizia che da differenze politiche evidenti. Il confronto tra principini, populisti, membri del clan di Shanghai e della trasversale “cricca di Qinghua” ha partorito un Politburo che cercherà di garantire la stabilità, la crescita economica e il mantenimento del ruolo centrale del Partito nel sistema politico cinese. La minaccia rappresentata dalla “nuova Sinistra”, uscita sconfitta con il processo a Bo Xilai, sembra allontanata, così come i possibili nemici interni di Xi Jinping.
Il nuovo Presidente, che ricopre le tre più importanti cariche del paese, può così mettere in pratica e implementare lo slogan del “Sogno cinese“, e la Cina può riguadagnare secondo l’ottica dei suoi leader e della sua classe dirigente, il posto che le spetta nello scacchiere mondiale. Tuttavia senza riforme e senza un preciso progetto che lo sostenga, il Sogno cinese rischia di trasformarsi in un incubo. Il cammino di Xi sarà ostacolato da problemi che sono cresciuti nei decenni scorsi, e che rischiano di esplodere in futuro se non affrontati in modo drastico e determinato. Problemi che Pieranni descrive nella seconda parte del saggio, prendendo in esame una lunga serie di tematiche che ha affrontato più volte in passato in diversi articoli pubblicati per China files.
Partendo dalla tematica della censura del web, attraverso il Grande Firewall cinese o il Kung fu Net, fino ad arrivare al fenomeno dell’esercito dei 50 cents, Pieranni compie un’analisi delle possibili future spine nel fianco ai progetti di sviluppo e crescita dei dirigenti cinesi. Oltre al web, nel testo vengono descritti gli scioperi dei lavoratori dell’azienda Foxconn e della Sony, ma anche le proteste nelle piccole e medie aziende cinesi che non salgono alla ribalta delle cronache occidentali, il fenomeno dell’urbanizzazione, l’inquinamento delle acque e dell’aria, il problema dell’hukou, o permesso di soggiorno, il travaglio dei neolaureati che ogni anno affrontano il mondo del lavoro.
Lo slogan di “Sogno cinese” rischia di rimanere vuoto, indefinito e nebuloso se Xi Jinping non si impegnerà a fondo nell’affrontare le grandi contraddizioni che la “Terra di mezzo” cela al suo interno, spesso nascoste dai dati economici roboanti o dalle dichiarazioni di facciata dei leader. Come sottolinea Pieranni le sfide future di Xi Jinping e di tutti i membri del Comitato centrale del Partito comunista cinese sono enormi, così come è grande la speranza, in tutti i cinesi, che il Sogno cinese possa portare uno sviluppo sostenibile, una vita più agiata e, lasciato alle spalle il secolo delle umiliazioni, la Cina posso dialogare con le altre potenze mondiali sullo stesso piano.
Leggere quindi “Il nuovo sogno cinese” può introdurci nelle complessità della “Terra di mezzo”, fornendoci una base da cui partire per conoscere più a fondo il paese che sarà protagonista dei prossimi decenni. Un paese in transizione, membro di un sistema internazionale in mutamento, in un mondo che cambia a un ritmo forsennato.
Marco Bonaglia
L’Europa perde la pazienza con Israele
L’Europa ha perso la pazienza con Israele? Italia e Spagna invitano a non investire in Cisgiordania, Gaza e Golan per non incorrere in possibili diatribe legali su diritti umani e diritto internazionale.
Stamattina il quotidiano israeliano Ha’aretz, tramite il suo giornalista Barak Ravid, ha pubblicato notizia dell’avvertimento del Ministero degli Affari Esteri alle aziende italiane di non investire o fare affari con partner israeliani in Cisgiordania, Gaza e Golan per il rischio di incorrere in possibili accuse di violazione del diritto internazionale o di violazione dei diritti umani. Anche la Spagna si è unita all’Italia. La dichiarazione è stata giustificata dalla necessità di ratificare una decisione UE di fine 2012 e senza l’intenzione di boicottare Israele con il quale si intende invece sempre mantenere un buon rapporto di partnership economica.
Per quanto l’effetto reale sull’interscambio commerciale e gli investimenti sarà verosimilmente ridotto, tale mossa ha in realtà una serie di significati e implicazioni non sempre immediati:
1) Non va visto come un gesto isolato. A dicembre 2012 l’Unione Europea (UE) ha ratificato un documento che rifiuta finanziamenti a imprese di qualunque nazione che abbiano sede o facciano affari (investimenti, partecipazioni…) con entità israeliane oltre i confini israeliani del 1967, quindi Gaza, la Cisgiordania, il Golan. Il motivo dietro a questa decisione risiede nell’aver ignorato, da parte di Israele, le richieste UE di cessazione della costruzione di insediamenti in Cisgiordania.
2) Di fronte al fallimento, nei mesi scorsi, dell’iniziativa di pace USA guidata dal Segretario di Stato John Kerry, che ha riportato una forte opposizione proprio da parte israeliana, l’UE non ha visto passi che potessero farla ritornare sulla propria decisione.
3) Il fallimento dell’iniziativa di pace ha portato l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) a riprovare la strada del governo di coalizione con il movimento di Hamas, mossa aspramente osteggiata da Israele. Poco tempo dopo, in risposta al rapimento di tre ragazzi israeliani da parte, secondo Israele, di esponenti di Hamas, il governo di Gerusalemme ha lanciato l’operazione Brother’s Keeper (“Guardiano di mio fratello”) in Cisgiordania per la ricerca dei tre giovani e per lo smantellamento delle strutture di Hamas nell’area. L’operazione, condotta con grande dispiegamento di forze, è stata giudicata eccessiva nelle modalità non solo dall’ANP ma anche da vari governi occidentali, fornendo quindi a questi ultimi l’occasione per l’espressione di una maggiore incisività diplomatica, tramite l’avvertimento di oggi (la Francia lo aveva già fatto nei giorni scorsi, Germania e Gran Bretagna ancora prima).

4) Come hanno spiegato i Ministri degli Esteri coinvolti, l’avvertimento non è una proibizione, né è rivolta a boicottare Israele in toto, con il quale l’UE è interessata invece a mantenere l’attuale partnership economica. Ma come ha spiegato Lars Faaborg-Andersen, rappresentante dell’UE in Israele, è anche la risposta alla continua costruzione di insediamenti: “Gli stati membri hanno perso la pazienza nel non essere interpellati”.
5) Come detto, le parole usate negli avvertimenti non implicano alcun obbligo, né alcuna possibile sanzione (del resto non esiste una legislazione al riguardo), ma bisogna ricordare che si tratta di linguaggio diplomatico: anche solo citare ufficialmente “rischio di accuse per infrazione del diritto internazionale o di violazione dei diritti umani” significa implicare il fatto che si ritiene che la situazione sul campo possa presentare questi aspetti. In gergo diplomatico è insomma la cosa più vicina a una condanna che ci possa essere senza dirlo direttamente.
6) La vicenda alzerà i toni diplomatici e scatenerà un po’ di polemica tra le parti, con Israele che potrebbe controbattere autorizzando altri insediamenti. Scontenterà d’altra parte anche quella parte dell’opinione pubblica che invece vorrebbe parole più dure. Ma la diplomazia è l’arte di dire cosa si pensa senza offendere pubblicamente la controparte: in altre parole, i Ministri degli Esteri dell’UE sanno bene che alzare troppo i toni servirebbe solo a chiudere ulteriormente il dialogo con Israele sulla questione, con pochi effetti pratici. Sconsigliare ufficialmente gli investimenti, come fatto, ha invece un’impronta potenzialmente più significativa.
Realisticamente è difficile che quanto successo porti Israele a cambiare la propria politica sugli insediamenti nel breve periodo, e anzi potrebbe perfino radicalizzarla. Sul lungo potrebbe però essere una testa di ponte che permetta a una parte della sua opinione pubblica di mostrare più incisivamente la necessità di un cambio di rotta. E’ però ancora presto per verificarlo.
Lorenzo Nannetti
Verso un accordo sul nucleare iraniano
Si è concluso il quinto e penultimo round di colloqui per stipulare un accordo definitivo sul nucleare iraniano. Com’è andata?
Tra il 16 e il 20 Giugno i rappresentanti dei P5 +1 (Membri permanenti del Coniglio di Sicurezza + Germania) e la delegazione iraniana sono tornati a discutere a Vienna sulle condizioni essenziali per sottoscrivere un patto globale sulla questione. Nulla di nuovo emerge dopo 5 giorni di incontri, che rimandano la stesura di un’intesa al meeting del 2 Luglio.
DOSSIER APERTO – Si riaccende il dibattito internazionale per trovare entro il 20 Luglio un punto di incontro sul discusso e complesso dossier nucleare iraniano. A Vienna nulla di fatto. Sembra che lo storico impasse negoziale abbia colpito anche la presidenza Rouhani che rimane però aperta a dialogare con l’Occidente e si dice positiva circa il raggiungimento degli obiettivi congiunti. Dopo cinque giorni di colloqui le divergenze tra le parti rimangono sostanziali. Ancora non è stato accettato il numero delle centrifughe che rimarranno attive in Iran, l’indice massimo di arricchimento dell’uranio né la tabella di marcia per il sollevamento completo delle sanzioni. Quest’ultimo elemento, infatti, è la conditio sine qua non iraniana per una soluzione di accettabile compromesso.
I COLLOQUI DI VIENNA… – …si sono aperti con l’incontro tra l’Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell’UE Catherine Ashton e il Ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif. I due hanno discusso sulle necessità di maggior trasparenza del programma nucleare di Teheran. La determinazione iraniana nello sviluppare tecnologia dual use (potenzialmente impiegabile sia per uso civile che per quello militare) fa crescere quel margine di ambiguità che circonda il programma nucleare. La mancanza di fiducia, infatti, ha storicamente impantanato i dialoghi e irrigidito le singole posizioni: “Non sappiamo ancora se l’Iran è pronto a prendere tutte le misure necessarie per garantire al mondo che il suo programma nucleare è e resterà esclusivamente pacifico”, ha aggiunto Wendy Sherman, Sottosegretario di Stato americano per gli affari politici, una posizione che riflette soprattutto i timori della delegazione statunitense.
La serie di incontri svoltisi negli ultimi mesi riprendono i temi pattuiti lo scorso 9 Novembre a Ginevra in un accordo interinale, valido sei mesi ma prorogabile per altri sei. Le clausole poste dall’intesa, firmata il 20 Novembre ed entrata in vigore 2 mesi dopo (e definita da Israele “errore storico”) impegnavano l’Iran a mantenere metà dello stock arricchito al 20% per alimentare il reattore della capitale (per ottenere un ordigno atomico è necessario raggiungere il 90%), congelare il restante materiale fissile al 5 %, permettere l’accesso degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) agli impianti di arricchimento di Natanz e ai reattori di Arak, e interrompere il programma di arricchimento. In cambio la comunità internazionale si impegnava ad alleggerite le sanzioni internazionali, eccetto quello che riducono la vendita petrolifera, non imporne delle nuove, e sbloccare 4,2 dei 60 miliardi di dollari di proventi della vendita di gas e petrolio congelati nelle banche asiatiche.
ROTTURA COL PASSATO – Contrariamente a quanto si è assistito con gli ultraradicali al potere, quando il programma nucleare era la punta di diamante di una retorica intransigente (non solo iraniana), la Repubblica Islamica appare oggi più moderata, consapevole della necessità di trovare una mediazione per ridurre l’impatto catastrofico delle sanzioni sull’economia interna. Essa soprattutto avverte l’esigenza di uscire dall’isolamento internazionale in cui era stata volutamente collocata. Nonostante permangano linee di frizione tra le parti ,Teheran mantiene ferma la volontà di continuare “ad oltranza” le trattative fino alla firma di un patto definitivo, senza fare marcia indietro su quello che dichiara essere suo diritto imprescindibile di arricchire uranio nelle centrali nucleari.
RUOLO REGIONALE – Il difficile percorso verso la redazione di un accordo definitivo e globale, incontra l’ambizione dell’Iran di imporsi quale pivot e crocevia strategico nell’area. Una potenza regionale di primo piano che per rompere l’isolamento diplomatico e risollevare l’economia stagnante ha bisogno di dialogare con l’Occidente. Il meeting di Vienna e l’intero iter negoziale assumono così una valenza cruciale per l’Iran di Rouhani, desideroso di reinserirsi nel gioco regionale. I colloqui della scorsa settimana, tra l’altro, si sono svolti in concomitanza delle complesse vicissitudini che stanno affliggendo lo scenario iracheno, assediato dalle forze jihadiste sunnite dell’ISIS. La pericolosa faglia fondamentalista apertasi in Iraq è un elemento non secondario per Teheran che, grazie alla sua stabilità interna, potrebbe assurgere a ruolo di stabilizzatore nell’area e interferire direttamente nella lotta anti qaedista. Proprio in questo periodo gli Stati Uniti hanno ridotto le relazioni con l’alleato saudita (finanziatore indiretto dei movimenti sunniti nella regione) ai minimi storici, mostrando una possibilità a dialogare con Teheran per la risoluzione della polveriera irachena.
Chissà se proprio gli eventi di confine possano creare la situazione favorevole per accelerare il processo di distensione tra Iran e Stati Uniti e mettere la parola fine alla lunga diatriba della questione nucleare.
Giorgia Perletta
Passaggi marittimi strategici: lo stretto di Malacca
Miscela Strategica – Lo Stretto di Malacca è un braccio di mare lungo 800 chilometri situato tra la Penisola di Malacca e l’Isola di Sumatra, dipendenza dell’Oceano Indiano.
I suoi bordi si estendono lungo Indonesia, Malesia, Singapore e Tailandia e rappresenta un punto di connessione tra il mare delle Andamane a nord e il mar Cinese Meridionale a sud. Lo stretto di Malacca è inoltre la maggiore via di comunicazione marittima tra l’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano. L’insieme di queste caratteristiche lo rende una delle rotte marittime più frequentate al mondo e un’area strategica di vitale importanza.
UN PASSAGGIO STRATEGICO FONDAMENTALE – La posizione geografica dello stretto di Malacca lo rende un punto di transito importantissimo per riserve energetiche di vario tipo, dal petrolio al gas naturale e a materie prime come carbone o acciaio. Lo stretto costituisce uno snodo del traffico marittimo da Oriente a Occidente e rappresenta la via marittima più breve per il commercio tra attori situati nel Golfo Persico e quelli dei mercati asiatici, in particolare la Cina, il Giappone, la Corea del Sud e i Paesi del Pacific Rim. Secondo la United States Energy Information Administration lo stretto di Malacca è il secondo passaggio marittimo strategico per il trasporto di petrolio, secondo solo allo stretto di Hormuz. Alcuni studi dimostrano che, nel 2011, 15 milioni di barili di petrolio e derivati sono passati attraverso Malacca, ovvero circa un terzo del petrolio trasportato via mare. Più in generale, un terzo del commercio mondiale passa attraverso questo punto generando un traffico di 60000 navi all’anno che lo attraversano. Altri dati sottolineano come Paesi quali gli Stati Uniti e il Giappone o economie in forte crescita come la Cina e l’India sono in fase di incremento della propria dipendenza energetica dalla sicurezza dello stretto. L’area attorno a questo passaggio marittimo può essere descritta come un crocevia di culture e società etnicamente diverse ma in procinto di aumentare le proprie interconnessioni grazie anche alla crescente integrazione economica nella regione. In questo senso, lo stretto potrebbe rappresentare una notevole opportunità di sviluppo economico e sociale degli Stati che vi si affacciano. Alla base di tale sviluppo si situa non solo la capacità di mantenere pace e stabilità nella regione ma anche quella di garantire la sicurezza dello stretto potenzialmente sottoposto a minacce di diversa natura.

GEOSTRATEGIA E MINACCE ALLA SICUREZZA – L’area in cui si situa lo stretto di Malacca è potenzialmente vulnerabile ad una serie di minacce che potrebbero intaccarne la sicurezza: dalla instabilità politica in alcuni Stati limitrofi, alla competizione tra Stati regionali, alla pirateria e al terrorismo internazionale. Lo stretto è noto per l’annosa presenza della pirateria oltre che per essere un punto di transito per numerosi tipi di mercato nero. Infatti, nell’area circostante lo stretto, alcuni porti non propriamente sorvegliati favoriscono l’infiltrarsi di numerose minacce alla stabilità e sicurezza dello stretto. Il debole controllo da parte di alcuni governi dei Paesi che si affacciano sullo stretto e la marginalizzazione economica fomentata dalla crisi, porta alcuni individui a intraprendere la via del crimine, favorendo i mercati neri e pirateria.
Sebbene alcuni dati dell’International Maritime Bureau dimostrino come essa sia in diminuzione, gli sforzi collettivi dei Paesi litoranei per combatterla hanno bisogno di maggiore coordinazione e risorse. Queste infatti differiscono tra loro a seconda delle capacità economiche e governative di Indonesia, Singapore e Malesia. In termini di capacità, Singapore è sicuramente più organizzata e tecnologicamente avanzata di Indonesia e Malesia. Quest’ultima ha intrapreso sforzi maggiori contro la pirateria negli ultimi anni anche se molte iniziative sono state concentrate sui versanti economico e ambientale invece che sulla sicurezza. Da parte sua, l’Indonesia continua ad avere problemi nell’implementare iniziative anti-pirateria totalmente efficaci. La sua estensione geografica non permette un controllo governativo stabile in ogni area e la presenza di gruppi fondamentalisti islamici e separatisti costituisce un’ulteriore pressione per il governo centrale. Inoltre, all’instabilità sociale in territori come l’Indonesia si aggiunge la presenza di varie cellule terroristiche che fomentano i livelli di sicurezza. La minaccia di attacchi terroristici è stata paventata in alcune occasioni e molte analisi convergono sul fatto che un attacco terroristico abbia più probabilità di avere luogo in stretti con un livello di sorveglianza regionale e internazionale inferiore. A tutto ciò si aggiungano le dispute riguardanti l’area del Mare Cinese Meridionale che si fondano su questioni politiche, economiche e strategiche e aggiungono tensione ad un’area già potenzialmente a rischio di destabilizzazione. Lo Stretto di Malacca termina nel Mar Cinese Meridionale, un’altra via di comunicazione estremamente importante ma soggetta a dispute legate alla presenza di risorse come petrolio e gas naturale oltre che ad annose dispute territoriali. In particolare, il gruppo di isole Spratly e Paracel sono oggetto di contesa tra Cina, Vietnam, Malesia, Indonesia, Brunei e Filippine. La crescita economica della regione comporta anche il transito di notevoli quantità di petrolio, gas e materie prime attraverso quest’area. Il 25% del transito del commercio globale la percorre ogni anno ed è di per sé esplicativo dell’importanza del Mar Cinese Meridionale come estensione dello Stretto di Malacca.

INTERESSI REGIONALI E INTERNAZIONALI NELLO STRETTO DI MALACCA – Essendo Malacca il secondo stretto al mondo per traffico marittimo e importanza strategica, l’area circostante è soggetta a competizione non solo da parte di attori regionali. Anche attori globali come la Cina, gli Stati Uniti, il Giappone e l’India dipendono dalla sicurezza e controllo dello stretto in termini economici, geopolitici e strategici. Gli Stati Uniti, in quanto potenza marittima globale, vedono l’India e il Giappone come potenziali alleati nel gioco di bilanciamento contro l’ascesa della Cina. In questo modo diverse dinamiche intervengono nei rapporti tra poteri regionali e globali esercitando pressione anche su questi ultimi, in vista del dispiegamento di forze e interventi che garantiscano la sicurezza nello stretto. Essendo gli interessi di ciascuno stato abbastanza diversificati, vale la pena di inquadrare queste dinamiche nel dettaglio. Il Giappone ha un particolare interesse nell’invio di forze nello stretto di Malacca fondamentalmente perché circa l’80% del petrolio importato per uso nazionale proviene dal Medioriente e passa attraverso lo stretto come anche una consistente quantità di prodotti manifatturieri giapponesi che transitano verso l’Europa, l’Australi, il Medioriente e l’Africa. La sicurezza del Giapppone nello stretto si basa sulla sua forte alleanza con gli Stati Uniti, altro attore fondamentale nei giochi di potere nello stretto, che naturalmente puntano a non essere estromessi ma anche a bilanciare la crescita di influenza di potenze emergenti come Cina e India.
Nuova Dehli annovera circa il 50% dei suoi traffici commerciali in transito attraverso lo stretto di Malacca e ha ulteriormente concentrato i suoi sforzi politici verso l’Asia del Sud visto che è di suo vitale interesse che lo stretto rimanga sotto l’influenza di Paesi amici.
Come già accennato, la Cina dipende fortemente dallo stretto per il trasporto di energia che cresce notevolmente di anno in anno. Il petrolio proveniente da Golfo Persico e Africa transita verso la Cina attraverso gli stretti di Malacca, Lombok o Makassar. Negli ultimi anni Pechino è stata molto attiva nel coltivare relazioni diplomatiche con i paesi litoranei, in particolare la Malesia. E’ chiaro che la crescita ed espansione di Paesi come la Cina passa e può essere regolata anche attraverso il controllo delle sue forze navali attraverso lo stretto.
Se la Cina fosse in grado di controllare tale passaggio, ridurrebbe la possibilità di egemonia statunitense nella regione visto che lo stretto è diventato un passaggio cruciale per la mobilità commerciale e strategica. D’altronde la tensione nell’area è stata già fomentata dalla Cina che non solo rivendica la sovranità sulle isole Parcels e Spratzly nel Mare Cinese Meridionale ma anche le isole Senkaku/Diaoyu nel Mar Cinese Orientale, disputate con il Giappone. Considerando queste isole come proprie, Pechino è arrivata a rivendicare la propria sovranità su circa l’80% del Mare Cinese Meridionale.
Il novero delle dispute non può non tenere conto di quelle tra Stati litoranei dello Stretto. L’economia della Malesia dipende in parte dal mercato ittico e vede lo stretto come una arteria fondamentale per questioni di risorse ma anche difesa, servizi, commercio e turismo. D’altronde,tutti i porti della Malesia sono situati lungo lo stretto.
Per quanto riguarda l’Indonesia, lo stretto rappresenta un immenso valore per ragioni socio-economiche. La costa indonesiana è quella che si estende più a lungo sullo stretto. La maggior parte dei pirati nello stretto si pensa provenga dall’Indonesia e sia provocata anche dalla instabilità politica ed economica del Paese.
Infine, Singapore ha profuso apprezzabili sforzi contro la pirateria nello stretto da cui passa una notevole quantità dei propri traffici commerciali. L’importanza della sicurezza nello stretto ha spinto Singapore a cercare una stretta collaborazione nel garantire la sicurezza con partner esterni, specialmente gli Giappone e gli Stati Uniti che hanno stretto maggiori legami di collaborazione a livello strategico ma anche incrementato le relazioni commerciali con Singapore, diventato il loro undicesimo partner commerciale.
Annalisa De Vitis
Realtà virtuale e realtà aumentata nel campo di battaglia
Miscela Strategica – La realtà virtuale e quella aumentata stanno cambiando l’addestramento e l’approccio tattico alla battaglia. I soldati potranno davvero ricorrere a una sorta di “sesto senso”?
Scopriamolo insieme
DALLA REALTA’ VIRTUALE… – L’informatica ha cambiato radicalmente il funzionamento di numerosi sistemi d’arma e, conseguentemente, l’approccio in battaglia. Le novità introdotte, però, non si sono limitate alla gestione degli armamenti e dei loro componenti sempre più complessi: l’impatto è stato molto più profondo.
Negli ultimi trent’anni le nuove tecnologie hanno portato allo sviluppo della cosiddetta “realtà virtuale” (virtual reality-VR), definibile come una simulazione di un ambiente o di un mondo alternativo creato con l’ausilio del computer. Nel tempo la VR è stata resa ancora più realistica con l’integrazione di periferiche – come guanti e visori – che “immergono” chi li indossa in una realtà alternativa in grado di coinvolge buona parte dei sensi. Lo sviluppo di programmi e periferiche ha interessato, facendole anche collaborare in alcuni frangenti, sia l’industria dell’intrattenimento (videogiochi e sistemi home theater) che quella militare.
Infatti per la produzione di simulatori – di volo, di carri armati, di navi e di fanteria – possono essere chiamate a collaborare famose software house di videogiochi. E’ questo il caso della tedesca Crytek che ha sviluppato la piattaforma tecnologica alla base del Dismounted Soldier Training System di Intelligent Decisions, il sistema VR di fanteria utilizzato dall’esercito americano.
Per quanto riguarda i simulatori di mezzi, l’apparecchiatura comprende anche sistemi idraulici ingombranti necessari per generare spinte e sollecitazioni realistiche anche se, soprattutto per i velivoli, questo tipo di riproduzione non raggiunge ancora il grado di libertà adeguato. Basta pensare, infatti, che per gli abitacoli simulati non è ancora possibile riprodurre le accelerazioni gravitazionali positive e negative che un pilota da caccia sopporta durante l’esecuzione di manovre brusche o evasive.
Il vantaggio di questo tipo di apparecchiature è evidente: consentono di ridurre fortemente i costi di addestramento senza ricorrere al “fuoco vivo” – l’utilizzo di munizioni vere – e di riprodurre innumerevoli scenari di impiego operativo.

…A QUELLA AUMENTATA – Contemporaneamente alla VR, le novità informatiche hanno permesso la ricerca di soluzioni innovative per l’esigenza, fortemente sentita sul campo di battaglia, di incrementare le informazioni a disposizione dei soldati, superando le limitazione dei sensi.
La cosiddetta realtà aumentata (augmented reality-AR) non è una novità: il cruscotto di un’automobile consente di incrementare la percezione umana fornendo dati normalmente irrilevabili come velocità, temperatura esterna e numero di giri del motore.
In ambito militare una prima applicazione ha riguardato i velivoli da caccia con la dotazione dell’HUD (Head up display, visore a sovrimpressione), successivamente installato anche sugli elicotteri, che consente di visualizzare i dati di volo (come quota, velocità e beccheggio) e di ingaggio del bersaglio (lock-on) senza distogliere lo sguardo per controllare la strumentazione di bordo.
Un notevole passo avanti è stato fatto con i caschi di piloti e cannonieri degli elicotteri d’attacco AH-64 Apachestatunitensi, corredati di un monocolo che visualizza dati di navigazione e per l’aggancio dei bersagli.
Attualmente lo stato dell’arte per questa tipologia di caschi è rappresentato da quello, ancora in via di sviluppo, per il cacciabombardiere statunitense F-35. Il sistema Helmet Mounted Display Systems (HMDS) dell’F-35 consente la navigazione ognitempo, essendo integrato con visori notturni, e garantisce un flusso continuo e diretto di dati di navigazione e attacco, integrati da un circuito composto da sei telecamere esterne a raggi infrarossi grazie alle quali il pilota riuscirà a vedere oltre l’abitacolo.
L’esigenza di superare i limiti posti dai cinque sensi è fortemente sentita anche per la fanteria e i mezzi terrestri. Come già successo in alcuni casi per lo sviluppo dei simulatori, l’industria civile e militare si sono trovate a collaborare dando vita a sinergie inattese.
L’azienda statunitense Oculus VR Inc, specializzata nella realizzazione di visori per videogames, è stata acquistata nel marzo scorso da Facebook, il gigante del social network, e attualmente i loro occhiali per la realtà aumentata sono in sperimentazione da parte delle forze armate norvegesi.
L’obiettivo è quello di sviluppare, in circa cinque anni, visori che consentano ai piloti di blindati la guida in battaglia disponendo direttamente sul casco dei dati relativi allo stato del proprio mezzo, la posizione e la mappa dell’area dell’operazione oltre a informazioni “netcentriche” sulla posizione dei propri alleati e dei nemici in tempo reale.
Anche sul versante della fanteria sono in fase di sviluppo e valutazione una serie di “occhiali” per la realtà aumentata, come gli ULTRA-Vis della Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) americana. Concepiti per le forze speciali, questi visori forniranno agli operatori mappe, rotte, allerte e posizione di alleati e nemici rilevati non visibili ad occhio nudo.
Sempre la DARPA due anni fa ha iniziato a finanziare la ricerca dell’azienda Innovega per lo sviluppo di lenti a contatto, le iOptik, con funzioni da HUD e con messa a fuoco automatica anche per la visione periferica.
CONCLUSIONI – Le tecnologie legate alla realtà virtuale e quella aumentata costituiscono delle risorse di estremo interesse per il settore militare. Mentre la prima consente di svolgere simulazioni verosimili – malgrado i limiti mostrati per i velivoli – abbattendo i costi dell’addestramento e delle esercitazioni, la seconda potrà fornire un vantaggio tattico vitale sul campo di battaglia. La vulnerabilità delle nuove strumentazioni AR, però, è evidente per i sistemi progettati per la fanteria. In questo caso i punti deboli principali sono la durata delle batterie e la possibilità del disturbo elettronico per i dispositivi che prevedono la ricezione e lo scambio netcentrico di dati. La validità di questi equipaggiamenti di fanteria è tutta da dimostrare ma le premesse fanno presagire una imminente rivoluzione sul campo di battaglia che comporterà una discriminate di non poco conto tra le forze militari in possesso di queste tecnologie e quelle ancora “tradizionali”.
Francesco Tucci
https://www.youtube.com/watch?v=4eCeuq36zHo
UE: Verso una nuova Commissione
Al via oggi il Consiglio Europeo. Dopo una prima fase nella cittadina belga di Ypres, il consesso si riunirà come di consueto a Bruxelles.
All’ordine del giorno un faccia a faccia su questioni riguardanti Spazio, libertà, giustizia, clima e soprattutto lavoro, crescita e occupazione; tematiche, quest’ultime, strettamente correlate alla composizione della futura Commissione. Potrebbe essere il giorno della consacrazione per Jean Claude Juncker. Facciamo luce sullo stato dell’ istituzione alla vigilia del summit
COMMISSIONE – Sembra fatta per Jean Claude Juncker, candidato alla nomina di presidente della commissione europea. L’ex Primo Ministro lussemburghese ha acquistato consensi anche tra le file socialiste, le quali -tramontata l’ipotesi Schulz, con ogni probabilità destinato a succedere a se stesso alle briglie del Parlamento Europeo- fanno sapere di voler rispettare l’esito elettorale dello scorso 25 maggio, dal quale i popolari sono usciti vittoriosi con un risicato 29,43% dei voti. Attualmente, i 422 seggi, frutto della somma di socialisti e popolari tra gli spalti di Strasburgo, assicurano a Juncker quella maggioranza dei membri necessaria all’ottenimento della nomina.
Un’alleanza prospettica tra popolari e socialisti pare quindi improcrastinabile. Tuttavia, in rottura con la tradizione politica, ad essere ambigui non sono le leadership europee, quanto i trattati. Il comma 7 dell’articolo 17 TUE lascia spazio a molteplici interpretazioni; per sopperire al deficit democratico di cui l’Unione è per definizione portatrice sana, con l’avvento del Trattato di Lisbona, l’individuazione, nonché la scelta di un candidato alla nomina di presidente della Commissione spetta ad una chimerica collaborazione tra Consiglio europeo e Parlamento Europeo.
NOMINA: COME FUNZIONA – Nello specifico è discrezione del Consiglio Europeo “tenere conto” del risultato elettorale. Ammesso che il Consiglio Europeo decida in maniera del tutto anacronistica di rispettare il voto popolare, il soggetto della delibera interna sarebbe proprio il democristiano Juncker. Per ottenere la candidatura alla nomina di presidente della Commissione, tuttavia, è necessario ottenere la maggioranza qualificata dei voti espressi dai capi di Stato e di governo dei 28. Per fortuna di Juncker i trattati, in sostanza gli stati firmatari, hanno fatto proprio un principio sintetizzabile con le parole del sociologo tedesco Ulrich Beck: “L’unanimità non funziona a tavola, figuriamoci in politica”. Dotandosi del principio maggioritario i paesi membri hanno scacciato lo spettro della sedia vuota, relegando il veto ad affare del passato. A poggiare la corona sul capo sarà il Parlamento Europeo il quale si esprime sul candidato a maggioranza dei membri che lo compongono.

IL DEFICIT DEMOCRATICO SI ALLARGA O SI RESTRINGE? – Diversamente, la mancata nomina del lussemburghese, allargherebbe la faglia che divide i cittadini e le élites. Ben inteso, l’affetto nei confronti di Juncker è pressoché inesistente. È improbabile una mobilitazione in suo favore nel caso in cui il Consiglio Europeo ne avallasse la candidatura. A tal riguardo il torto non sarebbe nei confronti del redivivo Juncker, che frequenta le vie di Bruxelles da oltre 25 anni, quanto verso coloro i quali, per trattato “cittadini europei”, hanno, presumibilmente, votato con la consapevolezza che per incidere sull’avvenire democratico di questa Europa non sia necessario essere membri di un generico Club del Coccodrillo.
A tener banco sono le “contropartite”. La candidatura di Juncker comprometterà ai popolari l’accesso a portafogli nevralgici della commissione, come gli esteri, nelle vesti dell’Alto Rappresentante. Lungi dal ritenere colui che succederà a Barroso il direttore d’orchestra di una comitiva fidelizzata dalle grandi famiglie politiche europee, non vi è dubbio che più di altre questa Commissione gioverà, o soffrirà, di una complessa e imperscrutabile discendenza democratica. Sebbene i partiti usciti malconci dalla tornata elettorale si stiano adoperando nella “ricerca di uffici”, è prerogativa delle leadership politiche la costruzione di una Commissione che sappia prescindere da logiche di potere strettamente interne al Consiglio Europeo. Ciò riflette quanto la candidatura di Junker da parte del Consiglio Europeo significhi legittimare il processo di nomine dei candidati Commissari nel rispettodegli esiti elettorali.
Daniele Morritti