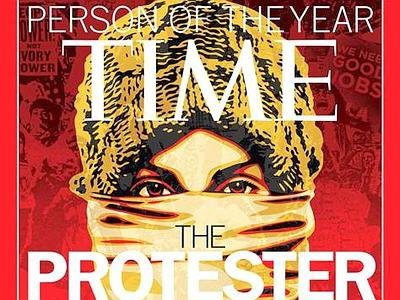Una storia che si ripete? Dopo l’Italia, è la Spagna a vedersi negata dal Brasile l’estradizione per un presunto terrorista dell’ETA, accusato di aver compiuto due attentati alla fine degli anni ’80. I due casi, tuttavia, sembrano diversi. Come diversa sembra essere l’attitudine di Dilma Rousseff nei confronti delle estradizioni rispetto al suo predecessore Lula. Vediamo come
ORA TOCCA ALLA SPAGNA – Dopo il caso Battisti, la storia sembra ripetersi. Nelle scorse settimane il Brasile ha negato l’estradizione alla Spagna di Joseba Gotzón Vizán, presunto terrorista basco affiliato all’ETA, che da oltre vent’anni si nascondeva sotto falso nome nella nazione sudamericana. Sotto accusa per avere partecipato a due attentati compiuti nel 1988 contro due agenti della polizia spagnola, che però non rimasero uccisi, l’etarra (questo il nome dei membri dell’ETA) Gotzón Vizán era quindi fuggito dapprima in Messico e in un secondo momento in Brasile dove, con l’alias di Aitor Julián Arechaga Echevarría, viveva a Rio de Janeiro impartendo lezioni di spagnolo. Appresa la notizia del mandato di cattura internazionale, i legali di Gotzón Vizán hanno invocato il diritto di asilo come rifugiato politico. L’ex indipendentista basco si trova ora in carcere in Brasile, dove le autorità giudiziarie hanno bloccato il procedimento di estradizione per esaminare la richiesta di asilo.
DUE CASI DIVERSI – Il caso ha suscitato interesse in Spagna, dove il terrorismo basco è stato una ferita aperta fino a pochi anni fa. In Italia è passato pressoché sotto silenzio, ma non può non indurre a un paragone con la vicenda di Cesare Battisti, il terrorista la cui estradizione è stata negata dalle autorità brasiliane adducendo il pretesto che, nelle carceri italiane, avrebbe potuto subire delle persecuzioni per le sue idee politiche. Le due vicende sono effettivamente simili e toccano dei nervi ancora scoperti della storia – relativamente ancora recente – di Italia e Spagna dove il terrorismo, di estrema destra e sinistra nel primo caso, di matrice autonomista nel secondo, ha rappresentato forse la pagina più buia della storia repubblicana di questi due Paesi. Non si possono però trascurare alcune differenze sostanziali. Innanzitutto, il processo dell’etarra basco non è ancora stato effettuato e dunque, fino al raggiungimento di una sentenza, Gotzón Vizán non può essere ritenuto colpevole. Battisti, al contrario, era stato giudicato colpevole in via definitiva per l’omicidio di quattro persone. Seconda differenza: mentre nel caso spagnolo non ci sono morti e le motivazioni, seppure esecrabili, possono essere ricondotte a motivazioni “politiche”, tra le vittime di Battisti ci furono anche un macellaio e un gioielliere non riconducibili a particolari appartenenze ideologiche o politiche.
DILMA E LULA – L’esa me della richiesta di asilo politico da parte delle autorità brasiliane può dunque essere considerato in questa fase legittimo. Inoltre, il Gover no presieduto da Dilma Rousseff sembra avere adottato una politica meno incline a favorire i criminali che hanno trovato rifugio sulle calde spiagge brasiliane. L’anno scorso il Ministero della Giustizia ha prodotto una sorta di “manuale di estradizione” con il chiaro intento di evitare altri “casi Battisti”. Il Brasile ha anche firmato nel 2011 un accordo per disciplinare l’estradizione con altri 25 Paesi, tra cui l’Italia, che pochi mesi fa si è vista concedere il rimpatrio di Paolo Santigli, condannato in via definitiva per traffico internazionale di droga. E allora perché Battisti non torna in Italia? Semplicemente perché gli accordi e le nuove norme non hanno valore retroattivo.
me della richiesta di asilo politico da parte delle autorità brasiliane può dunque essere considerato in questa fase legittimo. Inoltre, il Gover no presieduto da Dilma Rousseff sembra avere adottato una politica meno incline a favorire i criminali che hanno trovato rifugio sulle calde spiagge brasiliane. L’anno scorso il Ministero della Giustizia ha prodotto una sorta di “manuale di estradizione” con il chiaro intento di evitare altri “casi Battisti”. Il Brasile ha anche firmato nel 2011 un accordo per disciplinare l’estradizione con altri 25 Paesi, tra cui l’Italia, che pochi mesi fa si è vista concedere il rimpatrio di Paolo Santigli, condannato in via definitiva per traffico internazionale di droga. E allora perché Battisti non torna in Italia? Semplicemente perché gli accordi e le nuove norme non hanno valore retroattivo.
FERITE APERTE – Sembra dunque difficile accusare Dilma Rousseff di simpatizzare per criminali politici, come invece era accaduto per il ministro della Giustizia durante la presidenza Lula, Tarso Genro. Va però sottolineato un fatto: il Brasile ha trascorso circa venti anni della sua storia (dal 1964 al 1985) sotto un regime militare e la stessa Dilma ha trascorso un periodo in carcere come oppositore politico. La sensibilità dei politici brasiliani, e più in genere sudamericani, nei confronti delle dittature che hanno dovuto subire nel recente passato è ancora decisamente alta e questo serve a spiegare in parte la differenza di vedute sorta con alcuni Paesi europei, come l’Italia. Dittature e terrorismo politico sono dunque due ferite ancora aperte nelle società sudamericane e in quella italiana. Il Governo Lula ha istituito nel 2010 una “Commissione per la Verità”per fare piena luce sulle violazioni dei diritti umani avvenute negli anni della dittatura, mentre in Argentina si è recentemente pervenuti alla condanna di Jorge Videla e Reynaldo Bignone, responsabili della morte di migliaia di desaparecidos. Una lezione anche per l’Italia, per fare piena chiarezza sulle responsabilità di tante tragedie avvenute negli “anni di Piombo” e rimaste ancora senza un colpevole?
Davide Tentori