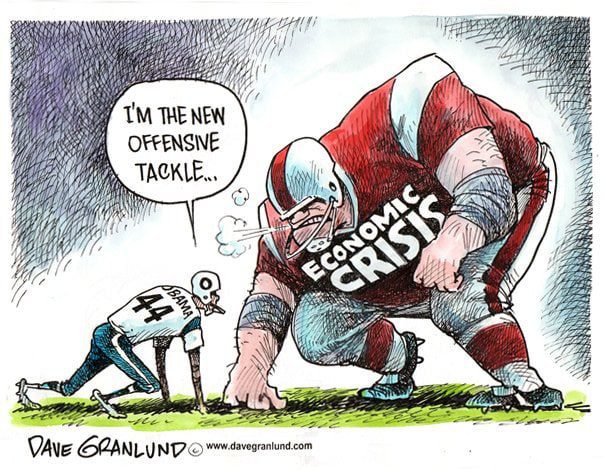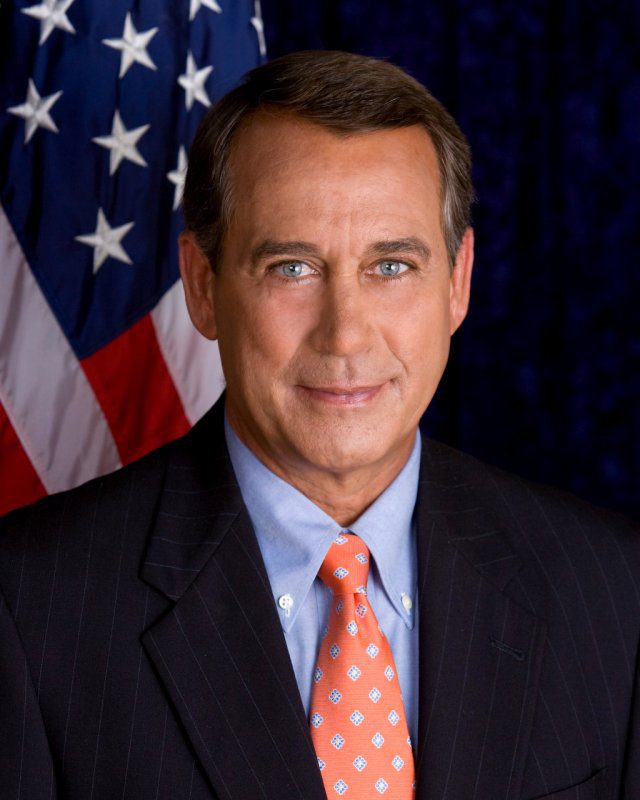Il Giro del Mondo in 30 Caffè – L’Africa, le sue città, la guerra, l'energia: una panoramica trasversale sul continente africano, che seppur ancora tra mille contraddizioni e problemi, si sta lentamente affrancando dalla morsa del sottosviluppo. Vediamo quali potenzialità potrebbero emergere con forza nel decennio appena iniziato
QUALCOSA STA CAMBIANDO – Qualcosa di potente si sta muovendo sotto la pelle dell’Africa. Mentre la scena, dall’Egitto alla Nigeria, dalla Costa d’Avorio al Sudan, è attraversata da nuovi tumulti per il pane e da tensioni di guerra civile, da spaventosi attentati terroristici, si possono osservare movimenti più profondi e possenti, destinati a cambiare volto al continente dimenticato, integrandolo finalmente nelle grandi correnti dell’economia globale.
In questa soglia di 2011 vediamo chiaramente due tendenze nuove, sull’energia (che da semplice riserva dell’Occidente si fa expertise e industria capace di produrre valore aggiunto, competere con le multinazionali, e alimentare il decollo economico e sociale del continente) e sulla demografia, con la potente spinta all’urbanizzazione – e una vecchia malattia, la guerra endemica.
ENERGIA – Il primo dato da cui partire è dunque la forte tendenza, attesa da qui ai prossimi decenni, a un continuo incremento nella domanda di energia. Un fenomeno che, come la spinta all’urbanizzazione, coinvolgerà l’intera Africa, sia quella mediterranea che la parte subsahariana. E’ un dato grezzo, ma confermato da diversi osservatori (in particolare l’Eia, l’agenzia statunitense per l’energia, “vede” un incremento cumulativo del 65% tra 2007 e 2035) e dalle mosse dei grandi operatori del settore (la Trafigura, uno dei principali trader di carburanti e metalli a livello mondiale, che nell’autunno scorso acquisisce da Bp la rete di distribuzione su un’ampia parte dell’Africa australe), e può significare scenari ben diversi:
– l’aumento della domanda risponderà semplicemente a uno sviluppo demografico inarrestabile, caotico, incontrollabile. Tra guerre civili e migrazioni bibliche nessuno sviluppo sociale o economico si profila all’orizzonte (ipotesi pessimista);
– l’Africa ha imboccato un sentiero di sviluppo economico, energia crescente dovrà alimentare un settore industriale in rapida espansione e diversificazione – e i consumi di una nuova società, urbana e segnata dall’impetuoso sviluppo della classe media (ipotesi ottimista);
– Come ogni economia fondata sull’esportazione di idrocarburi, il continente africano evolve verso un assetto export land model, già evidente per gli emirati del Golfo e la stessa Arabia Saudita: urbanizzazione e consumi crescenti di una società energeticamente inefficiente e parassitaria, incapace di sviluppare settori dell’economia diversi dall’estrattivo (ipotesi problematica).
Esistono i semi per ciascuno dei tre sviluppi. La crescita della popolazione sarà particolarmente intensa in Africa, negli anni a venire: gran parte delle società africane, tutte situate nella parte subsahariana, sono ancora alle prime fasi della transizione demografica, quella che contempla altissimi tassi di natalità e di mortalità infantile, e un’aspettativa di vita molto bassa. Dei primi venti paesi al mondo per tasso di fecondità totale (numero di figli per donna) diciotto appartengono all’Africa subsahariana.
Naturalmente la transizione è in corso, ma si preannuncia lenta: secondo le previsioni del francese Institut national d’études démographiques il tasso di fecondità in quella vasta parte del continente impiegherà ancora 35-40 anni per assestarsi intorno al 2,5. Nel 2050 dunque la popolazione dell’Africa sarà raddoppiata rispetto al miliardo di oggi, ma, soprattutto, ciò significa – ancora per diversi decenni – profili della popolazione per classi di età tipicamente a piramide, i più gravosi per sostenere politiche di sviluppo, perché la quota di popolazione attiva è minoritaria e non può fare fronte a un adeguato investimento in scolarizzazione.
Eppure, se anche l’incremento nel consumo di energia (e materie prime) dovesse servire solo ad assecondare lo sviluppo demografico, sarebbe probabilmente una buona notizia. Lo sfruttamento delle risorse energetiche del continente ha, pur nella varietà di situazioni, in gran parte natura predatoria. Si può trattare di regimi profondamente corrotti e autoritari, come in Libia Algeria ed Egitto, o di élites guerriere che hanno tutto l’interesse a tenere vivi conflitti esplosi per le più svariate cause (religiose, etniche, economiche, puramente imperiali..) solo per poter mantenere indisturbate una presa incondizionata e opaca sulle risorse del sottosuolo, o di regimi che hanno lasciato campo libero a uno sfruttamento devastante, quasi apocalittico del territorio da parte delle oil companies dell’Occidente (ma non più soltanto dell’Occidente), come nel Delta del Niger. L’export è il canale per monetizzare quello sfruttamento spietato, il trattenere più risorse a favore del consumo interno rappresenterebbe comunque un interrompersi del circuito perverso, un suo allentarsi.
URBANIZZAZIONE – Possono essere le città, le nuove vaste aree metropolitane che il continente incuba nel buio ancora denso delle foto satellitari, i motori di questo riassetto interno alle società africane, capaci di imporre una nuova distribuzione dell’energia, e del potere. Perché indubbiamente le città di energia ne consumano molta, ma forse possono essere molto di più: centraline di un nuovo modello di sviluppo, della industrializzazione del continente. E’ cambiato l’atteggiamento con cui gli analisti osservano lo sviluppo urbano in Africa – fino a pochi anni fa nel fenomeno si vedevano solo i semi di prossime crisi o catastrofi, di tensioni sociali ed emarginazione estreme, di una vulnerabilità accentuata agli scompensi climatici, di una accessibilità ancora più problematica delle infrastrutture idriche e sanitarie in condizioni di estrema densità di popolazione. Queste condizioni critiche permangono e continuano a preoccupare, è bene ricordarlo, ma ora si comincia a vedere anche altro.
Il movimento all’urbanizzazione è imponente, l’Africa è il continente che era rimasto più arretrato ed è ora quello dove il mutamento sarà più rapido e intenso: la dimensione della popolazione urbana triplicherà nel periodo fino al 2050, quando ammonterà a 1.2 miliardi di persone, il 60% degli africani (si raggiungerà la metà nel 2040).
L’insediamento avverrà inevitabilmente in maniera caotica, e su territori marginali, come pendenza scoscese o pianure alluvionali, e soprattutto in aree costiere minacciate dall’innalzamento delle acque (si pensi soltanto a cosa potrebbe essere del Cairo, o della immensa megalopoli che sta diventando il tratto di costa da Accra al delta del Niger – con i suoi cinquanta milioni di abitanti previsti entro il 2020 – nel caso di un aumento di un metro, possibile entro il secolo). Eppure si è riusciti nello sforzo di ridurre drasticamente la popolazione delle bidonvilles, in questi dieci anni – soprattutto nella regione mediterranea, dove si è avuto quasi un dimezzamento. Sotto il Sahara il progresso è stato sensibile, ma ben più lento (migliori risultati in Ghana, Senegal, Uganda, ma anche in Sudafrica e Nigeria).
Soprattutto dà speranza un dato qualitativo: finalmente (e diversamente da dieci anni fa) si vede nei radar un nesso chiaro e forte tra sviluppo urbano e crescita economica, le regioni più dinamiche sono quelle dove più rapidamente cresce la popolazione delle città. Le città trainano, può essere il segno di una svolta epocale. Soprattutto le vaste aree metropolitane offrono nuove opportunità, con la intensa concentrazione della domanda di merci e servizi, di attività umane e di know how, sviluppano nuovi bisogni, in particolare nella mobilità, accumulano la massa critica delle economie di scala e per la costruzione di decisivi nodi della mobilità: finalmente petrolio, gas e metalli, grazie anche al nuovo rapporto con la Cina (ma anche India e Russia, Brasile, Arabia Saudita entrano decisamente nel gioco) diventano linee ferroviarie, autostrade, aeroporti e metropolitane in grado connettere vaste aree dell’Africa tra loro e con il mondo.
LE POTENZIALITA' – Questo crea le premesse per un possibile sviluppo di attività manifatturiere, la diversificazione dell’economia e il suo affrancamento dalla maledizione delle materie prime. Sì è ancora molto indietro su questa strada, eppure si vedono chiari i primi passi: nel dato grezzo di una intensa crescita economica, attuale e attesa (nei prossimi decenni l’Africa sarà davanti all’Asia orientale, nei tassi di sviluppo), vediamo paesi che non hanno un importante export estrattivo svilupparsi a tassi analoghi alle altre economie. E’ inoltre atteso un boom della classe media, e relativa espansione del mercato interno. Nello stesso settore petrolifero parte dell’Africa (Sonangol in Angola, Oando in Nigeria) comincia a prendere in mano la propria fortuna, sviluppare industrie autonome dotate di tecnologie ed expertise in grado di rivaleggiare con le compagnie multinazionali anche su mercati esteri difficili e problematici, come l’Iraq.
Andrea Caternolo [email protected]