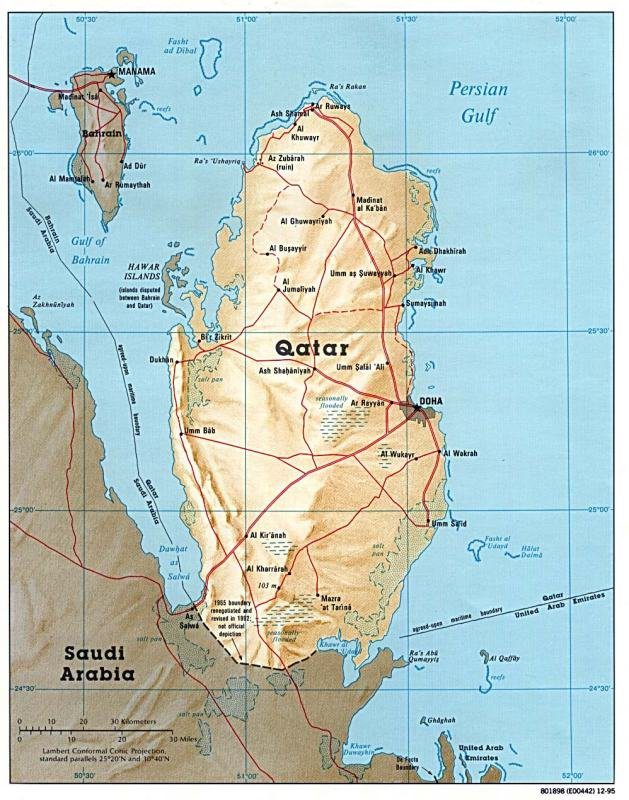Il Giro del Mondo in 30 Caffè – In un clima da guerra civile, il Messico si appresta a vivere l’ennesima campagna elettorale per il prossimo presidente, corsa che, nonostante si concluderà nel luglio 2012, è già cominciata. Il 2011 sarà l’anno della sfida: il rischio è quello di far assistere al Paese una sterile disputa, mentre una delle priorità dei candidati sarà quella di cercare un accordo con i vari cartelli della droga e far terminare la spirale di violenza in cui è caduto il Messico. Intanto l’economia stenta a crescere, la gente si impoverisce e il narcotraffico si sta facendo Stato.
MANIFESTAZIONI PER IL NARCO – In questi ultimi scampoli del 2010 il popolo messicano ha cominciato a sostenere i cartelli del narcotraffico, come è successo, lo scorso 12 dicembre a Apatzingán, un piccolo paesino del Michoacan, stato a 300 km dalla capitale, dove per giorni i militari mandati dal presidente Calderón si erano scontrati con i membri della Familia Michoacana, uno dei grandi cartelli messicani, mettendo a ferro e a fuoco varie città, fino a uccidere, probabilmente, Nazario Moreno González, il cervello ed ideologo della Familia Michoacana. Il giorno dopo l’annuncio della sua morte, il sindaco della cittadina,esponente del PRI, già arrestato l’anno passato per vincoli con il narcotraffico, ha convocato una manifestazione per protestare contro la violenza e i suoi concittadini scendono in piazza inneggiando a Nazario e la sua Familia. La manifestazione si è ripetuta qualche ora dopo nella città di Morelia, la capitale del Michoacan, per chiedere nuovamente pace. Dopotutto non c’è da stupirsi: il cartello dà cibo, lavoro, protezione, onore e riconoscimento, aspetti importanti e che fanno presa nelle fasce medio basse della popolazione. E pace: dove il narcotraffico amministra ci sono giustizia e regole. Il governo federale invece ha spesso abbandonato il territorio, tagliando i fondi per le politiche educative, sociali e lavorative, per destinare le risorse economiche allo spiegamento di migliaia di militari e poliziotti federali che, purtroppo, mentre combattono le forze armate criminali, frequentemente violano i diritti dei civili.
L’ECONOMIA A ROTOLI – L’esecutivo guidato da Felipe Calderón ha trascurato l’importanza di dover strutturare una politica economica di lungo termine per poter uscire dalla crisi: attualmente la disoccupazione è ancora elevata, mentre l'economia sommersa è aumentata rispetto all'inizio della crisi. È cresciuta l’apertura di imprese individuali, spesso però da parte di persone che avevano perso il lavoro, quindi più per disperazione che per reali esigenze di mercato, fattore che inevitabilmente porterà al fallimento. A tutto ciò si aggiunge la grave situazione di insicurezza causata dalla militarizzazione del territorio per la guerra al narcotraffico dichiarata dal governo di Calderón, che negli ultimi 4 anni ha provocato 35 mila morti ufficiali, migliaia di “desaparecidos”, oltre che innumerevoli vittime di violenze. Il ritrovamento, avvenuto l’8 gennaio ad Acapulco, di quindici cadaveri decapitati, è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di omicidi, prodotto della guerra tra i vari cartelli della droga. Negli ultimi mesi, la sicurezza nel paese è andata sempre peggiorando, con rapimenti, omicidi di sindaci, poliziotti e membri del cartello della droga, e la violenza si sta espandendo dalle aree centro – settentrionali, come Nuevo León, a quelle più centrali, come Michoacán e addirittura Monterrey e la stessa Città del Messico, causando un clima di terrore diffuso in cui la gente tende a rimanere in casa. Nelle città del Nord, vicino alla frontiera con gli Stati Uniti, la maggior parte delle imprese segnala cali nelle vendite (solo a Tijuana sono l'81%) e moltissimi negozi sono costretti a chiudere a causa della violenza (solo a Ciudad Juárez più della metà degli esercenti ha chiuso nell’ultimo anno). Quindi non sorprende come nel 2011 si preveda che la crescita economica continuerà ad essere inferiore agli altri paesi latinoamericani, anche a causa della grande dipendenza dell’economia messicana da quella degli Stati Uniti grazie al NAFTA; inoltre in questi giorni è aumentato del 50% il prezzo della tortilla, l’alimento basico di tutti i messicani, mettendo un ulteriore freno alle loro possibilità di spesa di quasi 100 milioni di cittadini. Infine, secondo alcuni analisti economici, il prossimo anno, il Messico potrà essere un altro paese oggetto di speculazione internazionale dato che il debito esterno delle società private nel 2010 ha raggiunto un livello record, pari a US$ 68.106 milioni, soprattutto in caso di ulteriore deprezzamento del peso.
CEVALLOS CANDIDATO? – Offuscati da questa guerra, gli iscritti al PAN (Partido de Acción Nacional), attualmente al Governo, sembrano aver scelto di non combattere per riottenere la presidenza, dedicandosi alla lotta di successione interna e alla spartizione dei guadagni: i principali successori di Calderón, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, l’ex ministro per l’attuazione del programma, e César Nava, ex presidente del partito, sono stati estromessi dalle loro cariche dallo stesso Calderón, che sembra volersi ritagliare un posto nel partito, una volta dimessi i panni del Presidente della Repubblica. L’unico che può mettere ordine e ricompattare il partito è Diego Fernando de Cevallos, vecchio patriarca panista che, appena liberato dopo 4 mesi di sequestro da un gruppo narcotrafficante non identificato, ha cominciato a parlare alla nazione, lodando il suo presidente e ricordando che la guerra al narcotraffico continuerà.
IL VECCHIO PRI – Per ora invece, la battaglia presidenziale ha sicuramente due contendenti. Da una parte Peña Nieto, giovane e bel governatore del PRI (Partido Revolucionario Institucional) del popoloso Estado de México, la enorme periferia urbana di Città del Messico, che ha basato la sua esperienza come amministratore sulla costruzione di infrastrutture, come aeroporti e autostrade, dimostrando uno scarso rispetto dei diritti umani e delle effettive volontà della gente, permettendo, per esempio, la repressione dei contadini di San Salvador Atenco che protestavano contro la costruzione del nuovo aeroporto sulle loro terre. Discendente di politici di professione, sembra essere ben consapevole del fatto che il suo mandato dura solo 6 anni e deve farlo fruttare, rimanendo inerte con i gruppi industriali più influenti del paese. Nella sua regione ha concesso ai grandi costruttori appalti redditizi, anche se alcuni inutili, per la costruzione di centinaia di km di autostrade, attraverso uno schema di finanziamento pubblico e privato per il quale se l’edile non riesce a concludere l’opera nei tempi stabiliti nel contratto, lo Stato gli paga la mora: non è un caso che nel 2011 l’evento per costruttori di autostrade più importante del mondo si svolga in Messico. Durante gli scorsi anni si è accordato con Televisa, la principale catena televisiva messicana, per ottenere quello spazio mediatico che gli ha permesso di essere tra i politici più conosciuti del paese. Ultimamente si è fatto notare per avere ufficialmente aperto la campagna elettorale per il 2012, con la “Ley Peña” che appunto porta il suo nome, con la quale ha legalmente proibito, con la legittimazione della Suprema Corte di Giustizia, le alleanze tra partiti prima delle elezioni, per poter mettere un freno, alla strategia PAN – PRD che ha portato nel luglio scorso a battere il PRI in varie roccaforti.
LA NUOVA SINISTRA – Dall’altra parte, c’è il campione della sinistra, Marcelo Ebrard, che se vincerà le resistenze di López Obrador, il candidato del PRD nel 2006 che fu probabilmente scippato della vittoria elettorale dal Presidente in carica, potrà presentarsi agli elettori come un liberale di sinistra che ha amministrato la più grande città al mondo. Anche lui amante delle infrastrutture costruite senza consultare nessuno, si è distinto per fare di Città del Messico la capitale più progressista di tutta l’America Latina: ha fatto approvare il diritto ad abortire per le donne nei primi 3 mesi di gravidanza e il diritto a sposarsi ed a adottare figli per le coppie omosessuali, inimicandosi la Chiesa cattolica; sta rivoluzionando la viabilità della città, costruendo strade preferenziali per filobus elettrici e biciclette, che sul modello delle città europee possono essere affittate per un modico prezzo, meritandosi il premio come “miglior sindaco verde” nel mondo; ha continuato la pulizia del centro storico, scacciando gli ambulanti che affollavano le sue strade, in appoggio a Carlos Slim, l’uomo più ricco del mondo nel 2009, che ha comprato diversi palazzi del centro. Per ultimo, ha riabilitato il vecchio motto romano “panem et circenses”, offrendo spettacoli gratuiti a tutte le ore in diverse parti della città, con i simboli del PRD che campeggiano fluorescenti, e mandando i suoi “angel”, assistenti sociali a gettone, nelle zone più arretrate.
LA CONTESA ELETTORALE – Basteranno queste azioni per farlo vincere a livello nazionale? I commentatori più esperti, puntano indubbiamente su Peña: troppo forte la macchina di Televisa per scalzare il suo campione, che intelligentemente ha messo le mani avanti aprendo la strada al divieto di raccogliere sotto il nome di Ebrard tutto l’arco costituzionale partitocratrico messicano. Probabilmente però il principale attore in questa campagna elettorale lunghissima saranno i cartelli mafiosi: accetteranno un presidente che pare esterno alle dinamiche criminali? Oppure opteranno per il candidato più malleabile? Forse li lasceranno sfiancarsi mentre cercano di allargare il loro potere sul territorio, inasprendo la guerra e facendo proseliti, sempre utili nella negoziazione politica, in attesa di poter presentare un loro uomo.

COLOMBIZZAZIONE? –Nel 2011 il cartello di Sinaloa, alleandosi con gli Zetas, il gruppo narco mercenario, sparso in tutto il paese che accetterà la migliore offerta economica, consoliderà il proprio dominio nel nord ovest del paese, lanciandosi all’offensiva della Familia Michoacana, detentrice del centro ovest, e del Cartello del Golfo, che ha il primato nel nord est, i quali non potranno che aumentare la loro potenza di fuoco, cercando quel sostegno istituzionale che per ora sembra prerogativa del Chapo. La efferatezza di questa lotta attirerà sempre più gli occhi internazionali, Stati Uniti in primis, che non possono permettersi un vicino tanto rissoso e che cercheranno di spingere Calderón ad accettare aiuti militari ed economici per mettere fine alla supremazia mafiosa, sperando di non causare una ulteriore recrudescenza della situazione, che ricorda terribilmente il baratro in cui finì la Colombia negli anni ‘90. Arriveranno le bombe nei centri commerciali e le mattanze nei quartieri turistici, per dettare le condizioni dell’accordo politico? La potenza di fuoco mafiosa ha già fatto vedere di cosa è capace durante quest’anno, quando ha cominciato a far esplodere autobombe, sparare granate e lanciare molotov.
Andrea Cerami (da Città del Messico)
[email protected]