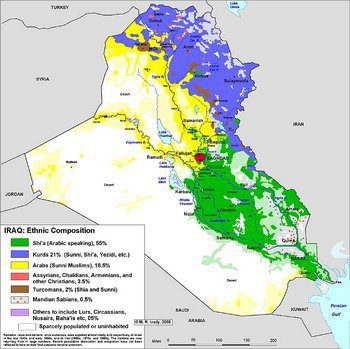Il Venezuela, al contrario degli altri Stati sudamericani, sta entrando in una seria crisi economica, mentre le libertà individuali si stanno assottigliando sempre più. Per Chávez si preannuncia un difficile 2010
IL POTERE LOGORA… – ma è meglio non perderlo, recita un detto. E il proverbio potrebbe descrivere la situazione in cui si sta trovando Hugo Chàvez, presidente del Venezuela: dopo un decennio alla guida dello Stato sudamericano (fu eletto per la prima volta nel 1999), si cominciano a intravvedere i primi segnali di difficoltà. Ma, proprio perché “l’appetito vien mangiando”, il leader di Caracas non sembra affatto disposto ad abbandonare il potere e i fatti accaduti negli ultimi mesi dimostrano come il suo governo si caratterizzi per tratti sempre più autoritari.
CRISI ECONOMICA – Il Venezuela è una delle principali potenze petrolifere mondiali. Unico membro americano dell’OPEC, il cartello che riunisce alcuni tra i principali Stati produttori di idrocarburi al mondo, ha fatto dell’estrazione del greggio il principale sostentamento della propria economia. Hugo Chávez ha potuto beneficiare del periodo più florido per l’estrazione, ovvero questo primo decennio degli anni Duemila, durante il quale i prezzi delle materie prime sui mercati internazionali hanno raggiunto livelli altissimi. Anziché approfittare della “bonanza” derivante dalle esportazioni di petrolio per diversificare le attività produttive, però, Chávez ha trasformato il Venezuela in un Paese quasi interamente dipendente dall’ “oro nero”. Dopo anni caratterizzati da alti tassi di crescita economica, in seguito alla crisi economica il 2009 si chiuderà per la prima volta dopo molto tempo con una recessione. Le ultime statistiche rese pubbliche dalla Banca Centrale venezuelana rivelano che nel terzo trimestre dell’anno il PIL ha subito una flessione del 4,5%; nel primo trimestre era salito dello 0,3% e nel secondo calato del 2,4%. Il motivo? Essenzialmente dovuto al brusco calo del prezzo del petrolio e alla minore produzione, una scelta concordata a livello OPEC per evitare abbassamenti del prezzo ancora maggiori attraverso una contrazione dell’offerta. Non va dimenticato, inoltre, che il petrolio venezuelano è “pesante”, ovvero ha una composizione chimica tale per cui la sua raffinazione è più complessa e costosa rispetto a petroli “leggeri” come, ad esempio, quello scoperto di recente al largo delle coste brasiliane. Un altro punto che rischia di mettere in ginocchio il sistema economico venezuelano è l’inflazione, tra le più alte al mondo: nel 2008 l’aumento dei prezzi è stato del 31,4%, con punte del 46,7% per i prodotti alimentari. E le prospettive per quest’anno sembrano ancora peggiori, dato che il blocco dei rapporti commerciali con la Colombia ha reso il Venezuela ancora più dipendente dalle importazioni di cibo e prodotti agricoli. Inoltre, il Governo è stato costretto ad operare in alcuni casi un razionamento della fornitura di acqua ed energia elettrica.

TUTTO SOTTO CONTROLLO? – Nonostante questa situazione, Hugo Chávez ha negato di essere in difficoltà e anzi ha criticato la veridicità delle statistiche macroeconomiche pubblicate. Secondo il caudillo di Caracas, lo sviluppo di una nazione non può essere misurato solo in base a indicatori “tipicamente capitalisti” come il PIL. Vero, ma Chávez dovrebbe considerare che anche per quanto riguarda indicatori di stampo meno “freddamente” e più sociali il Venezuela non se la passa troppo bene. I tassi di criminalità sono tra i più alti al mondo e anche il livello di distribuzione del reddito tra la popolazione è particolarmente disomogeneo (il 10% della popolazione più ricca detiene il 32% del reddito nazionale, mentre il 10% più povero solo l’1%). Il benessere di una popolazione dovrebbe essere misurato anche in base al grado di libertà di cui essa gode: tuttavia, nei mesi scorsi il Governo ha varato una legge sulle comunicazioni che potrebbe far chiudere il 40% delle emittenti radiofoniche e ha minacciato di sospendere le trasmissioni di Globovisiòn, televisione che ha un orientamento di opposizione. La diminuzione della libertà di stampa non ha però impedito di portare alla luce i risultati di recenti sondaggi, che rivelano un calo sensibile del consenso dei cittadini attorno a Chàvez, sceso al di sotto del 40%. Un brutto segnale in vista delle elezioni legislative che si terranno l’anno prossimo e che potrebbero mettere il Presidente in minoranza per la prima volta.
RAPPORTI TESI – Anche in campo internazionale il Venezuela sta attraversando un momento critico. Oltre ai forti contrasti con la Colombia (Cfr. “Giocare” alla guerra) la repubblica bolivariana è in attesa di essere ammessa nel Mercosur, l’area di libero scambio che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Il Senato brasiliano, a cui spetta l’ultima parola (o meglio la penultima, visto che anche il Paraguay deve ancora esprimersi) in merito all’ammissione, ha bloccato la procedura di voto per le perplessità legate al rispetto della democrazia in Venezuela. Caracas, nonostante sia già un grande importatore da Argentina e Uruguay di prodotti agricoli, avrebbe da guadagnare entrando nel Mercosur perché i prezzi delle merci si abbasserebbero e l’inflazione potrebbe tornare sotto controllo. Ma finchè Chávez continuerà a seminare zizzania in America Latina e a promuovere progetti di integrazione palesemente contrari al sistema internazionale, difficilmente otterrà una ripresa della propria economia. Mostrare i “muscoli” è servito fino a quando il petrolio ha garantito ricchezza e crescita, ma ora la potenza geopolitica di Caracas rischia di essere paragonabile ad una “tigre di carta”.
Davide Tentori 19 novembre 2009 [email protected]