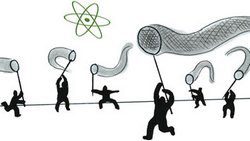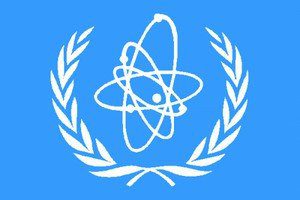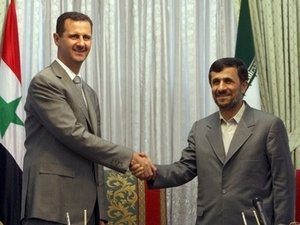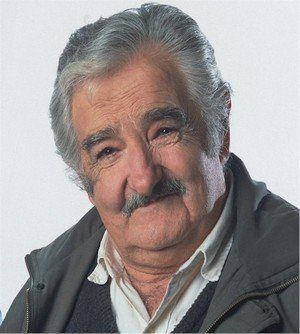Geopoliticamente parlando, uno degli Stati più strategici al mondo. A metà tra l’Oceano Indiano e il Mediterraneo, tra il Corno d’Africa e la penisola arabica, tra sciismo e sunnismo, lo Yemen sta sprofondando nel caos. In silenzio
NEL DIMENTICATOIO – Pochi ne parlano, in Italia praticamente nessuno. Lo Yemen è un Paese sull’orlo del collasso e, si direbbe, sull’orlo di una guerra civile. Si direbbe, perché in realtà già lo è, e non è una novità. Il Paese è profondamente diviso, non in due, ma almeno in tre. Governo autoritatio; separatisti di ispirazione marxista-leninista nel Sud; sciiti zaiditi, seguadi del ribelle Abd al-Malik Al-Houthi, a Nord. Questo è lo Yemen, e non è finita qui. Uno Stato in cui la presenza istituzionale e la sua legittimazione è pressochè nulla. Un Paese in cui, da anni e non da poco tempo, si nascondono alcune delle cellule più pericolose e attive di quella galassia di movimenti terroristici di ispirazione sunnita wahhabita, che per semplificazione va sotto il nome di Al-Qaeda. Un Paese che, complice la fetta di popolazione di fede musulmana sciita che è lì presente, è meta del sostegno logistico e finanziario di un altro grande protagonista del Medio Oriente, che sta tentando da tempo di espandere la propria influenza ai margini del Mediterraneo: l’Iran. Un Paese in cui il fondamentalismo sunnita, dall’altra parte, non è mai stato abbastanza combattuto ed in cui, adesso, si avvertono le conseguenze di anni di politiche a breve, brevissimo termine, senza un reale progetto che mirasse allo sviluppo ed alla stabilizzazione interna.
LE LOTTE INTESTINE – Tutto ciò è oggi lo Yemen, in cui da più di dieci anni, ma con rinnovato vigore da un paio di mesi, si sta combattendo una vera e propria guerra intestina tra il governo e le forze presidenziali di Ali Abdullah Saleh e gli sciiti zaiditi del guerrigliero Al-Houthi dall’altra parte. Parte, quest’ultima, che da sempre subisce le politiche discriminatorie di Sana’a e che, soprattutto per tale motivo, porta avanti una lotta al potere centrale che abbia come obeiettivo il riconoscimento di eguali diritti per tutti i cittadini yemeniti. Se è vero che l’Iran tenta di sfruttare questa presenza sciita nel Golfo meridionale per poter imporre una propria presenza ed influenza nella zona, pare essere altrettanto vero che il governo non fa niente per migliorare la condizione degli sciiti e tentare di conseguenza di calmare gli animi. In un Paese dove i legami personali e tribali contano ancora di più di quelli istituzionali e politici, ecco che la miscela diventa esplosiva. Nelle ultime settimane si sono intensificati gli scontri tra forze governative e sciite, fino al bombardamento di ieri, che ha fatto registrare ben 80 vittime civili in un villaggio del Nord e in un’operazione che in teoria sarebbe stata concepita per sradicare la presenza di al-Houthi e dei suoi seguaci dalla zona settentrionale del Paese.

TRA I DUE LITIGANTI… – In tutta questa grandissima confusione, come spesso accade in queste occasioni, vi è una terza parte che per il momento sembrerebbe raccogliere i frutti della lotta intestina: i fondamentalisti legati ad al-Qaeda. Questi stanno trovando nello Yemen privato di qualsiasi presenza politica ed istituzionale credibile alle proprie periferie, un campo fertile per fare proseliti e per agire indisturbati. Le infiltrazioni da qui verso l’Arabia Saudita (ancora nemico numero 1 di al-Qaeda) e nel resto del mondo arabo (Iraq in primis) comincerebbero a farsi sempre più pressanti ed il governo di Sana’a si tgrova così a dover affrontare anche questa presenza come nuovo nemico interno. Sullo sfondo, una lotta tra Iran e potenze sunnite che si espande sempre più verso le acque del Mar Rosso e del Mediterraneo; la pirateria nel Corno d’Africa che trova sempre più facile agire in luoghi pressochè anarchici ed un Paese arabo, lo Yemen, che rischia di diventare la miccia di nuovi esplosivi confronti in Medio Oriente.