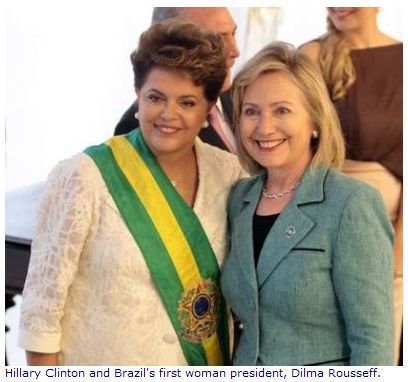Pubblichiamo in esclusiva, in quattro puntate, un documento del Generale Saverio Cascone, che con estrema chiarezza riesce ad illustrare nel suo complesso quanto sta avvenendo in Maghreb e nel Medio Oriente, mostrando i sottili fili rossi che stanno dietro le trame degli eventi di queste settimane. Una lettura imperdibile, per cogliere le dinamiche più profonde dei fatti che stanno cambiando la storia di quelle regioni, e non solo. Dopo una breve panoramica generale, partiamo oggi dalla Tunisia
GENERALITA' – La rivolta del Maghreb, sia “Piccolo Maghreb” (Marocco, Algeria e Tunisia) sia “Grande Maghreb” (i tre Paesi già citati, più Mauritania e Libia), iniziata in Tunisia ed Egitto a dicembre-gennaio scorso, si è propagata con velocità considerevole in Libia ed in altre aree del mondo arabo: la Valle del Nilo (già citato l’Egitto), il Corno d’Africa (Gibuti), il Mashreq (Libano, Giordania), la Penisola arabica (Bahrein, Yemen); si ricorda che Maghreb e Mashreq sono due termini arabi che indicano rispettivamente occidente e oriente; in questo caso, rispetto alla centrale Valle del Nilo.
Come per altre operazioni che coinvolgono la popolazione o un settore di questa, sembra opportuno connotare la rivolta (partecipanti, scopo, mezzi ecc.) e, per un’agevole comprensione e individuazione, anche un’etichettatura: per quanto si è visto finora, a proposito di Tunisia ed Egitto, si parla rispettivamente della “rivolta dei gelsomini” (una pianta che fiorisce d’inverno) e di “rivolta del web” (per il fondamentale ruolo avuto, nella fase organizzativa e nella condotta, dai social network – Twitter, Facebook ecc.); entrambe: una rivolta generazionale, con elemento predominante i giovani – uomini e donne alfabetizzati – contro un regime autocratico, in un contesto caratterizzato da “stato di polizia”, ingiustizia sociale, sistema di privilegi e povertà; regimi durati lunghi anni, le cui cause sono da valutare caso per caso. Tuttavia alcuni quotidiani (“La Repubblica” del 14 febbraio u.s., in particolare) riportano a tale proposito quanto evidenziato dallo storico e demografo francese, Emmanuel Todd, a proposito della longevità dei regimi del mondo musulmano, nel saggio “L’incontro delle civiltà”.
DEMOGRAFIA E ALFABETIZZAZIONE – Secondo lo studioso Todd, nel processo di modernizzazione, lo scoppio delle rivolte segue nel tempo l’alto tasso di alfabetizzazione e il calo delle nascite (è capitato con la Rivoluzione Francese, con il rovesciamento del regime zarista, con la Rivoluzione Cinese). In pratica, superata la soglia di alfabetizzazione del 50% per uomini e donne, è probabile il calo del numero medio dei figli per ciascuna donna. A questo punto, dietro l’angolo c’è la rivolta, perché, spiega Todd, «in una società in cui i figli sanno leggere e scrivere e i padri no, cambiano i rapporti tra uomini e donne; tale società è disorientata!»
Il mondo arabo non fa eccezione, tanto più che in quest’ultimo sussiste un altro fattore demografico importante, l’endogamia, ovvero la quota di matrimoni tra cugini: l’individuo è preso da forti legami familiari che ingenerano una sorta di “blocco politico”: è questa la causa del ritardo nella reazione al regime.
IL RUOLO DELL'OCCIDENTE – L’aspetto demografico non è tutto nel contesto maghrebino; è necessario prendere in considerazione anche gli interessi dei Paesi occidentali sia per l’acquisizione delle risorse energetiche nei Paesi maghrebini (Algeria, Libia ecc.), sia per il controllo e il blocco di fenomeni negativi “in espansione” come l’estremismo islamico, il terrorismo, la criminalità organizzata, il narcotraffico ecc., nel senso che, come contropartita per il loro impegno contro tali fenomeni, si ricorre a stanziamenti di fondi, anche sostanziosi (vedasi l’Egitto da parte degli Stati Uniti), sotto la voce del miglioramento del dispositivo militare e/o della polizia locale.
A questi stanziamenti si aggiungono una certa larghezza di vedute e, per certi aspetti, la tolleranza ai fini del comportamento dei regimi in questione nel settore dei Diritti Umani, come sarà possibile riscontrare, attraverso l’esame della situazione di ciascun Paese.
A tale ultimo proposito, dopo l’esame dei due Paesi maghrebini che hanno già conseguito un risultato tangibile, come avvenuto in Tunisia ed in Egitto (allontanamento dal Paese del “Capo” del regime), saranno presi in considerazione i Paesi che ancora sono alla fase precedente, nel contesto di una possibile schematizzazione delle fasi di una “rivolta” e cioè:
-
la “piazza”, quale luogo di manifestazioni e/o di scontro tra popolazione e forze militari e di polizia, in difesa del regime;
-
il rovesciamento o l’allontanamento spontaneo dal Paese del “dittatore”;
-
il processo di transizione e di normalizzazione.

1.LA TUNISIA E LA RIVOLTA DEI GELSOMINI
CAUSE E CONTESTO – Nel Paese, ritenuto il più stabile dell’area maghrebina, la scintilla parte dal gesto estremo di un giovane ventiseienne che, il 17 dicembre 2010, si cosparge di benzina e si dà fuoco per protesta; Mohamed Bouazizi (così si chiamava), diplomato senza lavoro, sopravviveva vendendo frutta e verdura, sprovvisto di licenza; la polizia gli aveva sequestrato la merce a Sidi Bouzid, una cittadina della Tunisia centrale. L’agonia è durata fino al 4 gennaio 2011; gli amici di Mohamed Bouazizi sono scesi in piazza, dando inizio a una ribellione che si è estesa ad altre località, fino alla Capitale.
La Tunisia, 10 milioni di abitanti a maggioranza sunniti (99%), stando ai parametri demografici dello studioso Emmanuel Todd, presenta un alto tasso di alfabetizzazione (94%) e un tasso di endogamia (matrimonio tra cugini), anche questo elevato (36%), che rendendo molto forti i legami familiari hanno determinato un blocco della situazione politica e ritardato il processo di modernizzazione del Paese, già condizionato dall’autoritarismo del regime tunisino.
In economia, la Tunisia che fruisce del sostegno dei Paesi occidentali, ha realizzato una crescita, nel periodo precedente alla “crisi globale”, di cui non hanno beneficiato i ceti più deboli; da considerare che la Tunisia non sfrutta appieno le proprie capacità, specie nel settore turistico, con un flusso di circa 8 milioni di turisti l’anno.
Con la crisi globale, si sono verificate la contrazione della domanda sui mercati europei che costituivano sbocco principale delle esportazioni tunisine (frumento, orzo, olio di oliva, datteri e agrumi), la riduzione sia del flusso turistico sia delle rimesse dei lavoratori tunisini all’estero.
La crisi economica ha portato all’attenzione anche altri aspetti negativi della gestione del potere:
-
l’assenza di competizione politica nell’apparato statale ( il Raggruppamento Costituzionale Democratico – RCD – costuisce in effetti “partito unico”, data l’inconsistenza degli altri partiti);
-
l’autoritarismo del regime non disgiunto dal controllo di polizia che, insieme alla censura, rendono la Tunisia alquanto simile all’Iran.
Come anticipato, è bastata la scintilla di Sidi Bouzid per portare la Tunisia in piazza, con manifestazioni di proteste e scioperi; la rivolta si connota come rivolta politica, in quanto la piazza chiede il cambio di regime che ha messo in discussione la legittimità del governo.
VIA BEN ALI, COSA RIMANE? – Nonostante la forte repressione, il Presidente Zine el-Abidine Ben Ali è stato costretto il 14 gennaio scorso ad abbandonare il Paese e, rifiutato dalla Francia, ha trovato scampo in Arabia Saudita. Le condizioni di salute dell’ex Presidente tunisino sono attualmente preoccupanti.
Il corso del periodo post-“rivolta dei gelsomini” non sembra privo di ostacoli: un primo governo ad interim non ha ottenuto consenso, in quanto gli esponenti di tre ministeri fondamentali (Difesa, Esteri e Finanze) erano stati assegnati ad esponenti compromessi con il regime di Ben Ali.
La formazione governativa successiva, affidata alla guida di Mohamed Gannouchi (da non confondere con il leader storico dell’opposizione, Rachid: non sono parenti), concede poco spazio agli esponenti del vecchio regime; alleggeriti i rigori del coprifuoco, in vigore dal 12 gennaio e avviata la ripresa di alcune attività commerciali, il processo di democratizzazione sembra avviato attraverso il dialogo tra la compagine governativa e l’Union General Travaglieurs Tunisiens (UGTT). In questa fase di transizione, un ruolo significativo spetta ai militari che negli ultimi anni hanno visto crescere gli organici della Polizia (120 mila effettivi), a scapito delle F.A. (35 mila effettivi), e per di più tenuti “lontani” dai centri di potere.
(1. continua)
Gen. Saverio Cascone (testo raccolto da Chiara Maria Leveque) [email protected]