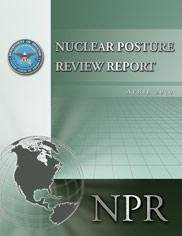Tutti a caccia di energia in Africa. La grandi possibilità di accedere a nuove risorse di energia fossile (petrolio e gas naturale) fanno gola al mondo intero. Tutto questo sfocerà in un ennesimo saccheggio, o vi sono effettive possibilità di sviluppo autonomo e durevole per il Continente nero?
LE RISORSE – L’Africa subsahariana, il continente dimenticato della globalizzazione, torna al centro del Great Game energetico. Le attenzioni di compagnie asiatiche (cinesi, coreane, giapponesi, indiane), brasiliane, russe, occidentali sono per le sue risorse, in gran parte ancora da esplorare, di energia fossile (petrolio e gas naturale). Questa sarebbe apparentemente la solita vecchia storia di sfruttamento, o di vero e proprio saccheggio coloniale, di scambio ineguale. E’ in realtà un intrico ben più complesso, che trama le possibilità di uno sviluppo industriale e umano autonomo per il Continente nero.
CACCIA ALL'ORO NERO – Vi è anzitutto una costellazione di fattori e sviluppi nell’upstream degli idrocarburi (cioè tutto il segmento industriale che va dall’esplorazione e sviluppo di campi petroliferi/gasieri, fino all’estrazione), che si profila come particolarmente favorevole alla posizione dei Paesi produttori dell’Africa. La sete di petrolio e gas brucia forte nelle gole dell’economia globale. Non si tratta solo della conclamata voracità dei giganti asiatici, è anche il drammatico profilarsi di vari peak oil nazionali (ovvero il picco di massima estrazione, oltre il quale si ha la fase di rendimento declinante), da quello britannico a quello messicano, passando per il lungo addio del petrolio statunitense, a spronare le grandi compagnie internazionali e alcuni “campioni nazionali” in questa corsa verso l’Africa. In particolare prezzi più alti significano per le compagnie la possibilità/opportunità di finanziare nuovi progetti di prospezione (tecniche di indagini del territorio) in territori rimasti finora inesplorati, o in ambienti più di frontiera (e dunque più costosi, come l’offshore, l’alto mare). E infatti, benchè l’Africa sia tuttora una regione relativamente poco esplorata dalle compagnìe petrolifere, è stato proprio nell’offshore, nelle acque profonde al largo rispettivamente del Ghana e del Sierra Leone, che si è fatta la scoperta più importante di questi anni. Così promettente da far ben sperare per l’esistenza di una vasta nuova regione petrolifera estesa su tutta la fascia costiera tra i due paesi (nel West African Transform Margin). Il rinascimento petrolifero (ma il gas ha un ruolo in prospettiva forse più importante) apre interessanti prospettive di sviluppo all’Africa, anzitutto sotto due profili.
I PROTAGONISTI – Le scoperte più importanti le stanno realizzando non le grandi compagnie integrate (le IOC) come Shell o Exxon, bensì piccole e medie società come Anandarko e Tullow, grazie alla loro maggior propensione al rischio e superiore agilità di manovra nella scelta dei siti e nell’innovazione tecnica e concettuale (il campo petrolifero Jubilee, al largo del Ghana, è situato in una regione in realtà già esplorata in passato, dove si è deciso di procedere secondo una diversa rappresentazione della geologia dell’area, e con tecnologie nuove). Alcune di queste sono però compagnie locali (sia indipendenti, come la nigeriana Oando, che nazionali – come Sonangol), che hanno raccolto e messo a frutto le competenze, il capitale umano locale creato in anni di sfruttamento delle risorse ad opera delle grandi compagnìe internazionali. Si tratta di realtà industriali solide e dinamiche, capaci di aggiudicarsi licenze anche in paesi esteri, e in grado di rafforzare il potere contrattuale dei rispettivi governi nelle trattative con le majors degli idrocarburi (in quanto alternativa possibile).
Il secondo aspetto strutturale è che l’entrata in scena delle società asiatiche (Cina, India, Giappone, Corea del Sud), brasiliane e russe ha creato un quadro di notevole concorrenza dal lato della domanda, nell’upstream degli idrocarburi; una condizione potenzialmente molto favorevole ai paesi esportatori. In particolare le compagnie asiatiche sono mosse da una domanda energetica, nei rispettivi paesi, esorbitante e in crescita tumultuosa, dispongono di notevoli capacità finanziarie (amplissime nel caso cinese), e rispondono a governi meno propensi (ancora la Cina) a condizionarne la libertà di movimento a vincoli di opportunità politica e inerenti alle relazioni internazionali o agli auspici dell'Onu. Grande attenzione, e grandi speranze nei governi e nei paesi produttori del continente, aveva suscitato la politica di oil for infrastructures inaugurata in Africa dai paesi asiatici circa un decennio fa. Eppure il bilancio risulta essere relativamente magro, e soprattutto contradditorio: ricco e positivo per entrambe le parti in Angola, pressochè nullo e molto travagliato da opzioni saltate e progetti annullati in Nigeria.
L'INTERESSE EUROPEO – Tutto questo deve pur essere considerato nell’ottica degli interessi europei, per cui tutto quanto può produrre sviluppo autonomo e durevole all’Africa, aumentarne l’integrazione economica interna e con l’Unione, ridurne l’emorragia migratoria, è da promuove e sostenere. Non si tratta solo di governare la pressione demografica: lo stabilirsi di un’Eurafrica dell’energia negli idrocarburi può essere il precursore della futura integrazione nel campo delle energie rinnovabili, cui già mirano alcuni progetti comunitari (come Desertec). E’ inoltre interesse generale l’affermarsi del soft power europeo nel continente nero, come moneta buona che può scacciare altre più pericolose egemonie o influenze (come quella russo-nucleare, o – peggio ancora – quella iraniana).
Andrea Caternolo [email protected]