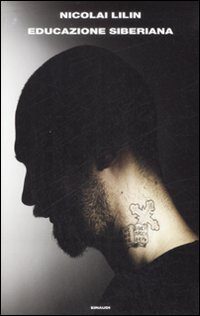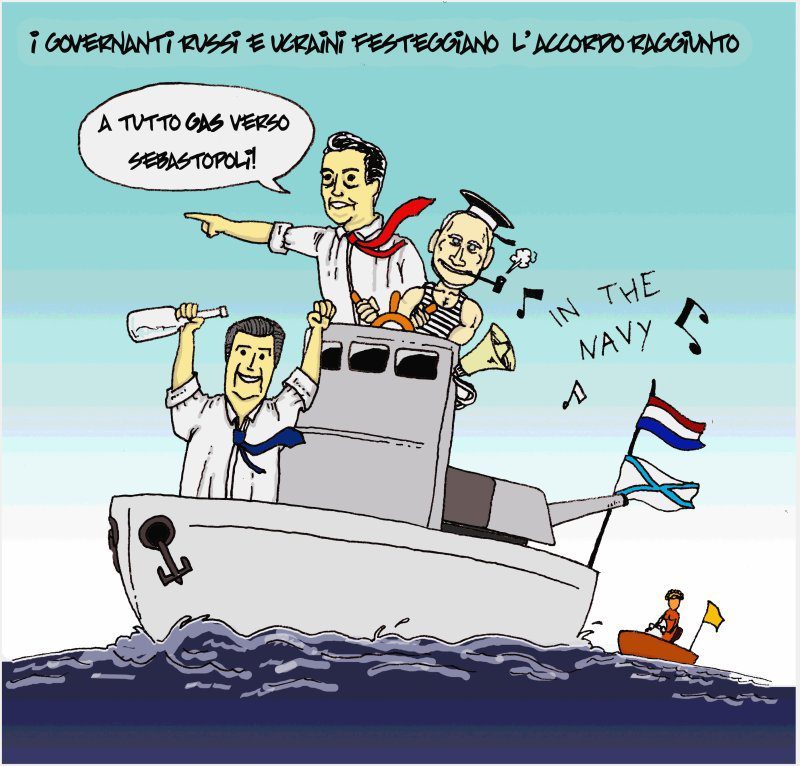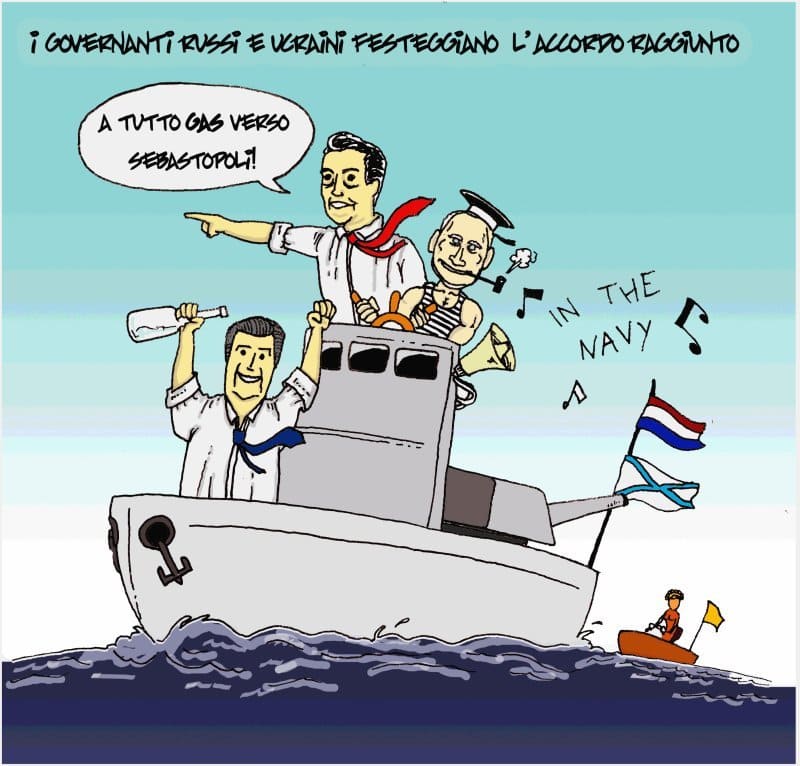A Cochabamba, in Bolivia, si è svolta la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra (CMPCC), fortemente voluta dal presidente boliviano Evo Morales, in seguito al fallimento della Conferenza di Copenaghen dello scorso dicembre. Con un approccio completamente nuovo, che prende spunto dalle richieste delle popolazioni indigene e delle organizzazioni non governative, i paesi hanno affrontato la questione della crisi climatica.
NON SOLO STRANEZZE – Il pollo? Non va mangiato perché gli ormoni femminili con cui i pennuti vengono fatti ingrassare “fa diventare gay”. La Coca Cola? “Buona solo per sturare lavandini”. Che dire insomma dell’alimentazione occidentale, che “nel giro di cinquant’anni farà diventare tutti gli uomini calvi?” Le dichiarazioni “folkloristiche” del presidente indio della Bolivia Evo Morales, in occasione della Conferenza Mondiale dei Popoli sul cambio climatico e i Diritti della Madre Terra, sono senz’altro gli elementi che hanno avuto maggiore risonanza a livello internazionale. Ma l’evento, del quale non si è praticamente parlato nel nostro Paese, non si è per fortuna ridotto a queste discutibili esternazioni.
Nel corso dei tre giorni del vertice, organizzata in risposta al sostanziale fallimento del vertice intergovernativo di Copenaghen, che si è svolto a dicembre 2009, diciassette gruppi di lavoro sulle differenti tematiche hanno elaborato documenti di analisi che sono stati poi presentanti nella conferenza finale. Dall’insieme delle proposte è stata realizzata un’agenda di azione comune e un calendario di priorità per arrivare al prossimo appuntamento sul clima che si terrà a Cancún, in Messico, a fine anno.
Tra i temi discussi nel corso della Conferenza si annoverano la creazione di un Tribunale Internazionale di Giustizia climatica e ambientale, una corte in grado di giudicare paesi, entità o persone che danneggiano l’ambiente a cui potranno fare appello Stati, popoli, persone; la possibilità per i Paesi in via di sviluppo di ricevere un indennizzo per le conseguenze che subiscono a causa del riscaldamento globale; e, infine, l’indizione di un Referendum Mondiale sul cambiamento climatico e sull'ambiente in coincidenza della prossima Giornata della Terra il 22 aprile 2011.
La consultazione, già proposta dal presidente boliviano durante la Conferenza di Copenaghen per ovviare alla mancanza di consenso tra i governi per concludere un accordo globale, si articolerebbe in cinque quesiti che riguarderanno vari temi: dall’abbandono delle modalità di sovrapproduzione e sovraconsumo al trasferimento delle spese militari alla difesa del pianeta. Nelle intenzioni dei promotori, al referendum potrebbero partecipare due miliardi di persone, ovvero la metà degli abitanti del pianeta in età elettorale.
Debito climatico, identificazione dei creditori, definizione delle forme di risarcimento e condanna dei paesi che non rispettano gli impegni per ridurre le emissioni di gas a effetto serra sono altri temi che sono stati trattati dai gruppi di lavoro.
RISULTATI- La conferenza ha riunito circa 20.000 persone tra attivisti, studiosi, esperti, rappresentanti delle popolazioni indigene, delle organizzazioni non governative e novanta delegazioni in rappresentanza dei governi provenienti dai cinque continenti.
Il vertice si è concluso con la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, che ha ottenuto grande approvazione tra i partecipanti, i quali si sono espressi a favore di ulteriori sforzi sottolineando la necessità di un maggiore dialogo tra i paesi per risolvere il problema del riscaldamento climatico.
Nella dichiarazione è stato stabilito che il riscaldamento globale non potrà eccedere l’1% fino al 2020, le emissioni di CO2 dovranno essere inferiori al 50% rispetto a quelle del 1990, la creazione di un Consiglio per la Difesa dei Popoli, più coordinamento affinchè si possa parlare con una sola voce e maggiore tutela dei diritti della Madre Terra.
Per risolvere la crisi climatica, conclude il leader boliviano, bisogna riconoscere la Madre Tierra come fonte di vita e adottare un modello di sviluppo basato sul benessere collettivo, sul rispetto dei diritti umani e sull’eliminazione di tutte le forme di capitalismo e imperialismo.
Il consenso sulla necessità di muoversi secondo un’azione cooperativa di lungo periodo deve andare, nelle intenzioni dei partecipanti, oltre la semplice negoziazione sul limite dell’incremento della temperatura e sull’emissione di CO2.
CONTRADDIZIONI – Va sottolineato innanzitutto che le dichiarazioni prese hanno un valore meramente propositivo e non hanno nulla di vincolante. Se i Governi difficilmente sono in grado di assumere impegni stringenti sulle tematiche ambientali, a maggior ragione una conferenza dei Popoli, per quanto lodevole sia il proposito, non potrà ottenere almeno nell’immediato importanti risultati concreti.
Inoltre, nonostante ci sia un accordo generale sul fatto che la Conferenza sia stata un evento riuscito e che il presidente boliviano, da sempre grande sostenitore dei diritti della madre tierra, abbia fatto un ottimo lavoro non sono mancate le critiche soprattutto in relazione alla decisione del governo boliviano di non interrompere l’esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi presenti nel paese.
Rafael Quispe, dirigente del Consiglio Nazionale di Ayllus e Markas de Qullasuyo, un’organizzazione boliviana indigena, ha sempre criticato i piani di estrazione mineraria del governo, e per questo motivo aveva chiesto di affrontare durante il summit la questione relativa ai conflitti ambientali portando all’attenzione dei partecipanti un caso di sospetta contaminazione di una miniera di rame di proprietà del governo boliviano.
Di fronte a una simile ipotesi è intervenuto il viceministro per la Biodiversità e l’Ambiente Juan Pablo Ramos, il quale ha sottolineato che l’obiettivo principale del Vertice è quello di porre le basi per la Conferenza Mondiale sul clima che si terrà a Cancún a dicembre, evitando che ciascun paese partecipante colga l’occasione per esporre problemi climatici che li riguardino direttamente.
DIMMI COME MANGI E TI DIRO’ CHI SEI – Il capo di Stato boliviano, leader del movimento mondiale per la lotta contro il cambiamento climatico, ha anche invitato la popolazione mondiale alla produzione e al consumo di alimenti ecologici, in linea con la cultura alimentare delle popolazioni indigene e in contrapposizione con l’industria alimentaria transgenica.
Mangiare quinua, grano andino di alto valore proteico e vitaminico, così come confermato dalla FAO, è ciò che è stato consigliato dal leader boliviano come miglior modo di alimentarsi. E ancora, l’utilizzo di sostanze naturali, secondo la tradizione delle popolazioni indigene, andrebbe fatto anche per i prodotti medicinali. Ma le maggiori critiche sono state rivolte verso gli alimenti transgenici prodotti in America Latina con sovvenzioni europee e statunitensi.
Il nemico mortale della terra, ha sottolineato il presidente Morales, sarebbe il capitalismo, basato su una crescita illimitata e insostenibile, causa di asimmetrie e ingiustizia nel mondo: “Senza un cambio nel sistema sarà impossibile ritrovare un equilibrio tra la natura e gli esseri umani” ha ricordato Morales.
NUOVA DIPENDENZA? – Anche in America Latina sono arrivate le colture transgeniche. Esiste un enorme dibattito a livello mondiale tra coloro che sostengono l’importanza della produzione transgenica per poter combattere in maniera più efficace la fame e al tempo stesso provocare un miglioramento della prosperità economica degli agricoltori e coloro che mettono l’accento sul fatto che questo tipo di culture non solo non apporta alcun tipo di beneficio, arrecando effetti nocivi sulla salute, ma al contrario genera nuove forme di dipendenza economica.
In tale contesto risalta il caso della Bolivia. Infatti, nonostante la nuova Costituzione, approvata con referendum nel dicembre 2009, prescriva il divieto di produrre e importare prodotti transgenici, è stato calcolato che più di 50 alimenti, che vengono regolarmente consumati dalla popolazione, contiene elementi modificati geneticamente.
Ciò si verifica perché non esiste nessuna autorità statale capace di controllare in quali condizioni vengono prodotti gli alimenti e la qualità dei prodotti utilizzati, ma soprattutto perché non esite una regolamentazione normativa che imponga l’etichettatura per i prodotti transgenici nazionali e importati.
La battaglia di Evo Morales, condivisa anche dall’alleato Hugo Chávez, che tuttavia continua a fare dell’estrazione petrolifera la principale fonte di sostentamento dell’economia venezuelana, è insomma caratterizzata da spunti interessanti ma anche di contraddizioni profonde. Merita tuttavia di essere sottolineata l’innovazione apportata a livello giuridico dall’inserimento, nelle carte costituzionali, di una nuova categoria di diritti che si riferiscono ai “popoli indigeni” e alla “Madre Terra”, o in senso più universale alla natura. Le nuove Costituzioni di Ecuador e Bolivia sono le prime a contemplarli.
Valeria Risuglia
[email protected]