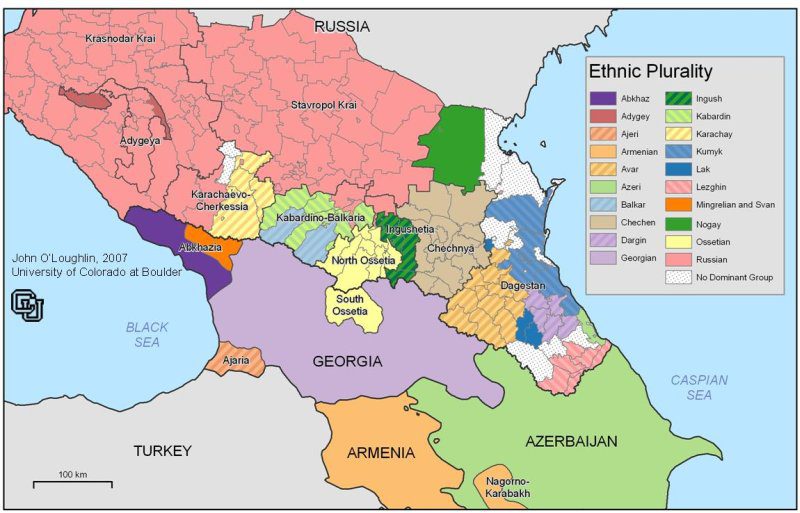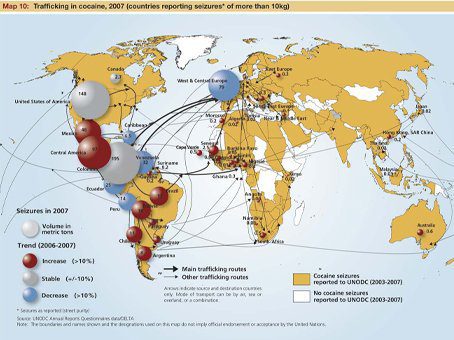Una vittoria inattesa, forse solo sperata. L’affermazione della lista capeggiata dall’ex primo ministro Iyad Allawi sorprende l’Iraq e le diplomazie occidentali gettando più di un’ombra sul futuro del paese. I vinti si riconosceranno tali? Ci sarà bisogno di un governo di unità nazionale? Il nuovo capo di stato saprà rispondere alle numerose sfide che gli si porranno dinanzi? Cerchiamo di fare luce su una situazione politica quanto mai complicata, ma importante da conoscere per comprendere le prospettive irachene
QUALE GOVERNO? – 91 contro 89, solo due seggi. È questo il minimo scarto con cui la coalizione di Iyaq Allawi, al-Iraqiya, ha vinto le elezioni presidenziali irachene di inizio marzo. Numeri che evidentemente non gli garantiscono la maggioranza (163 seggi su 325) in parlamento e che lo costringeranno a cercare alleanze con le altri fazioni politiche.
Ma chi sarà disposto a dialogare con Allawi? La risposta non è certo semplice. Infatti, anche qualora tutte le forze laiche volessero provare a formare un governo autonomo, non avrebbero i numeri per farlo: i 91 seggi di al-Iraqiya più i 43 dell’Alleanza kurda, aggiunti agli 8 della coalizione del Cambiamento kurda ed ai 6 di Uniti per l’Iraq non garantiscono infatti una cifra utile per raggiungere la maggioranza in parlamento. Il dialogo con le forze religiose sciite più che un atto volontario appare a questo punto una condizione necessaria anche perché la partecipazione curda ad un eventuale governo appare tutt’altro che scontata. Non si devono infatti dimenticare le forti spinte indipendentiste del Kurdistan il quale, proprio approfittando di un governo centrale debole, potrebbe assumere un atteggiamento sempre più autonomo e separatista.
RICONTIAMO – Lo sconfitto, il premier in carica Nuri al-Maliki, ha già dichiarato di non avere alcuna intenzione di aprire un confronto con Allawi. (nella foto sotto, i due contendenti) Anzi, il leader della colazione per lo Stato di Diritto ha chiesto a gran voce la riconta delle schede a causa di manifesti brogli elettorali. Gravi infrazioni sarebbero state rilevate da uomini vicini ad al-Maliki in molte sezioni di Baghdad e Mossul.
Le accuse di al-Maliki non sono state però raccolte dal mondo occidentale. USA, UE ed ONU si sono immediatamente affrettati a sottolineare la trasparenza del voto e l’inviato europeo Ad Merktel ha dichiarato che nessuna delle suddette millantate infrazioni è stata rilevata dagli osservatori internazionali.
Ma i problemi per Allawi non finiscono qui. Il numero di candidati eletti nelle liste del leader laico potrebbe infatti presto diminuire. Il comitato per l’epurazione degli ex baathisti (membri del regime di Saddam) ha raccomandato l’esclusione di sei deputati eletti nella lista vincente guidata da Ayad Allawi e di altri 46 candidati. Già nei mesi precedenti alle elezioni, la stessa commissione aveva proceduto all’esclusione di circa 500 nomi a causa della loro eccessiva vicinanza al vecchio regime di Saddam. Anche in Iraq politica e magistratura non vanno poi così d’accordo.

INCROCI E COALIZIONI – La vittoria di Allawi non va allora a delinearsi realmente come tale. Nonostante abbia ottenuto il maggior numero di seggi, al-Iraqiya rischia seriamente di non riuscire a governare il Paese. E nel frattempo al-Maliki si organizza. Una volta appurata l’attuale non disponibilità al dialogo con la controparte sunnita, l’attuale premier sciita ha infatti nuovamente aperto alle milizie di Moqtada al-Sadr: la reale sorpresa di quest’ultima tornata elettorale.
Gli uomini del leader spirituale sciita Al Sadr hanno infatti visto raddoppiare i loro seggi in parlamento: da 24 a 40 in un sol colpo. Le milizie sciite radicali fanno attualmente parte dell’INA (Iraq National Alliance) ossia quella coalizione che raccoglie la maggior parte delle forze di matrice sciita presenti attualmente in Iraq. Se al-Maliki riuscisse realmente ad unirsi con l’INA, terzo partito con 70 seggi conquistati, entrambi raggiungerebbero quota 159: ad un passo dalla maggioranza.
Resta però da vedere se al-Sadr accetterà o meno il ramoscello di ulivo offertogli dal vecchio alleato. L’appoggio dll’imam sciita non è affatto scontato visto il duro confronto militare che si ebbe nel 2008, quando proprio il premier al-Maliki ordinò alle truppe governative di attaccare il quartiere Sadr City di Baghdad, quartier generale di al-Sadr. La sconfitta di due anni fa è ancora viva nei ricordi del giovane imam e questo rende la situazione oltremodo incerta. Ultimissime indiscrezioni di stampa rivelano come al-Sadr abbia negato il suo assenso ad una formazione di governo che non includesse proprio il vincitore Allawi. Lo stesso al-Sadr pare abbia invocato un referendum popolare per scegliere chi dovrà ricoprire la carica di primo ministro. Paradossalmente proprio l’uomo considerato fino a un mese fa il principale propugnatore delle violenze del paese chiama alla calma ambo le fazioni proponendosi come mediatore fra le parti.
Le violenze sembrano però non voler conoscere fine. Il 28 marzo quattro bombe sono state fatte esplodere nella provincia di Anbar contro la casa di un membro della coalizione elettorale facente capo ad Allawi: 6 morti e 15 feriti. Il giorno successivo a Mossul un ordigno, parte di un fallito attentato contro una chiesa locale, ha causato la morte di un bambino di soli tre anni. Nella stessa giornata del 29 marzo tre autobombe sono deflagrate a Kerbala causando in serie 12 morti ed oltre 50 feriti. L’Iraq non sembra conoscere pace.
Marco Di Donato [email protected]