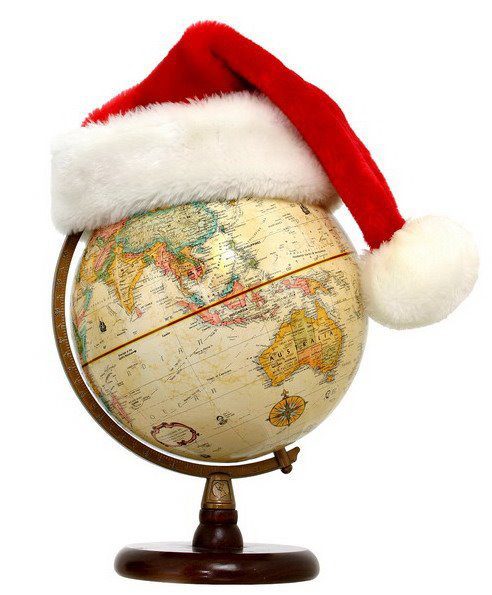Il 16 dicembre si sono tenute in Giappone le prime elezioni politiche post Tsunami, che hanno riportato al governo i conservatori, dopo la breve parentesi del triennio a guida progressista. Il partito Liberal Democratico di Shinzo Abe ha vinto con le solite parole d’ordine che in momenti di difficoltà catalizzano l’attenzione di un popolo in cerca di una guida forte. L’analisi del voto e gli scenari che si prospettano
UN’ANALISI DEL VOTO – Come da previsione, Shinzo Abe, leader del “Partito Liberal-Democratico”(DLP), principale formazione di centrodestra del paese del Sol Levante, ha trionfato alle elezioni politiche dello scorso 16 dicembre. Una vittoria schiacciante sul candidato del centro-sinistra, il premier uscente Yoshihiko Noda, al governo nell’ ultimo triennio, 2009-2012. Vittoria prevista quella di Abe, già primo ministro tra il 2006 e il 2007, che tuttavia, va al di là delle aspettative. Il DLP vince infatti con oltre il 60% dei consensi,ottenendo circa 300 dei 480 seggi della camera bassa e conquistando la maggioranza qualificata che permetterà di evitare l’empasse politica dei veti incrociati alla camera alta. Bene anche gli ultra nazionalisti del “Partito per la Restaurazione del Giappone”(JRP), terza forza del paese con l’11% dei consensi e i buddisti del “Nuovo Komeito” con il 6% delle preferenze. Gli sconfitti sono il “Partito Democratico del Giappone”(DPJ) al 12%, da cui il premier uscente Noda ha rassegnato le dimissioni, e gli antinuclearisti di “Giappone futuro” fermi al 2%. “Paghiamo il prezzo pesante di scelte necessarie -le prime parole di Noda- e me ne assumo la responsabilità”.
SCENARI PREOCCUPANTI – Le principali cause della debacle elettorale del DPJ sono da ricercarsi nella pesante crisi economica in cui versa il paese e nelle scintille con i “vicini di casa” che stanno per innescare un incendio il cui scoppio sarebbe difficile domare. Un capitolo a parte merita la vicenda sul nucleare, in un Paese ancora scosso dalla tragedia di Fukushima e che ha visto l’argomento al centro del dibattito elettorale. Abe a differenza dello sconfitto Noda è parso poco convinto sulla necessità della chiusura totale delle centrali nucleari, principale fonte energetica del Paese. La sua vittoria potrebbe far riflettere sul fatto che i giapponesi la pensino come lui: sarà determinante osservare nei prossimi mesi quali saranno le decisioni di politica energetica che verranno adottate dal nuovo governo. Ma andiamo con ordine. Sul piano economico il Giappone è in una situazione molto delicata, l’altissimo debito pubblico e l’elevata età media della popolazione incidono sul tasso di crescita economica del Paese, fermo all’1.2%. Ad ulteriore conferma, il FMI sostiene che la maggior parte dell’ enorme debito pubblico, pari al livello astronomico del 230% del PIL, sia dovuto proprio all’incremento della spesa pubblica per la previdenza sociale, in primis pensioni e sanità. I tagli alla spesa pubblica e il previsto aumento dell’iva, dal 5 all’8 % nel 2014 fino al 10% nel 2015, per far fronte a questa emergenza, non sono piaciuti ai giapponesi. Misure che si sono sommate inoltre alla grave crisi delle esportazioni verso i paesi dell’area euro e soprattutto verso il principale partner commerciale nipponico, la Cina.
I RAPPORTI CON I VICINI – Situazione quest’ultima, deterioratasi parecchio negli ultimi mesi a causa delle frizioni per il controllo dell’arcipelago Senkaku-Diaoyu, formalmente giapponese ma rivendicato a gran voce dal gigante asiatico. Una delle tante ambiguità territoriali lasciate in eredità dalle diplomazie occidentali dopo lo scioglimento degli imperi coloniali asiatici. In estate alcune “delegazioni” di nazionalisti di ambo le parti hanno fatto “visita” alle isole in questione muniti di bandiere e striscioni rischiando di mettere in pericolo la pace nella zona. Anche con la Corea del Sud la situazione è tesa per la disputa su alcuni isolotti da decenni sotto controllo sud coreano e rivendicati in questo caso dal Giappone, ovvero le isole Dokdo-Takeshima. Ad agosto la visita sulle isole contese del presidente Sud Coreano Lee Myung-bak, ha scatenato l’ira del governo giapponese che ha richiamato il suo ambasciatore da Seoul. Nelle prime dichiarazioni post-voto il premier neo eletto, ha rilanciato la necessità di “rispondere alle provocazioni di Cina e Corea del Sud”, dichiarazioni precedute da un infuocata campagna elettorale improntata su forti slogan nazionalistici e anti-cinesi. Non bisogna dimenticare infine il pericolo nordcoreano che poche settimane fa ha completato il lancio del missile balistico UNHA-3 provocando un terremoto diplomatico in Asia orientale e non solo. Numerose le voci di condanna, da Ban Ki Moon segretario generale dell’ONU, alle principali cancellerie occidentali, Stati Uniti in testa.

IL PACIFICO E’ PIU’ LARGO? – Proprio agli Stati Uniti guarda con rinnovata fiducia il neo premier, che ha bisogno ora più che mai dell’appoggio americano. Non a caso la prima visita di Abe in gennaio sarà proprio alla Casa Bianca, un segnale che può voler dire “non lasciateci soli”. Gli Stati Uniti tuttavia difficilmente potranno schierarsi apertamente a fianco del Giappone contro la Cina super-potenza asiatica con la quale vi è ormai una interdipendenza strategica. Il Giappone ha scelto di affidarsi a Shinzo Abe, soprannominato il “falco”, per dirimere le pericolose questioni territoriali e far ripartire l’economia della terza potenza mondiale. La situazione ha bisogno di una scossa immediata, per riconsegnare al Paese del Sol Levante il ruolo chiave negli equilibri dello scacchiere geopolitico in estremo oriente. Abe sarà in grado di darla?
Filippo Carpen