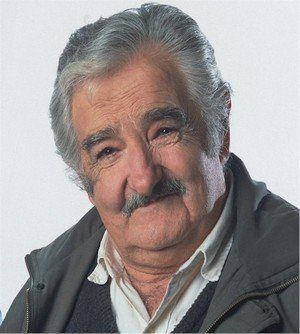Uno scenario tutt’altro che improbabile o disfattista. Nell’ultimo mese, diverse dichiarazioni, da parte israeliana ma non solo, sembrano volte a preparare le opinioni pubbliche interne. E i negoziati sullo scambio di prigionieri e Gilad Shalit potrebbero svolgere un ruolo determinante
SCENARI DI GUERRA – Coma va a Gaza? Male. Molto male. Non solo perché la situazione umanitaria è ogni giorno più drammatica. Non solo perché la guerra di dicembre-gennaio con l’incursione israeliana nella Striscia (1400 morti) non ha risolto nulla, anzi. Non solo perché Hamas non accenna minimamente a cambiare strategia, sempre più decisa nella sua politica di riarmo. Questi elementi sono solo alcuni di quelli che contribuiscono a creare uno scenario decisamente cupo. Ma soprattutto, e qui sta la questione centrale, gli scenari prossimi potrebbero essere ancora più devastanti. Perché se è vero che non troverete nessuno disposto a metterci mani sul fuoco, è altrettanto vero che diversi fatti concorrono a rendere sempre più possibile lo scenario di un nuovo conflitto nella Striscia nel breve termine. Quasi nessuno ne sta parlando, ma un simile scenario non è affatto da escludere, soprattutto se, come vedremo poi, altre questioni tra le parti non riusciranno a sbloccarsi a breve.
DAL RAZZO IN POI – Torniamo indietro di un mese. È il 3 novembre quando Amos Yadlin, direttore dell’Intelligence militare israeliana, annuncia il lancio di un razzo in mare compiuto da Hamas. Il lancio doveva rimanere segreto, ma è stato intercettato dai radar israeliani. Un esperimento con un particolare allarmante: la gittata del razzo, che può essere lanciato anche da una rampa sistemata su un semplice autocarro, è di 60 chilometri, e dunque, se lanciato dal punto più settentrionale della Striscia di Gaza, potrebbe arrivare a colpire Tel Aviv. E alla Knesset, il Parlamento israeliano, Yadlin ha riferito che l’arsenale militare di Hamas è di gran lunga più ricco rispetto a un anno fa, nell’imminenza dell’Operazione Piombo Fuso. Inoltre, egli ha affermato che tale riarmo indica un chiaro segnale di rinnovata volontà di un conflitto con Israele, e che quest’ultimo razzo voleva essere una sorta di “arma a sorpresa” da riutilizzare in un prossimo conflitto. Un razzo di tale gittata parrebbe dunque alterare il bilanciamento della deterrenza, che Israele dichiarò di aver ristabilito in gennaio, al termine dell’incursione nella Striscia. La questione centrale però non è tanto il fatto in sé, quanto il modo con cui Yadlin ha riferito del lancio. Parlare alla Knesset è equivalso di fatto a parlare all’opinione pubblica. La modalità di comunicazione ha infatti tolto un velo, iniziando a preparare il pubblico relativamente ad un nuovo conflitto a Gaza. Hamas, che sa bene come una nuova incursione israeliana risulterebbe per la già martoriata Gaza un disastro senza confini, ha smentito il lancio, denunciando la falsità della dichiarazione israeliana, volta a influenzare le discussioni Onu sul Rapporto Goldstone relativo al conflitto di dicembre-gennaio, e istigare l’opinione pubblica.

VOLANO ACCUSE – Una decina di giorni dopo, il Capo di Stato Maggiore dell’esercito, Gabi Ashkenazi, ha dichiarato: “Se i lanci continueranno, l’esercito non esiterà a rispondere contro questi”. La frase in sé potrebbe apparire quasi di circostanza, se il contesto non fosse stato quello di un dialogo con un gruppo di studenti delle superiori in una scuola di Beer Sheva. Un altro segnale indirizzato non tanto a politici e istituzioni, quanto all’opinione pubblica. Difendendo la giustizia dell’Operazione Piombo Fuso, Ashkenazi ha rilanciato così: “Quando arrivano razzi su Beer Sheva, dobbiamo difenderci, e così abbiamo fatto. Ed esiste la possibilità che saremo costretti a farlo di nuovo”. Da questa dichiarazione è partito il monito del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, che alla televisione iraniana ha denunciato la volontà israeliana relativa ad una nuova offensiva nella Striscia, mentre Hamas, come dichiarato ad una delegazione della Croce Rossa, “non sta cercando nuova violenza. Ma se Israele attaccherà, ci faremo trovare preparati e combatteremo con tutti i mezzi a nostra disposizione”. Al di là delle schermaglie verbali, rimane l’obiettivo: preparare le opinioni pubbliche, affinchè un possibile nuovo conflitto non le colga di sorpresa. E da questo punto di vista, in Israele le parole di Yadlin e Ashkenazi hanno subito trovato riscontro sulla stampa. Su Yediot Ahronot, uno dei giornali più diffusi in Israele, l’analista militare Alex Fishman ha scritto: “Nessuno ai vertici delle forze armate dubita della necessità di andare incontro ad un nuovo scontro militare con Hamas. È credibile affermare che lo scontro riprenderà su larga scala a dicembre, ad un anno esatto da Piombo Fuso”. Il lancio del razzo a lunga gittata avrebbe segnato dunque l’inizio del countdown. La tensione regionale (negoziati sul nucleare iraniano appesi a un filo, instabilità interna palestinese) potrebbero solo accelerare tutto questo. Come spiega un editoriale di Yisrael Hayom, “Per Israele è meglio essere un occupante ma in pieno controllo della situazione piuttosto che rimanere passivo lasciando ad Hamas la sua capacità strategica”.
DIPENDE DA GILAD? – In realtà, Israele non ha nessun interesse o convenienza a occupare nuovamente la Striscia di Gaza. I benefici sarebbero incerti, e i costi altissimi. Tra l’altro, da una ventina di giorni su questo scenario è calato il silenzio, soprattutto perché i negoziati per lo scambio di prigionieri tra le parti – che porterebbero alla liberazione del soldato israeliano Gilad Shalit, da tre anni e mezzo nelle mani di Hamas, in cambio di 1000 detenuti palestinesi (tra cui probabilmente Marwan Barghouti, uno dei leader del braccio armato di Fatah durante la Seconda Intifada) – stanno per giungere ad un punto cruciale. Le due questioni sono collegate: se lo scambio andrà in porto, uno scenario conflittuale sembrerebbe meno possibile, o quanto meno rimandato nel tempo. Se tutto dovesse saltare improvvisamente, però, ecco che queste dichiarazioni volte a preparare l’opinione pubblica tornerebbero violentemente alla ribalta, e non potrebbero essere ignorate.
Alberto Rossi [email protected]