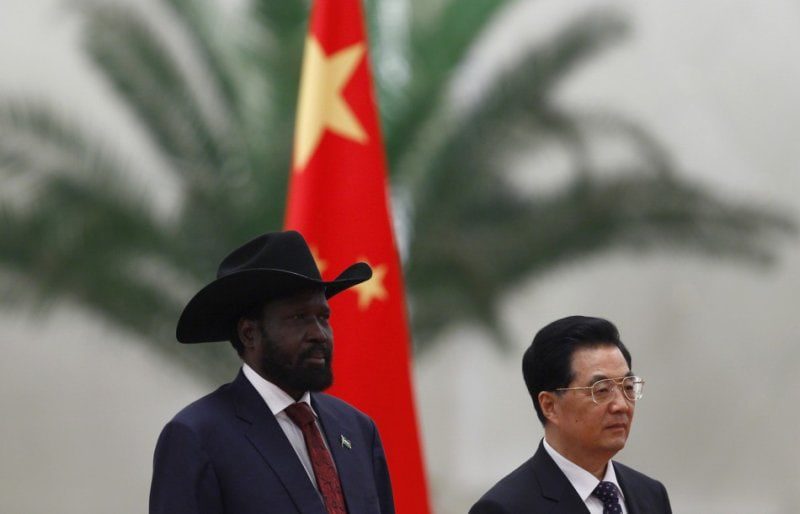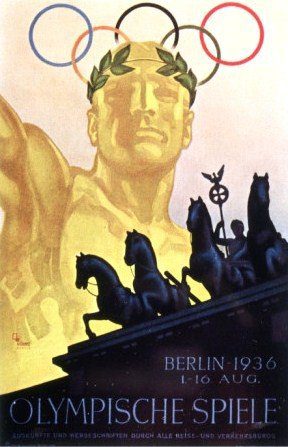Durante la giornata di domenica 20 maggio 2012, nella Repubblica di Santo Domingo si sono svolte le elezioni presidenziali. Alle 5.00 di mattina del 21, ora locale, la Junta Central Electoral (JCE) ha emanato il nono bollettino con il quale dichiara, dopo lo spoglio del 97,47% delle schede la vittoria al primo turno del candidato del PLD (Partido de la Liberacion Dominicana) Danilo Medina e di Margarita Cadeño de Fernandez ex-first lady e candidata alla vice presidenza, con il 51,27% dei voti
IL PANORAMA ELETTORALE – Il popolo domenicano è stato chiamato ad eleggere il nuovo Presidente del Paese tra una rosa di sei candidati, ma tutti i sondaggi già da diverso tempo rilevavano che la competizione si sarebbe sostanzialmente svolta tra i due leader dei principali partiti del paese: Hipolito Mejia rappresentante del PRD (Partido Revolucionario Dominicano) già presidente durante la legislazione del 2000-2004 e appunto Danilo Medina del PLD appoggiato dall’ormai ex-presidente Leonel Fernandez. Gli altri quattro candidati hanno infatti ricevuto un numero di voti irrisorio rispetto ai primi due.
I DUE SFIDANTI – Questa elezione può essere definita quasi un rematch di quella del 2000 durante la quale Mejia sconfisse Medina. Si è trattato insomma di una competizione tra veterani. Mejia, ingegnere agronomo, iniziò la sua carriera politica in giovane età e oltre a ricoprire massima carica di Presidente del paese fu, ancora prima, nominato Ministro della Agricoltura. Durante la sua legislatura il governò non fu assolutamente in grado di gestire la politica e l’economia nazionale. L’aumento dei livelli di povertà fu notevole così come quello del debito estero. La sua presidenza vide inoltre il crollo della Baninter (la banca commerciale privata la più grande del paese) a causa di uno scandalo di corruzione e di frode ad altissimi livelli di governo. Infine, il suo pacchetto di riforme, chiamato appunto il “paquetazo”, fatto di tagli alla spesa pubblica e di tasse per i cittadini mise in ginocchio buona parte della già povera popolazione domenicana. Nonostante ciò oggi, dopo la crisi economica che ha colpito la Repubblica Domenicana, si è presentato come il salvatore della patria, con il motto “E’ arrivato papà!”, forte soprattutto nella parte Nord dell’isola, quella della città di Santiago.
UN PRESIDENTE NORMALE – Dalla fine della legislatura di Mejia nel 2004 è stato invece presidente per due mandati consecutivi Leonel Fernandez, il quale non potendosi più presentare alle elezioni appoggia il nuovo rappresentante del partito, un economista, anche lui non nuovo alla vita politica, Medina. Questi è stato eletto tre volte come deputato nel 1986, nel 1990 e nel 1994, ha lavorato anche come presidente della Camera dei Rappresentati ed è stato due volte nominato Segretario di Stato. La sua campagna elettorale ha avuto un avvio difficoltoso a causa della sua fama di candidato debole e i sondaggi inizialmente lo davano come perdente fino a quando non ha scelto come candidata alla vice-presidenza l’ex-first lady grazie alla quale si è guadagnato nuovamente le simpatie dei militanti del PLD. Il suo motto è “Per continuare con le cose buone, correggere quelle sbagliate e fare quello che non si è mai fatto”.

BRIVIDI E TENSIONI – Si è trattato di una campagna elettorale segnata comunque da fortissime tensioni e ostilità tra i due contendenti alla carica, e spesso e volentieri si è dato più spazio ai reciproci insulti che ai programmi elettorali. Lo stesso Presidente Fernandez si è trovato in mezzo ad un conflitto a fuoco, mentre la moglie ha subito un lancio di pietre che però hanno ferito un suo collaboratore. A causa di queste tensioni durante questa tornata elettorale erano presenti nel paese ben duecento osservatori internazionali accreditati, e sessantamila poliziotti e truppe dell’esercito sono stati mobilitati per garantire il normale svolgimento delle elezioni e la sicurezza all’interno del paese. Le operazioni di voto, effettivamente, si sono svolte in un clima abbastanza pacifico e da più parti sono stati fatti elogi alla popolazione domenicana per la compostezza con cui si sono recati alle urne. Lo stesso Presidente della JCE ha elogiato il comportamento pacifico e civile dimostrato dagli elettori e ha dichiarato che benché ci siano stati alcuni incidenti soprattutto nel sud del paese, con diversi casi di persone rimaste ferite durante gli scontri tra i sostenitori delle diverse fazioni, si è comunque trattato di casi isolati e di lieve entità. Ciò non toglie che la scorsa notte durante lo spoglio ci siano stati momenti di forte tensione, quando si è appreso che il candidato del PLD avrebbe potuto vincere al primo turno. Le contestazioni dei risultati da parte dello sfidante non si sono fatte attendere e ora fanno temere una nuova fase di incertezza dopo la campagna elettorale già tesa e a tratti violenta. Le contestazioni sono iniziate ancora prima che venisse emesso il primo bollettino elettorale da parte della JCE. I sostenitori di Mejia hanno accusato la giunta stessa di aver manomesso il sistema di trasmissione dei risultati e di non aver consentito un controllo da parte dei suoi stessi rappresentati.
DA DOMANI – La vittoria di Medina non lascia presagire un vero e proprio cambio di rotta della politica domenicana, anche se questo era l’intento iniziale del neo-premier, almeno prima della candidatura della Cadeño de Fernandez. Non bisogna, infatti, sottovalutare il fatto che il favore da parte dell’elettorato del PLD nei confronti del neo-presidente è andato in crescendo solo dopo la candidatura alla vice presidenza della Signora Fernandez la quale, non solo ha dato una svolta alla campagna elettorale, ma con molta probabilità cercherà di seguire l’impronta politica lasciata dal marito. Di incoraggiante c'è che durante le sue prime dichiarazioni Medina ha espresso apertamente l’intenzione di coinvolgere gli avversari del PRD nella politica di governo attraverso la sigla di un patto che favorisca la collaborazione dei due schieramenti in tutti i settori che riguardano il progresso, lo sviluppo e la trasformazione nazionale indispensabili per il paese.
Marianna Piano [email protected]