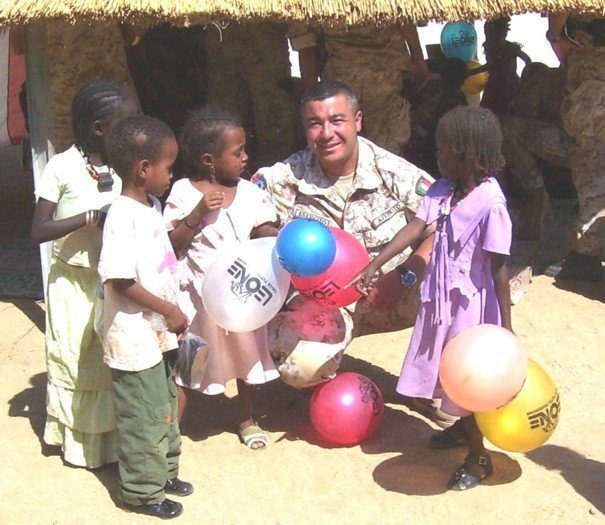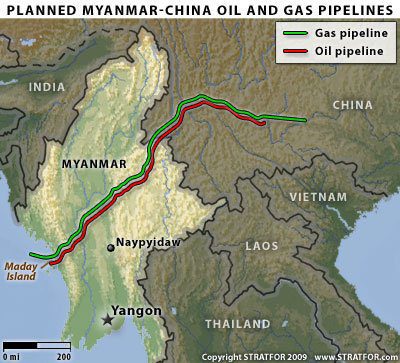L’Unione Europea sta negoziando con l’India per un accordo di libero scambio che potrebbe ridurre drasticamente l’accesso ai farmaci economici salvavita per milioni di persone affette da HIV/AIDS. L’India, che produce l’80 per cento dei medicinali generici destinati alla lotta contro l’AIDS, finora ha mantenuto la sua posizione nel non voler accettare queste condizioni, ma i tentativi dell’Europa di limitare l’accesso a questi medicali sono insistenti. Ecco come questa questione si inserisce nell'importante dinamica del commercio bilaterale tra Nuova Delhi e Bruxelles
IN GIOCO LA VITA DI MILIONI DI PERSONE – La giornata mondiale contro l’AIDS celebrata ogni 1° di dicembre, quest’anno vuole richiamare le istituzioni alle proprie responsabilità per impegnarsi in maniera più decisa sul fronte dell’accesso alle cure. Questo aspetto dovrebbe suscitare particolare attenzione a causa della concomitanza con la conclusione delle trattative tra l’Unione Europea e l’India per un accordo di libero scambio tra le due potenze economiche. Già nel giugno del 2007 la Commissione Europea (CE) e il governo indiano hanno intrapreso i negoziati verso un accordo completo e di vasta portata sul libero scambio, che potrebbe avere conseguenze significative non solo per l’economia indiana ma anche per milioni di persone affette da HIV/AIDS che vivono in paesi del terzo Mondo. MEDICINALI GENERICI – Alcune delle disposizioni che la CE intende imporre all’India, minacciano la posizione di quest’ultima come maggior produttore di farmaci generici, che hanno giocato un ruolo fondamentale nell’aumento delle cure antiretrovirali nei paesi in via di sviluppo. Prima di approfondire il discorso, vi è la necessità di chiarificare cos’è l’industria dei medicinali generici e l’importanza di quest’ultima ai fini dei trattamenti salvavita per le persone sieropositive nei paesi in via di sviluppo. Il ciclo di produzione di un prodotto farmaceutico comincia con la scoperta di un determinato principio attivo caratterizzato da particolari potenzialità terapeutiche. Un lungo (e costoso) ciclo di test clinici che confermano l’efficacia e la sicurezza del farmaco, come anche il periodo di ricerca antecedente alla scoperta, rendono necessaria la richiesta di tutela brevettuale da parte delle aziende farmaceutiche. Queste ultime così possono assicurarsi un ritorno economico sugli investimenti effettuati. Una volta scaduto il brevetto, che copre un periodo di circa 20 anni, un’ industria farmaceutica può ‘copiarla’ e mettere sul mercato un prodotto con le stesse proprietà del farmaco originale, ma con una differenza fondamentale: il prezzo. Infatti, questo può venire a costare almeno il 20% in meno rispetto a quello originale e permette così un consistente risparmio a coloro che ne hanno bisogno. LA FARMACIA DEL SUD DEL MONDO – La questione dei farmaci generici è uno dei punti caldi delle trattative tra la CE e l’India. Il subcontinente è soprannominato farmacia del Sud del mondo e produce l’80% medicinali generici destinati alla lotta contro l’HIV e l’AIDS. Le clausole che la CE vuole far approvare sono state contestate dal Global Fund, da varie ONG come Medici senza Frontiere, ma anche dalla stessa Organizzazione mondiale della Sanità, che contestano il prolungamento della durata dei brevetti e, particolarmente, l’esclusività dei dati di ricerca clinica. Questi dati, prodotti dalle multinazionali farmaceutiche, accertano la sicurezza ed efficacia dei principi attivi e la mancanza di questi accertamenti, aumenterebbe molto i costi dei farmaci, visto che le industrie farmaceutiche locali indiane sarebbero costrette a iniziare da capo la ricerca oppure aspettare la fine del periodo di protezione dei dati per il periodo di dieci anni.

“EUROPA! GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE MEDICINE!” – In una nota pubblicata a Ginevra, il Relatore Speciale sul diritto alla salute delle Nazioni Unite, Anand Grover, ha inoltre sottolineato come l’accordo di libero scambio nella versione corrente non sarebbe in regola con la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, visto che andrebbe a privare milioni di trattamenti salvavita. Grover ha anche criticato la mancanza di trasparenza dei negoziati sull’accordo e si è unito alle campagne come quella indetta da Medici senza Frontiere, “Europa! Giù le mani dalle nostre medicine”. Ariane Bauernfeind, coordinatrice dei progetti di MSF in Africa ha dichiarato: “Senza cure appropriate, la metà dei bambini affetti da HIV/AIDS non raggiungerebbe il secondo anno di vita. Non possiamo permettere che l’UE interrompa la nostra fornitura di medicine nuove e a basso costo”. Veronika D’Anna [email protected]