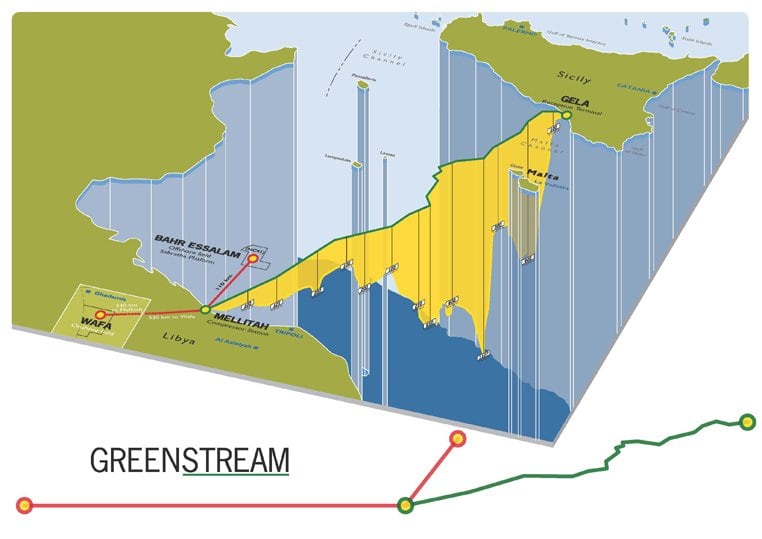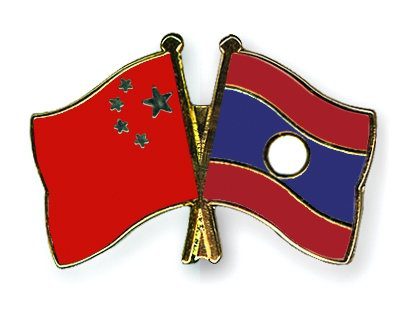Seconda parte del nostro articolo introduttivo sul panorama degli Investimenti Diretti Esteri nel continente nero. Grandi risorse naturali e manodopera a basso costo sono due fattori che costituiscono importanti ragioni per l'afflusso di capitali nella regione. Tuttavia, i settori estrattivo e agricolo non sono i soli destinatari: esistono infatti anche alcune “nicchie” per quanto riguarda l'Information and Communication Technology
Seconda parte GLI IDE: UNA NUOVA PROSPETTIVA PER L’AFRICA – Ciò che oggi emerge, quindi, nel panorama economico africano di questi ultimi anni è che molti governi stiano progressivamente abbandonando una politica incentrata solo sulla richiesta di aiuti internazionali per lasciare spazio ad una politica economica attiva anche attraverso l’apertura agli IDE. Si tratta di un cambiamento di rotta radicale, tanto che molti investitori internazionali attualmente considerano l’Africa la nuova frontiera dell’investimento privato, inserendola tra le così dette economie emergenti. Gli studi del Vale Columbia Center on Sustainable International Investment della Columbia University, inoltre, pongono l’accento su un dato di notevole importanza: nel prossimo decennio Brasile, Russia, India e Cina forniranno da soli il 30% dei nuovi investimenti stranieri in Africa (la quota maggiore di IDE proviene ancora dai paesi dell’OCSE). Ciò trova la sua giustificazione nella la rapida crescita dei BRIC, nonché degli altri mercati emergenti come quelli del Medio Oriente che avendo sempre maggiore necessità di materie prime sono disposti a finanziare sempre di più il settore estrattivo in tutte quelle parti del globo ricche di risorse minerarie ed energetiche. Anche i mercati emergenti cambiano volto, non si pongono più solo come consumatori ma anche come investitori nel settore dell’industria estrattiva e non solo, diventando essenziali per il sostegno delle economie locali. Dal canto loro i governi africani, grazie a quest’accresciuto interesse da parte degli investitori, stanno favorendo e sostenendo il miglioramento delle politiche fiscali e la creazione di un mercato maggiormente competitivo in modo da rendere gli stati capaci di attirare maggiormente gli IDE e di diversificare i settori dell’economia. GLI IDE FAVORISCONO LO SVILUPPO DEI DIVERSI SETTORI ECONOMICI – Gli investimenti esteri favoriscono, attraverso accordi di partnership tra governi e investitori, lo sviluppo e la crescita. Si tratta di dare nuovo ossigeno all’economia reale, liberando il potenziale di sviluppo regionale con la costruzione delle infrastrutture necessarie come le strade, le rotaie, i porti, lo sviluppo della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni. Il Ruanda, ad esempio, sta investendo nel settore delle tecnologie di comunicazione con l’ICT Park di Kigali e la telefonia mobile sta vivendo un momento di boom in tutto il continente. Nei prossimi tre anni, invece, il Sud Africa, secondo le stime del Ministero del Commercio e dell’Industria, attirerà investimenti esteri per circa 11,8 miliardi di euro a fronte del 2,9 del 2010 che hanno contribuito alla creazione di circa 13.000 posti di lavoro. Mentre, l’India in cinque anni investirà 4 miliardi di dollari nello Zimbabwe nella costruzione di un impianto per la lavorazione di minerali ferrosi, che permetterà la creazione di nuovi 500 posti di lavoro. La ricchezza di materie prime consente sì lo sviluppo del settore estrattivo, ma tutto ciò sarà utile anche al miglioramento della produttività agricola e allo sviluppo del capitale umano – attraverso la costruzione di scuole e la maggiore diffusione dell’istruzione, indiscutibile base per il progresso di uno sviluppo economico sostenibile – e il collegamento dei vari settori e comparti attraverso le catene di fornitura dei prodotti, la formazione professionale, l’occupazione e conseguentemente di sviluppo industriale condurranno alla diversificazione dei settori economici. UN SETTORE IN ESPANSIONE – Un settore fondamentale per lo sviluppo sostenibile che sta riscuotendo grande successo in diversi paesi africani come il Kenya, e il Sud Africa è quello delle energie rinnovabili. Alcuni programmi di investimento provengono anche dalla Banca Mondiale e dall’Unione Europea e dovrebbero dare vita a moderne reti elettriche nazionali in Malawi e in Tanzania. L’Etiopia punta invece allo sviluppo dell’energia idroelettrica, un settore che potrebbe portare alla piena soddisfazione del mercato nazionale e all’esportazione del surplus. Si tratta di un progetto di sviluppo sostenibile molto ambizioso perché ha l’intento di sostenere la compartecipazione degli investitori locali sia nella costruzione di impianti idroelettrici che nell'indotto e la formazione in loco di professionisti. NON TUTTI I PAESI SI MUOVONO NELLA STESSA DIREZIONE – Paesi come il Sudan e l’Angola rappresentano, invece, esempi meno edificanti di crescita economica attraverso gli IDE. In Sudan l’Iran sostiene lo sviluppo del nucleare. Ahmadinejad, durante la visita di Stato, ha offerto al governo di Bashir investimenti in denaro, in know-how, supporto tecnico e ingegneristico per lo sviluppo di questo settore. Al di la delle ripercussioni che ciò potrebbe avere sul piano internazionale è evidente che investimenti di questo tipo, in un paese devastato dalla guerra civile, con un tasso di povertà e problemi alimentari enormi e un tasso d’istruzione molto basso, non possa essere conciliabile con la definizione di crescita e sviluppo sostenibile. In Angola, invece, nella regione della Cabinda – che da sola detiene il 60%delle riserve petrolifere del paese – la compagnia petrolifera Sonangol impiega solo manodopera cinese e il ricavato va tutto nelle casse dello stato tagliando completamente fuori gli abitanti locali costretti a condizioni estreme di povertà e impossibilitati a sviluppare il loro territorio. L’estrazione petrolifera in questa zona – dove sono presenti anche la Chevron-Texaco, l’Agip e la TotalFinaElf – è super protetta tanto che il FLEC (Fronte per la Liberazione dell’Enclave della Cabinda) non avendo i mezzi per ingaggiare una forte opposizione contro le compagnie e contro lo stato nulla può fare perché si avvii un processo di sviluppo sostenibile a favore della popolazione locale e dell’ambiente.
LO SVILUPPO PASSA ATTRAVERSO LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE FORZE IN CAMPO – E’ facile comprendere a questo punto quanto incida la volontà dei decisori nazionali e degli investitori stranieri – che siano essi stati o multinazionali – perché l’Africa possa crescere in modo consapevole ed entrare a pieno titolo a far parte dell’economia mondiale. E’ indispensabile il coordinamento e l’impegno di tutte le forse e i progetti in gioco. E’ necessario dare vita ad economie di scala, ridurre i costi e favorire l’accesso per la fruizione dei nuovi servizi. La conversione o il contemporaneo utilizzo delle infrastrutture costruite per l’esportazione di materie prime anche per il trasporto dei prodotti agricoli può rappresentare un primo esempio, così come la produzione di energia in una determinata zona può essere utilizzata anche per il miglioramento e l’espansione delle reti locali dell’elettricità. Tutto ciò, tra l’altro può essere favorito dal fatto che molti attori internazionali sono sempre più disposti a finanziare lo sviluppo di queste infrastrutture sia in cambio dell’accesso alle risorse (la così detta offerta “risorsa-per-infrastruttura”), sia in cambio della costruzione di nuovi legami diplomatici più forti con i governi africani. Molti stati africani, inoltre, si sono visti cancellare il debito estero che pesava sulle proprie finanze come un macigno, un’ulteriore incentivo, assieme agli IDE per il superamento della crisi. LA LUNGA STRADA PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI – Queste rosee prospettive potrebbero essere minate se gli attori coinvolti mancassero della dovuta serietà e continuassero ad operare solo con l’intento di ricavarne un proprio utile. Si tratta di un compito affidato in primo luogo a tutti i leader africani; dovranno dimostrare di essere in grado di sfruttare positivamente i nuovi impulsi provenienti dalla crisi economica internazionale e di promuovere le giuste politiche economiche e sociali. Non solo, per la prima volta anche l’opinione pubblica africana sta ricoprendo un ruolo fondamentale a favore del cambiamento positivo. Si tratta di un’opinione pubblica che cambia, che diventa più consapevole, più partecipe e che da più parti del continente comincia a denunciare a gran voce gli abusi tollerati finora. Anche da questo punto di vista il cambiamento sembra essere stato avviato in molte parti dl continente, ma la strada è ancora lunga. Per raggiungere questo importante obiettivo i governi dovranno impegnarsi soprattutto per fare si che il boom degli IDE per le risorse venga convertito in un boom di sviluppo sostenibile, inclusivo per le popolazioni africane permettendo così all’Africa di guadagnare finalmente un ruolo di soggetto internazionale paritario all’interno del panorama mondiale e di abbandonare definitivamente quello meno lusinghiero di “oggetto” che ha rivestito per troppo tempo. Solo gli sviluppi futuri potranno dirci se la strada imboccata per l’agognato processo di crescita va nella giusta direzione. Marianna Piano [email protected]