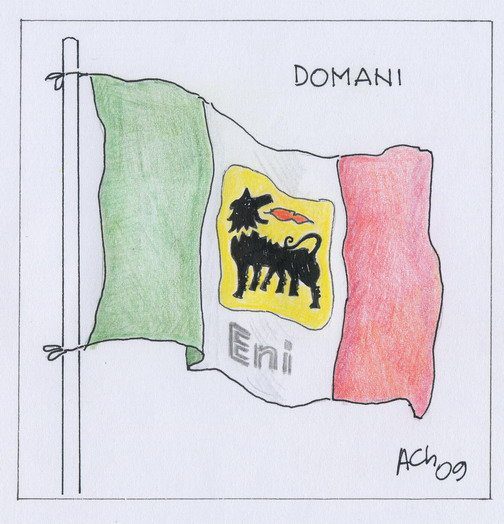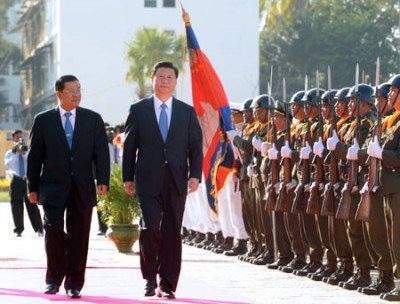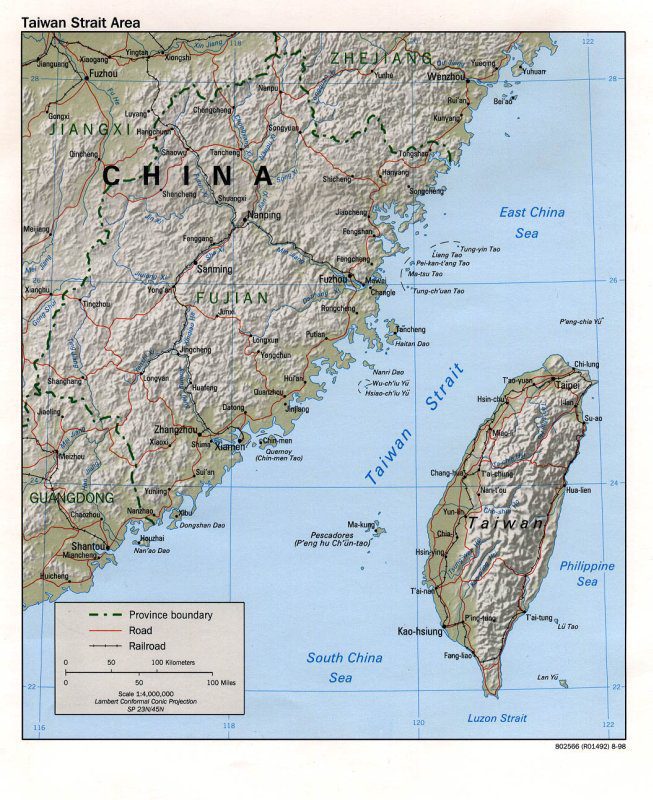Non è stato un inventore, Steve Jobs. C’era il Pc prima del Mac, l’Mp3 prima dell’iPod, il telefonino prima dell’iPhone, il tablet prima dell’iPad. Ciò che ha creato, c’era già. La rivoluzione e la genialità di Jobs non stanno nell’inventare, ma in quel think different che permette di re-inventare. Cambiare il modo di guardare alle cose: sta in questa visione la sua influenza sul mondo, ed è questo il suo messaggio. Al quale anche noi del Caffè vogliamo ispirarci
IL COLORE DEL LUTTO – In casa Apple è il bianco. Un volto d’uomo impresso su sfondo bianco nella home-page del sito della Apple. Barba incolta, sorriso schivo e quello sfolgorio di creatività proiettato al futuro, che illumina lo sguardo di geni avanguardisti, innovatori e precursori. Ieri a Palo Alto è morto Steve Jobs, fondatore di Apple. Poco dopo lancio del nuovo melafonino, l’i-Phone 4S, il mondo si prepara a salutare il padre del Mac, dell’i-Pod, dell’i-Pad, dell’i-Phone e della Pixar, un “genio visionario e creativo” che “ha cambiato il modo in cui ognuno di noi guarda il mondo”, come ha affermato stamani il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama.
Per il gigante della comunicazione globale si è mobilitata per celebrare il cordoglio digitale, uniti al grido di “stay hungry, stay foolish” con lacrime e lutto virtuali.
I più critici sottolineano le contraddizioni del suo operato e colgono l’infelice occasione per estendere alla grande mole di internauti attivi sul web l’invito a riflettere sulle gravose condizioni di lavoro degli operai della Foxconn con sede a Taipei, che produce i componenti per i prodotti Apple.
NON SOLO TECNOLOGIA – Steve Jobs è stato senza dubbio un uomo in grado di creare e sfruttare una forma di potere, di influenza, che va ben oltre i prodotti e l’economia. Anche noi del Caffè Geopolitico vogliamo ricordare Steve Jobs e, senza cadere nella retorica sensazionalista e melensa, vi parliamo del leader carismatico che comprese, primo fra tutti, che l’innovazione è il nodo sostanziale per lo sviluppo e avviò una rivoluzione informatica e tecnologica senza precedenti, forza motrice della crescita negli Stati Uniti, in Giappone e nelle nuove potenze economiche asiatiche, prime fra tutte la Cina, il Sud Corea e l’India.
Quando parliamo di “rivoluzione informatica” che fa impennare i titoli nei mercati azionari e il PIL dei paesi industrializzati ancora nella fase più acuta della crisi economica globale, non ci riferiamo alla mera innovazione dell’hardware e del software, ma ad una “faccia del potere” poco manifesta, eppure incisiva e penetrante, capace di condizionare ed influenzare le preferenze nel mercato.
Parliamo del soft power esercitato da chi questa rivoluzione l’ha guidata; parliamo di innovazione nell’ambito della comunicazione, della trasmissione, della partecipazione, della diffusione e dello scambio di informazioni, di modelli culturali e di marketing, mediante un nuovo schema di linguaggio; parliamo di potere dell’attrattiva e della seduzione, quindi di estetica e culto delle forme, del potere del “marchio” come elemento uniformante e democratizzante, capace di annullare confini territoriali, talvolta di rompere barriere sociali e culturali.

QUALE RIVOLUZIONE? – La “Steve Jobs Revolution”, in un’epoca di globalizzazione dell’informazione, è molto più che una rivoluzione informatica, è una rivoluzione sociale e culturale, un nuovo modulo di marketing e di business, un efficace stile di leadership organizzativa per la nuova società post-industriale.
Chi altri era Steve Jobs, se non un leader ammaliatore, capace di coniugare intelligenza e disciplina emotiva, visione creativa e strategia organizzativa, negoziazione e fidelizzazione, comunicazione simbolico-personale e retorica pubblica?
Il padre della Apple, con il suo intuito e la sua lungimiranza ha sfruttato più di ogni altro quello che gli analisti politici definiscono “smart power”, un mix di risorse di soft e hard power, di comando e persuasione, che distingue un vero leader da uno fasullo, in grado di prevedere lo sviluppo delle tendenze nel mercato, quindi di accrescere le opportunità di capitalizzazione sopra le stesse.
È questo elemento innovatore che ha reso la Apple un attrattore globale in grado di orientare le preferenze dei clienti in tutto il mondo, anzi di sviluppare una cultura di leadership del marchio, una sorta di “must-have-icona”.
Il successo dell’i-Pod e il correlato software i-Tunes, uscito dopo altri lettori mp3, sono un esempio lampante del potere di atrattiva della Apple, così forte da consentirgli di costruire da sè le preferenze, tale è ormai il legame di identificazione tra l’aspirazione del cliente e l’influenza esercitata dall’attrattore. “Non puoi solo chiedere ai clienti che cosa vogliono e poi provare a darglielo. Per quando l’avrai costruito, vorranno qualcosa di nuovo”, chiosava spesso Steve per spiegare la sua “filosofia” di managment.
COMPLESSITA’ vs SEMPLICITA’ – Jobs fu un precursore senza pari perchè comprese che in un contesto globalizzato che favorisce la costruzione di società anomiche e atomizzate, quindi la sovrapproduzione di modelli di riferimento pleonastici, andava reinventato un nuovo linguaggio semplificatore “a togliere”, un “Apple speaking”, sobrio ed essenziale nella linea del design e nella comunicazione, che solo ai più distratti appare come una “non-comunicazione”.
Tutti noi, consapevoli o meno, attivamente o di riflesso, simpatizzanti o detrattori, siamo figli di questo Apple speaking che ci ha insegnato a parlare Steve Jobs.
E proprio ora, indecisi se scrivere di lui al presente o al passato, ci sovviene che possiamo fare ancora qualcosa per l’uomo del “Think different!”, per quel “visionario del futuro” che ha liberato il potenziale rivoluzionario del mercato digitale e della potenzialità comunicativa dei suoi prodotti.
“I want to put a ding in the universe”: senza dubbio, Jobs ha lasciato un segno nell’Universo.
M. Dolores Cabras