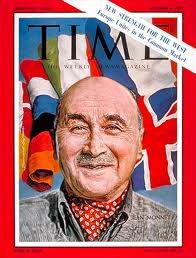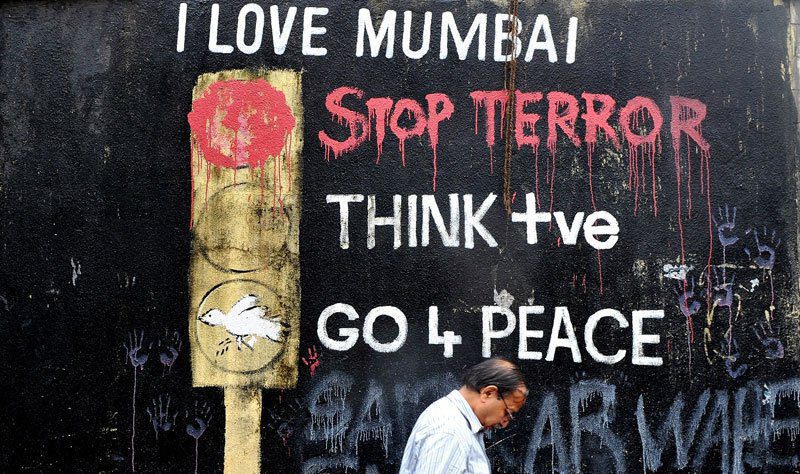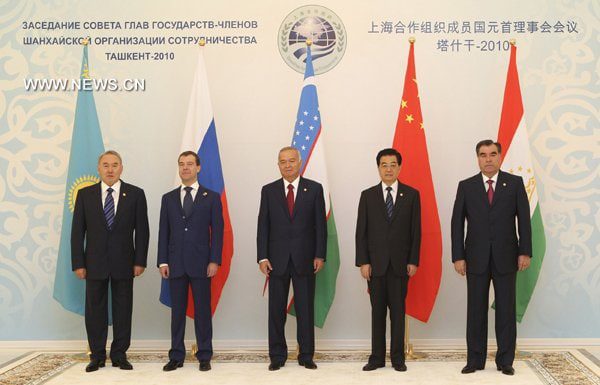Le forze armate cinesi appaiono nel mezzo di una forte svolta innovativa: nuovi sistemi d’arma, sviluppo di tecnologie moderne e perfino produzione di portaerei. Molte di queste novità non avranno effetti immediati, tuttavia vengono monitorate attentamente. Tutte queste mosse infatti ci dicono molto sui progetti e gli interessi geopolitici e strategici futuri di Pechino
SEA DENIAL – Partiamo dallo sviluppo missilistico, che si basa sul tentativo cinese di imporre una strategia di “Sea Denial” davanti alle proprie coste e in particolare nel Mare Cinese Meridionale.
Tutte queste aree sono attualmente dominate dalla marina USA tramite le proprie portaerei nucleari (CVN) e i gruppi da battaglia che le scortano. L’impiego di questi mezzi consente infatti agli USA di mantenere in zona una forte potenza di fuoco tramite i cacciabombardieri imbarcati sulle portaerei e i missili cruise sui vascelli minori di scorta (incrociatori, fregate, cacciatorpedinieri), fino alla possibilità di controllare l’aria (caccia da superiorità aerea, missili antiaerei) e il mare sottostante (sommergibili di scorta, navi ed elicotteri antisommergibile).
Per la Cina esistono solo due modi per eliminare questa influenza straniera che di fatto impedisce a Pechino il controllo del mare e delle risorse sottostanti: la prima opzione è inviare nell’area le proprie forze aeronavali, che però risultano al momento tecnologicamente inferiori a quelle USA, tanto da non poter competere in uno scontro diretto e non poter mantenere una presenza significativa in zona.
La seconda è impedire anche agli USA di fare lo stesso (Sea Denial). Il principio è semplice e basato su una banale considerazione: la potenza aeronavale USA dipende dalle portaerei, se queste e le altre navi non possono rimanere in zona in un dato tratto di mare, non possono impiegare le proprie risorse aeree e missilistiche e, dunque, cessano di esercitare il proprio controllo.
La creazione del missile balistico antinave (ASBN) Dong Feng-21 D va visto dunque in tale ottica: impiegabile ad elevata distanza dal nemico, è definito un potenziale carrier-killer (ammazza-portaerei) proprio per la sua presunta capacità di poter colpire e distruggere un vascello anche da distanze considerevoli.
PANICO AL PENTAGONO? – La notizia è stata ovviamente presa con la dovuta serietà, ma esistono ancora dubbi riguardo all’effettiva efficacia del Dong Feng-21 D; ne citiamo due, tra i principali: i cinesi non hanno ancora dimostrato di avere sistemi di puntamento avanzati e il bersaglio che si intende colpire è un bersaglio in movimento e anche solo pochi gradi di errore di puntamento possono provocare chilometri di errore alla destinazione; pertanto, a meno di sofisticati sistemi di puntamento e tracciamento, l’arma rischia di essere notevolmente imprecisa. Secondariamente, le portaerei USA sono protette dal sistema antimissile AEGIS trasportato dalle loro navi di scorta, attualmente il più preciso ed avanzato esistente al mondo e le cui caratteristiche assicurano grande affidabilità.
UNA GUERRA DI NERVI – In una situazione dove poche sono le certezze, quello che conterà non sarà tanto la reale potenza di fuoco (difficilmente si arriverà a uno scontro aperto, specialmente a breve), quanto la capacità di convincere l’avversario di possedere l’arma migliore.
Se la Cina dimostrerà l’efficacia del Dong Feng-21 D o delle sue future evoluzioni come validi carrier-killer, o comunque spaventerà abbastanza gli USA con tale possibilità, il Pentagono sarà costretto a far indietreggiare le portaerei e diminuire quindi il controllo sul Mar Cinese Meridionale e zone limitrofe, aprendo il controllo alla marina di Pechino.
Se invece la Cina non riuscirà a convincere i propri avversari oppure gli USA avranno migliorato i propri sistemi antimissile tanto da parare anche questa nuova minaccia, allora le portaerei rimarranno e la Cina continuerà a trovarsi in svantaggio.

AEREI STEALTH – A questi discorsi si sommano anche le migliorie nell’aviazione, con la recente notizia dello sviluppo del primo caccia stealth cinese, il J-20. Anche in questo caso l’obiettivo è ridurre il gap con le controparti USA, indispensabile per le proprie mire strategiche nella regione; si dubita però che la Cina abbia sviluppato una tecnologia stealth paragonabile a quella occidentale, per quanto ciò non sia da escludersi. Inoltre per ora si tratta solo di un prototipo ottenuto tramite parziale reverse-engineering di un caccia USA caduto. In generale in una corsa agli armamenti la Cina parte già da una posizione svantaggiata, trovandosi sempre a rincorrere l’avversario; va detto però che i problemi economici USA e i tagli ai budget militari (inclusa la riduzione del progetto per i nuovi cacciabombardieri Joint Strike Fighter F-35) riducono la capacità statunitense di progredire allo stesso ritmo.
PORTAEREI – La questione più importante torna però ad essere quella delle portaerei. La Cina ha ricevuto nell’ottobre 2010 la vecchia portaerei russa Varyag e secondo le dichiarazioni dei propri portavoce intende modificarla e impiegarla come modello per la costruzione di propri vascelli analoghi.
Anche in questo caso non si osserva una semplice escalation degli armamenti ma la ricerca di una soluzione a questioni ben precise.
Pechino sta aumentando la propria influenza in aree geografiche dotate di risorse naturali a lei favorevoli (tra le altre, vari paesi africani per la terra coltivabile e i minerali, Sudan e Libia per il petrolio), dove le distanze impongono un elevato impegno commerciale marittimo. Risulta dunque necessario garantire il controllo del mare. Attualmente questa necessità si concretizza nel rendere sicure le rotte commerciali dai pirati, come nella regione del Corno d’Africa, dove infatti alcuni vascelli militari cinesi per la prima volta operano lontano dalle proprie coste.
In futuro tuttavia la Cina dovrà essere in grado di poter difendere i propri interessi anche in caso di conflitti contro altri paesi o situazioni di seria crisi internazionale. La presenza militare dunque risulta fondamentale per proiettare la propria forza lontano da casa e garantire l’indipendenza dei propri rifornimenti. Come già indicato, nel mondo moderno la superiorità navale arriva dall’impiego di risorse aeronavali mobili che sono definite principalmente dall’impiego di portaerei. Ecco dunque spiegato l’acquisto della Varyag e dei progetti futuri: Pechino sa che prima o poi potrebbe avere bisogno di proteggere i propri interessi lontano dall’Asia orientale; pertanto punta fin da ora ad attrezzarsi per poter affrontare queste sfide. A questo va legato l’interesse a stringere accordi per l’ottenimento di diritti di sfruttamento di basi navali e di monitoraggio (militari e non) lungo l’Asia sud-orientale e attorno all’Oceano Indiano, come visto nell’articolo “La strategia del filo di perle”. Ogni flotta, per quanto potente, ha infatti bisogno di basi adeguate per il rifornimento e l’appoggio logistico. E la mano cinese sta creando le premesse per far operare le proprie navi sempre più lungo quelle rotte che risultano di maggiore valore strategico verso occidente.
NESSUN CONFLITTO A BREVE – Non è realistico immaginare seri conflitti a breve. Oltre a un’inopportunità politica ed economica, le innovazioni e i piani di ammodernamento messi in atto vanno viste sul medio-lungo termine; le forze armate cinesi sono infatti ancora caratterizzate da grandi numeri ma scarso equipaggiamento e qualità. L’obiettivo è sicuramente quello di ottenere almeno un nucleo di forze altamente addestrate ed equipaggiate, tuttavia Pechino dovrà sfruttare ancora per vari anni un approccio di quantità contro qualità. Da parte loro gli USA non possono impedire fisicamente alle navi cinesi di assumere atteggiamenti aggressivi, tuttavia hanno ancora un enorme vantaggio tecnologico che consente loro di mantenere la supremazia. Sicuramente però la corsa agli armamenti in Asia orientale appare solo appena iniziata e nel prossimo decennio gli equilibri potrebbero almeno parzialmente modificarsi. La Cina ora è ancora indietro, ma sta dimostrando la capacità di sviluppare una propria industria bellica indipendente e avanzata, e avere obiettivi chiari su come impiegarla.
Lorenzo Nannetti