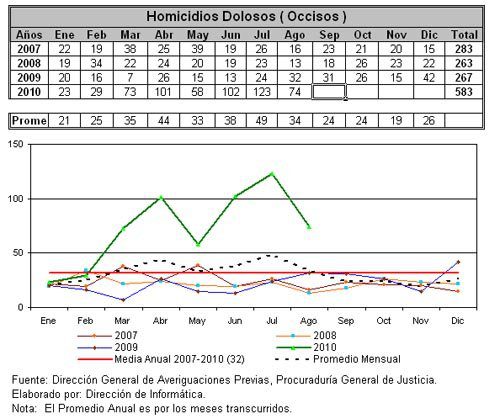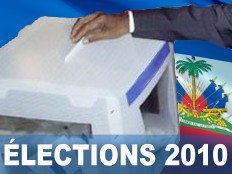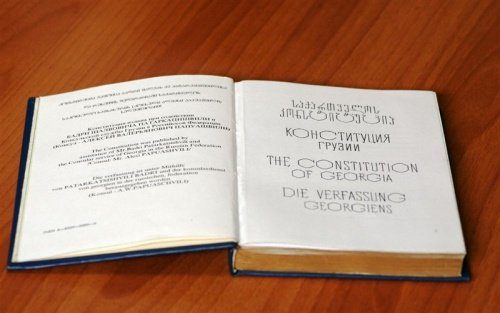Anche il Giappone cade nella trappola di Wikileaks: questa volta non si parla di primi ministri stanchi o dediti a festini, o ancora di scandali sulle forniture di gas. Nel mirino del sito di Julian Assange sarebbe l’incidente diplomatico avvenuto tra Cina e Tokyo per la rivendicazione delle isole Sengaku e delle acque territoriali, dopo i fatti dello scorso settembre.
BUFERA WIKILEAKS – Il Primo Ministro giapponese Naoto Kan ha disposto dei provvedimenti legislativi, votati dal suo gabinetto, a seguito della falla nel sistema informativo causata dalla fuga di notizie riguardanti un video pubblicato su internet lo scorso settembre. Il materiale multimediale ritraeva la collisione avvenuta tra il peschereccio cinese e le due motovedette della Guardia Costiera giapponese in ricognizione nell’area territoriale marittima delle isole Sengaku, che aveva già interessato abbondantemente l’opinione pubblica mondiale e creato diversi screzi diplomatici tra Cina e Giappone. L’incidente, sul quale si è dibattuto molto, è stato considerato da alcuni come una mossa provocatoria giapponese nei confronti della Cina, ed aveva portato poi all’arresto del capitano del peschereccio cinese e all’incrinarsi dei rapporti economici tra i due paesi. Il Giappone ne è stato poi fortemente danneggiato, in particolare a causa della sua stretta dipendenza dal vicino cinese per il rifornimento di alcune materie prime utili, tra le altre cose, all’implementazione del settore tecnologico. Il videoclip riguardante la collisione tra le due motovedette e il peschereccio, della durata di 44 minuti, era stato pubblicato su You Tube nei primi giorni di novembre da parte di un membro della Guardia Costiera giapponese, che tuttavia non era stato implicato nella collisione, ma che aveva avuto accesso alle informazioni governative sull’incidente.
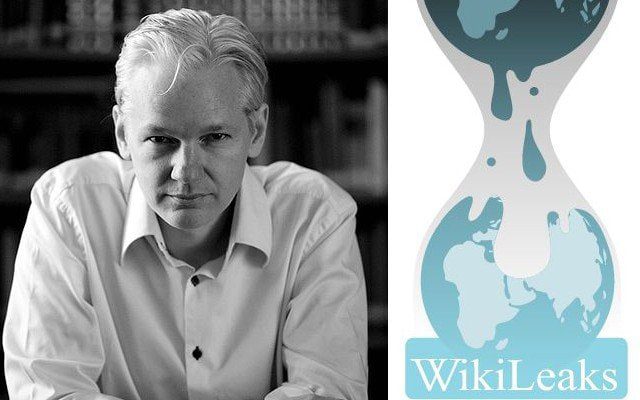
LA RISPOSTA DI TOKYO – Il governo giapponese, dopo la bufera diplomatico-mediatica scatenata da Wikileaks e che ha sconvolto, insieme a Tokyo, l’intera politica mondiale, ha votato alcuni provvedimenti, in data 7 dicembre 2010, per spingere verso un forte impegno da attuare tramite misure legislative e dell’intero sistema statale. L’obiettivo è fare in modo che le informazioni vengano gestite in maniera differente e più oculata. La decisione è stata presa dopo il primo incontro governativo per il miglioramento della gestione delle informazioni, in base a quanto ha affermato Yoshito Sengoku, il segretario del capo di gabinetto. “Negli ultimi anni, l’informazione tecnologica e la diffusione dei social network hanno avuto uno sviluppo molto significativo, e questo meeting è la risposta concreta a questo tipo di cambiamento nell’ambito dell’informazione”, ha affermato Sengoku, referente del summit, che rimasto aperto anche alla presenza di giornalisti. L’incontro ha condotto alla stesura di alcune proposizioni da mettere in atto per la prossima primavera. Dopo il meeting, Sengoku ha tenuto una conferenza sul diritto all’informazione e sulla libertà di stampa, come elementi basilari della società moderna, ma, come ha poi affermato, “è necessario che siano effettuate alcune restrizioni”. C’è chi dichiara la possibilità che vengano applicate alcune limitazioni da parte del governo in merito alla diffusione di informazioni ufficiali: a latere sono dunque nate molte perplessità sia sull’efficacia dei provvedimenti, che sulla loro legittimità. A seguito della collisione, Sengoku si era fortemente opposto alla pubblicazione di materiale sensibile, ed era stato sottoposto a diverse pressioni durante le ultime settimane con l’intimidazione di dover lasciare il suo incarico governativo: l’opposizione gli ha contestato di aver ridotto in qualche modo la libertà di informazione, mentre la sua parte politica di non essere stato particolarmente cauto e di aver fatto trapelare informazioni sensibili.
Alessia Chiriatti
redazione@ilcaffègeopolitico.net