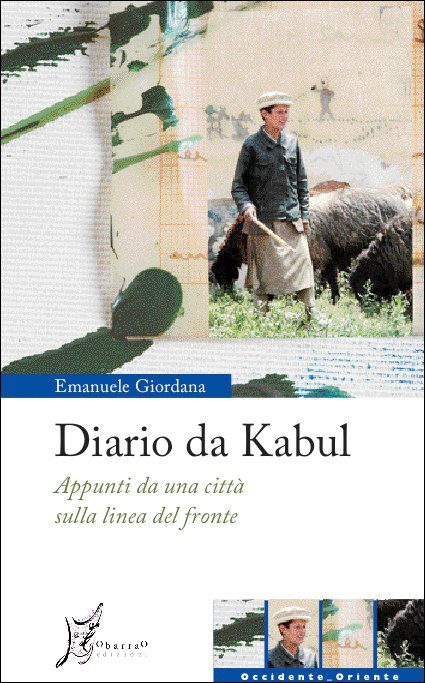È Naoto Kan il nuovo premier giapponese. 63 anni, già vice premier e Ministro delle Finanze del governo uscente, co-fondatore e vice presidente del partito Democratico giapponese. Sostituisce Yukio Hatoyama, dimessosi il 4 giugno, in vista del voto della Dieta, che ha decretato il cambio di guardia ed un nuovo esecutivo. Il gradimento di Hatoyama era sceso al 17% dopo soli otto mesi di governo, da quando, vinte le elezioni in agosto, aveva mandato all’opposizione i Liberaldemocratici dopo una supremazia incontrastata di 54 anni.
UNA CADUTA INESORABILE – Hatoyama ha annunciato bruscamente le sue dimissioni dopo il fallimento che l’ha visto coinvolto nella risoluzione riguardante la base americana di Futenma, ad Okinawa. A peggiorare la sua posizione, alcuni scandali finanziari che continuavano a perseguitarlo. Si è dimesso anche il numero due del partito dei Democratici, Ichiro Ozawa. Uno scivolone che ha solo messo i ripari ad una definitiva sconfitta, in previsione delle elezioni per il rinnovo del Senato a luglio.
Hatoyama si era scusato, ritenendosi addolorato, per non essere riuscito a trovare una soluzione migliore che trasferire la base militare statunitense dalla popolosa città di Ginowan verso la zona costiera e poco abitata di Capo Henoko, a Nago, ma sempre ad Okinawa. La giustificazione dell’importanza di mantenere sul proprio suolo uno scudo americano contro le potenze nord coreane e cinesi non convince più né la popolazione, né probabilmente la comunità internazionale (nella foto sotto alcune proteste popolari), nonostante il recente affondamento della corvetta sudcoreana. Hatoyama ha d’altronde deluso la presidenza statunitense, mancando l’impegno preso con Barack Obama e Hillary Clinton di risolvere la questione militare entro il 31 maggio. Queste mosse hanno inevitabilmente screditato l’immagine del Giappone non solo dinanzi agli Stati Uniti, ma anche di fronte agli attori mondiali.
L’IRA DI KAN… – Kan è il 94esimo presidente del Giappone, ed eredita un governo traballante, senza un appoggio popolare saldo. L’elezione di Kan era dopotutto scontata: il suo appoggio nella Camera Bassa era considerevole, dove è stato eletto con 313 voti. Alla Camera Alta, ha totalizzato 123 preferenze. Il nuovo premier è noto per le sue idee conservatrici in ambito economico-finanziario, per la sua propensione ad uno yen debole, ma le sue priorità saranno quelle di risanare l’ingente debito pubblico che attanaglia il paese, così come applicare politiche demografiche per fermare il costante invecchiamento della popolazione nipponica. E ancora: la sua preoccupazione è lavorare fianco a fianco con il corpo giudiziario e con i membri del suo esecutivo, in vista della formazione del nuovo governo prevista per martedì, e non per giovedì, come aveva precedentemente affermato.
…NUOVO CORSO – Il Giappone ha uno spudorato bisogno di dare alla propria politica una nuovo volto. Un maquillage di cui Kan, un self-made man, una rarità per la politica nipponica, dovrà prendersi carico. Naoto è un pacifista, in linea con la vecchia scuola della tradizione di sinistra. Già nel 2003, prese le distanze dall’impegno in Iraq, ritenendo la decisione di inviare delle truppe un calcolo politico sbagliato. Segno che non vuole entrare in discussioni pericolose riguardanti obiettivi sensibili con i propri alleati. La base di Futenma, adesso, rappresenta un precedente al quale guardare con discrezione: gli elettori non si faranno più raggirare con facilità, e il patto con il potere per Kan non è affatto semplice.
Alessia Chiriatti