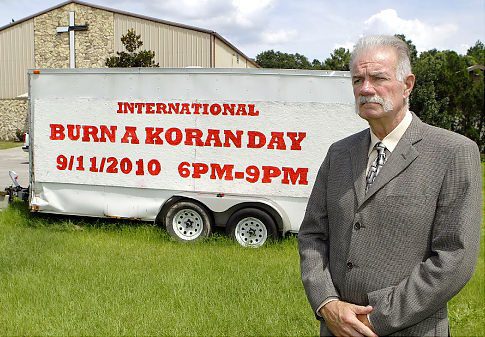La volata per la leadership del Labour Party britannico è prossima al traguardo finale e mai come in quest’occasione l’ordine d’arrivo appare difficilmente prevedibile. Tuttavia, la maggioranza degli osservatori accredita un lieve vantaggio a David Miliband, Segretario di Stato per gli Affari Esteri del Governo Brown e grande sostenitore del New Labour di Tony Blair
DECLINO DEL NEW LABOUR – Il progressivo sgretolamento dell’elettorato laburista, certamente una delle principali cause della debacle delle elezioni politiche di maggio ha origine con molta probabilità durante il terzo ed ultimo governo di Tony Blair.
In quel preciso periodo storico la spinta innovatrice del New Labour subiva una graduale battuta d’arresto che con la successione di Gordon Brown sarebbe stata sempre più netta ed inarrestabile.
Un’incapacità di rinnovarsi che ha favorito, oltre al classico astensionismo, anche uno spostamento di voti, un piccolo ma decisivo “travaso” in favore del partito dei Liberal Democratici guidato da Nick Clegg, attuale vice Primo Ministro della coalizione di Governo guidata da David Cameron.
L’obiettivo primario per chiunque coglierà l’eredità di Blair e Brown nella leadership del partito sarà quello di lubrificare gli ingranaggi dando un nuovo e chiaro segnale d’indirizzo politico. Certamente non sarà un compito agevole per lo meno inizialmente quando potrebbero continuare a prevalere all’interno del Labour Party le cosiddette “correnti ideologiche”.
CORSA A CINQUE – I cinque candidati rappresentano al meglio le diverse anime politiche che in questo momento caratterizzano il Partito Laburista.
-
Diane Abbot, prima donna di colore deputata nella storia della Gran Bretagna, ha maturato un’esperienza trentennale all’interno del partito. Nota per aver votato contro la guerra in Iraq è una forte sostenitrice dei diritti umani.
-
Ed Balls, ex Ministro del Tesoro negli anni 2006/2007 ha posto al centro del proprio programma la giustizia e l’istruzione con un occhio di riguardo alla riqualificazione del pubblico impiego.
-
Andy Burnham è probabilmente il candidato meno noto. Nonostante la sua lunga militanza nel partito non ha mai ricoperto incarichi di particolare rilievo. Meritocrazia e abbattimento degli ostacoli sociali sono i suoi cavalli di battaglia.
Ed infine lo scontro “casalingo” tra i fratelli Miliband, probabilmente il più atteso.
David Miliband ha curato il settore comunicazioni dei Labour nella storica campagna elettorale vinta da Tony Blair nel 1997 e nel 2005 è divenuto suo Ministro dell’Ambiente. Come già anticipato ha ricoperto anche il ruolo di Ministro degli Esteri nell’esecutivo di Gordon Brown.
Naturale successore del progetto del New Labour, dovrà vedersela tra gli altri con il fratello Edward Miliband, ex Ministro per l’Energia. Più tradizionalista, Ed vorrebbe riproporre un partito più socialista favorendo maggiori interventi dello Stato sul piano economico.

LA SOLUZIONE DELL’ENIGMA – Le votazioni sono ancora in atto: parlamentari e militanti sono chiamati in queste ore a esprimere la propria preferenza.
Il dubbio sulla leadership ed il conseguente annuncio del vincitore verrà svelato il prossimo sabato durante il Congresso.
Il nuovo leader avrà da subito il compito di presiedere all’annuale Conferenza laburista che si terrà dal 26 al 30 settembre a Manchester. Durante questo importante appuntamento verrà probabilmente svelato il nuovo indirizzo programmatico del partito sia per ciò che concerne l’imminente opposizione al governo sia in vista delle future tornate elettorali.
La domanda che gli elettori del partito si pongono potrebbe essere la seguente: “L’ambizioso progetto di apertura e rinnovamento al quale diede vita Tony Blair avrà un seguito e verrà riproposto sotto una veste rinnovata oppure vi sarà un ritorno ad una maggiore ortodossia laburista?” Difficile a dirsi.
Ad ogni modo non sarà semplice ritrovare quello spirito che 13 anni fa numericamente fece registrare una storica vittoria per la sinistra britannica ma l’obbligo è senza alcun dubbio quello di tentare ogni strada percorribile per ridare linfa ad un partito che, politicamente parlando, pare aver momentaneamente smarrito l’ago della bussola.
Andrea Ambrosino [email protected]