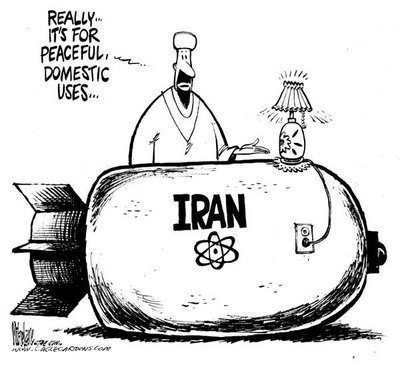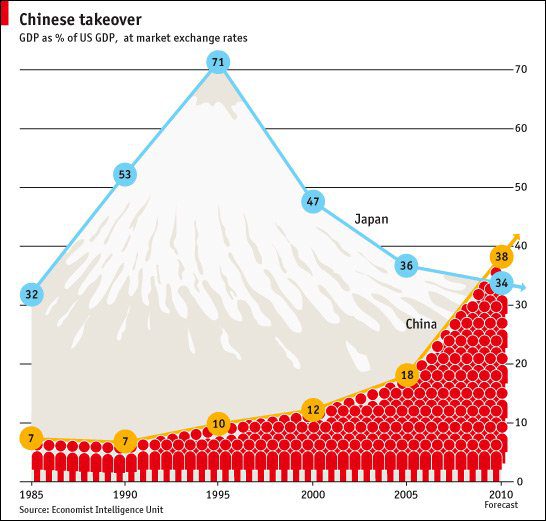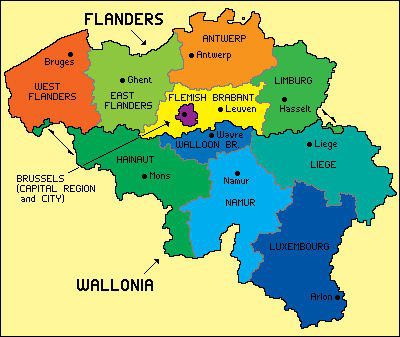Da Città del Messico – Seconda puntata del reportage del “Caffè” sul narcotraffico messicano. In questo articolo parliamo della storia e del funzionamento del cartello della droga più grande, quello di Sinaola. Un’organizzazione criminale potentissima e molto estesa, che si è accresciuta negli ultimi anni in seguito alla lotta dichiarata dall’attuale presidente messicano nei confronti dei trafficanti di droga. Le istituzioni tuttavia, al fine di debellare la maggioranza dei cartelli e di ridurre il caos nel Paese, si dimostrano più tolleranti nei confronti dei sinaloensi.
CHAPO GUZMÁN – Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, capo dei capi del Cartello di Sinaloa, dirige la organizzazione criminale che controlla il 50% del mercato di stupefacenti in entrata negli Stati Uniti, trasporta droga in più di 50 paesi in tutto il mondo e una vasta reti di contatti in Sudamerica, Europa e Australia. Possiede un impero economico di più di un miliardo di dollari che gli ha permesso di essere inserito nel 2009 nella classifica dei miliardari di Forbes, come il 7° miliardario messicano; attualmente è considerato il 41° uomo più potente del pianeta, prima di Sarkozy, Medvedev o Steve Jobs, a soli 4 posti da Osama Bin Laden, con cui condivide la leadership nella lista dei più ricercati al mondo.
LA MULTINAZIONALE SINALOENSE – Tuttavia, la fortuna del Chapo non dipende solamente dalle tradizionali mansioni del Cartello di Sinaloa, traffico di droga e di persone per esempio, ma anche da imprese che svolgono attività consentite dalla legge dove si ricicla il denaro accumulato illegalmente. Secondo alcune ricerche, quasi il 78% dei settori economici messicani sono infiltrati dal narcotraffico; tra le imprese che lavano il denaro sporco del Cartello di Sinaloa si trovano industrie e negozi di vestiti, industrie farmaceutiche e manufatturiere, agenzie immobiliari, aziende agricole, boutique, agenzie di capitali, produttrici di giochi. Dal 2005 l’Ufficio per il controllo dei beni stranieri (OFAC per la sua sigla in inglese) del ministro del Tesoro statunitense ha segnalato ogni anno centinaia di aziende messicane, con conti nelle banche americane, nelle quali investiva il Cartello di Sinaloa. Per esempio, nel 2007 la OFAC congelò a 19 industrie messicane che erano controllate da Blanca Margarita Cázares, sorella del luogotenente più importante di Ismael El Mayo Zambada, principale socio del Chapo.
Il Cartello di Sinaloa, come tutte le moderne cosche, si struttura secondo gli schemi di una multinazionale, con amministratore generale, dirigenti, eccellente tecnologia, alleanze strategiche con altre organizzazioni, cicli di finanziamento, programmi di espansione, attività di reclutamento, controllo di qualità, settori di relazioni pubbliche e riscossione tasse, organi interni di controllo e vigilanza. In questo modo si garantiscono la continuità delle loro attività in Messico e nel resto del mondo, secondo quanto segnala il Dipartimento di giustizia e del Tesoro americano. Si stima che solamente nelle attività illegali del Cartello di Sinaloa vi lavorino quasi 250.000 messicani, senza contare i funzionari pubblici legati indirettamente al narco: in quasi il 60% dei comuni del Messico vi lavora gente impiegata del crimine organizzato.
POTERE REALE – Secondo il giornalista Diego Enrique Osorno, il Cartello di Sinaloa è uno dei poteri di fatto del Messico, illegale ma con il quale tutte le autorità di governo devono fare i conti quando amministrano il territorio, visto che da quasi 80 anni esiste con reti di penetrazione sociale, politica, economiche e culturali molto forti. In effetti, diversi uomini del Partido de Acción Nacional (PAN), al potere ultimamente dopo 70 anni di PRI, si sono spesso distinti per i diversi vincoli con il Cartello di Sinaloa.
Nel gennaio 2001, solo 50 giorni dopo che Vicente Fox si era instaurato a guida del Messico, il Chapo Guzman, detenuto dal 1993, riesce a scappare dal carcere di massima sicurezza di Puente Grande, vicino a Guadalajara. Vengono accusati 70 funzionari del carcere tra cui il direttore Leonardo Beltrán, amico personale di un membro del gabinetto di Fox, Miguel Ángel Yunes Linares, attuale direttore dell’istituto pensionistico messicano, il quale invece è considerato, con il consistente aiuto di Enrique Pérez Rodríguez, vice direttore dell’area che gestiva il sistema penitenziario federale, il referente politico della fuga. Questi due personaggi, con l’aiuto di amici e parenti funzionari dello Stato in altre aree, avrebbero coperto il piano di evasione del Chapo, che fu messo a loro conoscenza alcuni mesi prima grazie alla denuncia su un piano di fuga da parte di un interno, archiviandola e non permettendo la ricollocazione del pericoloso narcotrafficante. Jorge Tello Peón, attuale direttore del Sistema Nazionale di Sicurezza Pubblica, fu l’ultimo funzionario a vedere il Chapo, prima che scappasse, tal come è stato accertato nel processo penale 16/2001-III. Suo fratello, Ricardo Tello Peón, fu appoggiato dall’allora presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Men, e da un deputato di nome Felipe Calderón, alla candidatura a sindaco di Cancún

LA GUERRA AL NARCOTRAFFICO – Tempo dopo, Calderón viene eletto presidente e scatena una guerra contro i mafiosi del paese, senza però cancellare gi investimenti di fondi pubblici nelle imprese dei familiari del Chapo, come ha denunciato recentemente “El Universal”, segnalando che Jesús y Ofelina Guzmán Loera, fratelli del Chapo, continuano a ricevere finanziamenti da un programma del Ministero dell’agricoltura. Per un vasto numero di commentatori la politica di sicurezza pubblica del PAN avrebbe dimenticato di attaccare il Cartello di Sinaloa. Una radio statunitense, National Public Radio, ha denunciato che dal 2006, anno di arrivo al potere di Calderón, sui quasi 2,600 incriminati per narco, solo il 12% appartenevano ai sinaolensi. Alcuni ufficiali della polizia federale messicana di Ciudad Juarez hanno accusato il governo di attaccare a tutti i cartelli mafiosi, tranne quello del Chapo, soprattutto da quando è entrato l’esercito in città. In effetti, dal febbraio 2008, mese in cui arrivò l’esercito, il governo federale annunciò la incriminazione di 88 membri del Cartello di Juarez mentre denunciò solamente 16 persone del cartello di Sinaloa. Nello scorso febbraio, anche membri dello stesso PAN hanno cominciato a storcere il naso verso la politica contro il narcotraffico di Calderón. Il deputato Manuel Clouthier Carrillo ha accusato il presidente di aver attuato una politica che non avrebbe fatto altro che abbandonare a sé stesse alcune zone dello Stato, permettendo così ai narcos di consolidare il loro potere e proteggendo personaggi potenti come il Chapo.
Andrea Cerami