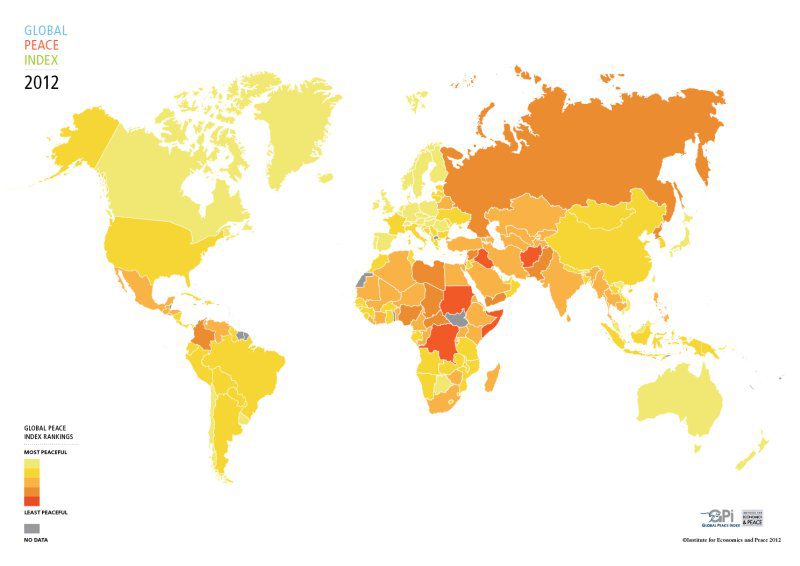Alla vigilia delle elezioni per l’Assemblea Costituente della Libia del post-Gheddafi, il Caffè Geopolitico vi offre una preziosa intervista ad Arturo Varvelli, Resarch Fellow presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, tra i massimi esperti delle relazioni italo-libiche. In uno scenario in cui il CNT cerca disperatamente il riconoscimento e l’appoggio della comunità internazionale, si può sperare nella continuità della special relationship tra Roma e Tripoli?
Molti osservatori, già durante l’intervento della NATO, ritenevano che il nostro paese potesse perdere i vantaggi economici guadagnati grazie ai rapporti con il passato regime, a quanto ci risulta, l’ENI sembra invece aver mantenuto tutte le concessioni ottenute prima della guerra. Ad oggi quali sono gli scenari delle relazioni italo-libiche?
“La situazione attuale delle relazioni bilaterali tra i due paesi è molto complessa, non tanto perchè l’Italia incorra in eventuali rischi nell’immediato, non credo sia questo il caso, ma poiché in prospettiva qualcosa potrebbe effettivamente cambiare. Il destino dei legami politico-economici costruiti fino a questo momento dipende necessariamente da chi riuscirà a salire al potere nei prossimi mesi. Quello che non potrà variare, nemmeno negli scenari più bui, è la forte complementarietà economica tra i due paesi, esportatore di greggio il primo, acquirente bisognoso di risorse energetiche il secondo. Questo è un legame storico e duraturo che permane ormai da più di quarant’anni, la Libia ha grande convenienza ad avere un compratore sicuro e qualificato, disponibile a pagare l’oro nero più di altri, come l’Italia. L’Italia non può fare a meno di vicini, sulla sponda sud del Mediterraneo, ricchi di petrolio e gas, per questo proprio la complementarietà dei due sistemi sarà nuovamente la base su cui costruire il futuro comune dei due attori. L’ENI ha saputo gestire la situazione al meglio, rifornendo di petrolio tramite le sue strutture entrambi gli schieramenti fino alla fine del conflitto, contribuendo ad assicurare la continuità energetica all’intero paese. Sicuramente in vista di concessioni future potrebbero cambiare i pesi specifici delle varie compagnie, ma questo è ancora tutto da dimostrare.”
Rapporti ufficiali confermano volontari e armi in movimento dalla Libia alla Siria. Quanto il governo di transizione potrebbe favorire questo processo per allontanare eventuali elementi “problematici”?
“Personalmente non credo che l’attuale governo libico possa spingersi fino all’intuizione di offrire un’altra battaglia da combattere alla moltitudine di milizie armate presenti sul territorio, tuttavia questi flussi esistono. Il fatto che alcuni guerriglieri, che potremmo definire jihadisti, abbiano contribuito al conflitto libico per poi passare all’attuale guerra civile in Siria è sicuramente un’ipotesi plausibile, abbiamo casi sporadici accertati, vi sono dei libici che combattono tra le fila dell’Esercito Libero Siriano e armi che raggiungono tale contesto. Proprio il traffico di armi è inviso all’attuale governo di Tripoli, che mostra più interesse alla stabilizzazione della situazione interna rispetto ad un’eventuale solidarietà islamica nei confronti della popolazione siriana. Storicamente la Libia è nota come bacino di arruolamento di guerriglieri che hanno combattuto sul versante iracheno e ancora oggi in Afghanistan, tuttavia tale fertilità per i germogli della jihad islamica era dovuto al fatto che il regime gheddafiano si è sempre opposto alla diffusione di tali ideologie estremiste, mostrando una repressione violenta. Per i cirenaici in particolare, l’unica forma possibile di dissenso era la via della jihad all’estero, con l’eventualità di combattere in futuro la guerra contro il regime.”
Da sempre Tripoli e Bengasi si contendono lo scettro di capitale morale della Libia, ma in seguito alle recenti vicissitudini e i rispettivi “assedi”, sembra che anche Misurata e Sirte inizino a covare una pesante ostilità. Esiste dunque il rischio di una deriva localistica da un’unità nazionale compromessa, che sembra aver perso l’unico collante identitario?
“Sicuramente tale rischio esiste, tant’è che durante il conflitto le due parti sembravano corrispondere ai classici schieramenti di Tripolitania e Cirenaica, in uno scontro che va avanti da tempo. D’altra parte esistono naturalmente localismi e formazioni identitarie legati a fazioni regionali, a tal proposito, nelle ultime settimane la situazione sembra essersi lievemente stabilizzata, se si esclude da tale considerazione il sud. Il Fezzan e buona parte dei territori meridionali sono ancora una grande incognita, di cui conosciamo poco, anche a causa dell’assenza di resoconti dei media, si sono registrati molteplici episodi violenti, compresa la questione aperta con la popolazione di etnia tebu. Insomma quella del sud della Libia è una questione ancora più complessa rispetto alla totalità del sistema paese, vedere un sud pacificato nei prossimi anni sarà molto difficile. A ciò si lega la questione del controllo delle frontiere e del risveglio dei movimenti tuareg, che rende il puzzle ancora più intricato, se possibile. Venendo invece alla Libia più vicina a noi, probabilmente Sirte mostra la condizione più precaria tra le grandi città costiere. Capoluogo di provenienza del clan Gheddafi, la città ha subito un assedio lungo svariate settimane che non ha risparmiato i suoi abitanti dai regolamenti di conti e dalle faide etniche. Attenzione anche alla periferia di Tripoli, compreso l’aeroporto, scenario di svariati scontri armati tra le fazioni che regnano sovrane su alcuni quartieri della città. Sembra tuttavia che per il momento le milizie abbiano trovato una sorta di accordo per la convivenza pacifica, naturalmente precario e basato sulla gestione della forza da parte dello stato centrale.”

I continui ritardi nel fissare la data delle elezioni per l’Assemblea Costituente possono essere attribuibili alle difficoltà collegate proprio alla questione della legittimità del governo in carica e dell’effettivo controllo del territorio?
A livello ufficiale lo spostamento della data delle elezioni al 7 luglio era dovuto al processo di revisione dei ricorsi pervenuti dai vari candidati, ma sicuramente una grossa fetta del problema è costituita dalle ragioni menzionate. Senza dubbio vi sono inoltre motivazioni relative al contrasto e allo scontro tra le varie forze del paese, non solo fazioni armate dunque, ma veri e propri gruppi di potere. Ma è soprattutto il Consiglio Nazionale Transitorio che gioca a tenere il piede in due scarpe, conscio della precarietà della propria permanenza al governo. Da una parte dimostra di avere la necessità di indire al più presto elezioni libere e democratiche, perchè la comunità internazionale lo pressa, perchè i cittadini libici lo chiedono con forza, d’altra parte è consapevole che ciò vorrebbe dire rinunciare, in parte o del tutto al potere. Proprio per questo è facile sollevare dubbi su quanto veramente il CNT abbia spinto per arrivare senza intoppi alla data del 7 luglio. Come spesso accade, è difficile che chi detiene saldamente il potere possa lasciare il trono senza ‘combattere’.”
Oltre alla formazione locale della Fratellanza Musulmana e alcuni circoli accademico-liberali a livello locale, la situazione delle forze politiche in campo sembra alquanto confusa. Quali sono le formazioni politiche da osservare con maggiore attenzione alla vigilia della tanto attesa chiamata alle urne?
“Questo è il nodo principale della questione, ovvero a chi andrà in mano il paese e quale destino seguirà l’unità nazionale della Libia. Credo che le lessons learned dalle recenti transizioni in Tunisia ed Egitto possano mostrare qualche tratto del futuro della Libia post-Gheddafi, con l’ascesa delle forze che si rifanno all’Islam politico. Naturalmente le tradizioni dei tre paesi hanno caratteri incomparabili e peculiari, ma l’ultima volta che i libici hanno votato con qualche criterio di trasparenza ed effettiva libertà è stato con le elezioni del 1952, per questo permane una scarsa attenzione a quelle che sono le dinamiche della democrazia partecipativa. Sicuramente non bisogna attendersi un cittadino libico che si reca alle urne con le stesse sensazioni di un qualsiasi elettore occidentale, le richieste e le ispirazioni legittime sono senza dubbio differenti. Per quanto riguarda le forze in campo, i grandi indirizzi sono dunque quelli che legano le aspirazioni di democrazia, libertà e giustizia alla tradizione islamica, come appunto le formazioni filiali della Fratellanza Musulmana, quelle attorno alla figura carismatica di Ali al-Sallabi, religioso molto riconosciuto in Libia. Attenzione anche ad Abdelhakim Belhadji e al suo partito conservatore Al Watan, comandante del Lybian Islamic Fighting Group, noto oltretutto per le sue imprese in Afghanistan e Pakistan. Quello che ci si attende è quindi una sorta di convergenza da questi tre nuclei di forza politico-religiosa, mentre le forze ‘laiche’ vivono della popolarità delle figure che abbiamo visto nel ruolo di traghettatori in forza al CNT. Mi riferisco in particolare ad Ali Tarhuni e agli altri ‘tecnocrati’ che dagli Stati Uniti, dall’Inghilterra e da altri angoli dell’Occidente hanno fatto ritorno in Libia. Tuttavia pesare con efficacia la popolarità di queste figure tra la popolazione è un discorso alquanto problematico dato che quello del 7 luglio sarà il primo ‘test’ per tutti, partecipanti e osservatori compresi.”
Tra le clausole dell’accordo italo-libico, siglate durante il precedente governo, il colosso italiano Impregilo aveva ottenuto l’appalto per la costruzione di opere ed infrastrutture per il progresso della Libia. Crede che tale appalto giungerà comunque a conclusione nonostante le attuali condizioni d’instabilità?
“Questa vicenda ci riporta nuovamente al futuro delle relazioni tra l’Italia e la Libia e in particolare al destino del trattato italo-libico. Quell’accordo è stato, nel silenzio più totale dei media, riattivato durante il vertice tenutosi a Roma tra il governo italiano e le autorità del CNT. Tale atmosfera riservata, quasi nascosta all’attenzione dei mezzi d’informazione, rivela un cambio totale di rotta nella gestione della retorica delle relazioni bilaterali con Tripoli. Vista l’avvenuta riattivazione di tale intesa, immaginiamo che occorrerà necessariamente far fronte alle previsioni di tale dettato, se si tratterà di un’autostrada realizzata da Impregilo, è ancora prematuro dirlo, visto che l’esatta definizione dell’appalto richiamava un più generico ‘infrastrutture di base’. Gheddafi aveva bisogno di un gesto simbolico, la costruzione dell’autostrada che andasse a collegare Tripoli e Bengasi, interpretava perfettamente la realizzazione di quel prezzo ‘materiale’ pagato da Roma per le conseguenze del periodo coloniale. I nuovi governanti libici potrebbero decidere altrimenti, come potrebbero benissimo accogliere tale richiesta, dando un segno tangibile del tentativo di mantenere unito un paese che rischia la secessione. Il periodo attuale d’altra parte è il picco massimo dell’incertezza nel dopo-Gheddafi, sicuramente i prossimi mesi lanceranno i primi segnali di un futuro ancora tutto da costruire. Personalmente ritengo molto difficile il realizzarsi, almeno nel breve periodo, di un paese stabile con indirizzi politici chiari e decisi è ancora troppo prematuro, tuttavia sembra che le relazioni tra l’Italia e la Libia potranno proseguire sui binari costruiti sul reciproco interesse nel corso del 2008.”
Fabio Stella [email protected]