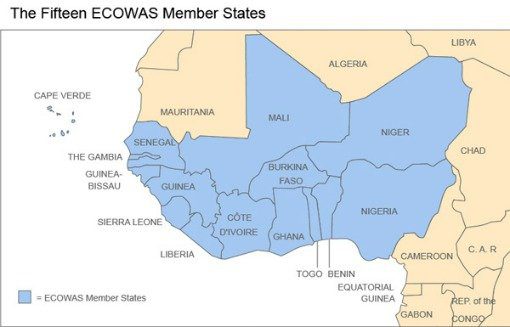Continua l'impasse politica tra Cina e Filippine iniziata dopo la scoperta di alcuni pescherecci cinesi nella secca di Scarborough. La notizia era arrivata a pochi giorni dall'annuncio di un accordo fra Vietnam e Russia per l'estrazione di gas nel Mar cinese meridionale. E la tensione continua a salire
Tratto da “China Files”
IL FATTO – Tutto è iniziato nella giornata di domenica 8 aprile, quando un aereo da ricognizione filippino ha avvistato alcune navi ormeggiate nei pressi della secca di Scarborough, al largo dell’isola di Luzo. Ricevuta la segnalazione, Manila ha inviato – probabilmente intuendo l’importanza politica della situazione – la sua più grande nave da guerra, la Gregorio del Pilar, a controllare le imbarcazioni sospette. Nella mattinata di martedì 10 aprile i militari sono arrivati sul posto e si sono trovati di fronte un piccolo gruppo di pescherecci cinesi. Perquisendoli, avrebbero trovato pescecani vivi, vongole e coralli. E, fin qui, nulla di così incredibile. Se si fosse semplicemente trattato di pescatori di frodo trovati a girovagare nel Pacifico la notizia non avrebbe certo fatto il giro del mondo. Ma queste non sono acque qualsiasi. Si tratta del Mar cinese meridionale, una delle aree a maggior rischio di conflitto nel mondo a causa di una rivalità latente che vede protagoniste – fra gli altri – proprio le Filippine e la Cina, che reclamano entrambe la sovranità su questo angolo di oceano. E così, quando mercoledì la Gregorio del Pilar è ritornata per mettere agli arresti i pescatori ha trovato una sorpresa ad attenderla. Due navi della guardia costiera cinese si erano appostate davanti all’ingresso della laguna, impedendo fisicamente il passaggio dei militari. STALLO DIPLOMATICO – È iniziata in quel momento un'impasse diplomatica che dura ancora oggi, a distanza di giorni. Da un lato le imbarcazioni cinesi, dall’altro la nave da guerra filippina. E nessuno vuole concedere un centimetro, perché entrambi i paesi sostengono di essere a casa propria e sanno che un passo indietro verrebbe letto come una resa. Manila ha in seguito ritirato la Gregorio del Pilar sostituendola con una guardia costiera, probabilmente nel tentativo di far calare la tensione. Ma il faccia a faccia continua. Non è bastato l’incontro avvenuto martedì tra l’ambasciatore cinese Ma Keqing e il governo filippino, perché entrambe le parti non hanno fatto che riaffermare la propria posizione. Un passo avanti è stato fatto raggiungendo un accordo sulle modalità per risolvere la questione: solo mezzi diplomatici, niente soluzioni militari. Secondo quanto riporta la Reuters, infatti, il ministro degli esteri filippino, Albert F. del Rosario avrebbe dichiarato che “l’uso della forza è fuori questione”. Al di là di questo punto fermo, tuttavia, i toni sono andati salendo sempre di più. Il Global Times (voce dell’ala radicale del Partito comunista cinese) ha pubblicato un articolo nel quale si sostiene che “i pescatori cinesi hanno bisogno della protezione della guardia costiera, incluso l’aiuto in casi di scontro come questo”, aggiungendo che “bisogna aspettarsi una decisa risposta tesa a difendere i propri interessi da parte della Cina”. GLI INTERESSI IN GIOCO – Ma perché il Mar cinese meridionale rappresenta una questione così viva e capace di infiammare gli animi? Perché Cina, Vietnam, Filippine, Malesia, Indonesia, Taiwan e perfino il piccolo Brunei se lo contendono così aspramente? Si potrebbe obbiettare che stiamo parlando – quasi letteralmente – di una serie di scogli in mezzo al mare. Innanzitutto giova ricordare che sotto a quegli scogli si celano vaste riserve di gas e petrolio. Secondo quanto riportato dalla US Energy Information Administration le stime sono molto variabili ma si parla comunque di decine – se non centinaia – di miliardi di barili di petrolio e di miliardi di metri cubi di gas. Vaste risorse che non possono non fare gola a dei paesi in via di sviluppo, bisognosi di sempre maggiori quantità di energia per mandare avanti il loro sistema economico. Ma la questione è più complicata, perché chiama in causa – soprattutto da parte cinese – forti sentimenti nazionalistici. Come ha spiegato durante un discorso tenuto alcuni mesi fa il professor Zhu Feng, direttore del Centro per gli studi internazionali e strategici dell’Università di Pechino, la politica estera cinese è pesantemente influenzata dalla storia coloniale del paese. La memoria delle angherie passate – rinforzata da una buona dose di moderna propaganda – rende l’opinione pubblica poco incline ad accettare qualsiasi soluzione che includa una cessione di territorio. “Non vogliono passare per dei codardi” concluse allora il professore parlando del governo di Pechino. Del resto, gli altri contendenti non intendono cedere la palla alla nascente grande potenza, e si contrappongono in modo altrettanto netto alle ambizioni di Pechino. Del Rosario, quando la notizia del confronto è diventata di pubblico dominio, si è affrettato a dire che “se verranno sfidate, la Filippine saranno pronte a difendere la propria sovranità”. E chi scrive ricorda come un anno fa, durante una cena accademica a Pechino, un professore filippino avesse privatamente inveito contro la politica cinese sostenendo che “a dar retta a loro, si prenderebbero tutto. Dicono che il Mar cinese gli appartiene perché era cinese già secoli or sono. Ma allora la Mongolia, che a suo tempo invase e conquistò l’Impero di mezzo, dovrebbe reclamare tutta la Cina!”.

IMPLICAZIONI GLOBALI – Il caso non è solo una questione locale, un disputa isolata figlia di interessi particolari. Si tratta di un problema con risvolti globali. Un po’ perché attraverso il Mar cinese meridionale passano alcune delle principali arterie del commercio internazionale. Un po’ per via di chi è implicato nella vicenda, cioè molte delle principali potenze mondiali, emergenti e non. Washington, in particolare, ha recentemente rafforzato la propria presenza nell’area del Pacifico installando una base militare a Darwin, in Australia, e ponendo l'accento sulla rinnovata attenzione americana per il continente asiatico. Le Filippine sono uno dei principali partner degli Usa nella regione, tant’è che lo scorso novembre Hillary Cliton, parlando – guarda caso – dal ponte di una nave da guerra nella Baia di Manila, aveva elogiato l’alleanza tra i due paesi. Durante il suo discorso il segretario di stato americano aveva anche menzionato il Mar cinese meridionale, chiamandolo “Mare filippino occidentale”. Un termine che solo Manila utilizza e che certo i cinesi non devono aver gradito. E gli Stati uniti non sono l'unica potenza “esterna” a voler dire la propria nella politica di questa regione. Anche altri sono pronti a entrare nella partita. L’ultimo caso è stato quello degli accordi fra Russia e Vietnam per la ricerca e l’estrazione di gas naturale. Agli inizi di aprile il gigante russo Gazprom ha sottoscritto un accordo con Petrovietnam per l’esplorazione dei cosiddetti “blocchi” 05.2 e 05.3, che dovrebbero racchiudere 55.6 miliardi di metri cubi di gas e 25.1 milioni di tonnellate di gas condensato. Un affare per Hanoi e Mosca. Ma per la Cina è un affronto. Già il 4 aprile, infatti, il China Daily riportava la perentoria dichiarazione di Deng Zhonghua, direttore del Dipartimento per i confini e gli affari oceanici del Ministero degli esteri, secondo il quale “la Cina ha un’incontestabile sovranità sulle isole presenti nel Mar cinese meridionale e sulle acque circostanti”.Il quotidiano, inoltre, accusava il Vietnam di essersi intenzionalmente rivolto ai russi per bilanciare l’influenza della Cina nella regione. E sempre il China Daily, nello stesso articolo, riprende le parole del ministro degli esteri indiano, S.M. Krishna, il quale sostiene che la zona sarebbe di proprietà globale, una terra di nessuno e di tutti. Ma alla Cina anche questa teoria non va giù: l’autore conclude infatti che l’India avrebbe rilasciato tali dichiarazioni con l’intenzione di alzare ulteriormente i toni del dibattito. Insomma, il risultato di queste dinamiche è un incontro e uno scontro nel quale potenze grandi e piccole cercano in ogni modo di difendere i propri interessi particolari. Il tutto senza un sistema atto a prevenire l'esplodere dei dissensi. Questa volta, almeno per i pescatori, tutto è andato bene. Il 14 aprile è giunta la notizia secondo la quale i pescherecci cinesi avrebbero lasciato la secca e sarebbero ritornati in patria. Le Filippine hanno dovuto rinunciare alla requisizione del materiale a bordo delle imbarcazioni, il che significa una sconfitta diplomatica per Manila, che non è riuscita a dimostrare di essere padrona delle acque sulle quali reclama la sovranità. LO SCONTRO CONTINUA – Ma il confronto fra le due guardie costiere non è terminato, e l'evento è una prova di come le tensioni vadano crescendo con il passare del tempo. Questo non è certo un buon augurio, né facilita il dialogo fra i paesi dell'area pacifica. Senza contare che in questo modo si vengono a creare situazioni pericolose. Cosa succederebbe, per esempio, se una delle navi che si fronteggiano in queste ore colpisse accidentalmente la parte avversaria? Data la retorica che circonda il problema, la via della diplomazia sarebbe sarebbe difficile da percorrere. Un’escalation diventerebbe una possibilità più che concreta. E sarebbe un disastro. Questo, si, da condividere tutti insieme. Michele Penna (da Pechino)[email protected]