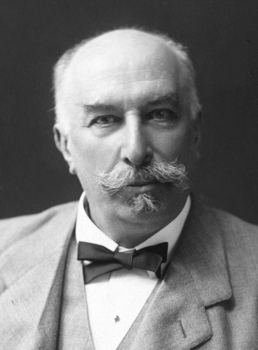Caffè Nero – Torna l’appuntamento con la rubrica “7 Giorni in un Ristretto” dedicata al continente africano. Questa settimana parliamo della ricerca di stabilità politica in Costa D’Avorio, ancora lontana nonostante l’allontanamento dal potere di Laurent Gbagbo, dei vent’anni dalla nascita del Somaliland, Stato “secessionista” dalla Somalia ma ancora privo del riconoscimento internazionale, e ancora di Nigeria, Sudan e Marocco.
COSTA D’AVORIO – Nonostante le elezioni passate, in Costa d’Avorio si respira ancora tanta insicurezza. Le violenze perpetrate prima, durante e dopo le elezioni politiche hanno riaperto vecchie ferite e faide etniche, politiche e religiose facendo aumentare gli sfollati interni e i profughi fuggiti. I crimini di guerra coinvolgono gli schieramenti sia del presidente uscente che di quello in carica. Tutto si muove scandito da senso di vendetta , in cui si mescolano gruppi armati, forze regolari e paramilitari a mercenari e ribelli. La paura viene poi alimentata da voci che circolano e che fanno temere una controffensiva delle reduci forze fedeli a Gbagbo che pare si siano raccolte al confine con il Ghana. Bisogna monitorare come penserà di agire Ouattara, durante il suo mandato, per assicurare una stabilità e pace al paese.
SOMALILAND – Il 18 Maggio si è celebrato il “compleanno” dello stato Somaliland che si rese autonomo separandosi dalla Somalia circa vent’anni fa . L’esistenza di questo stato (nella foto un monumento dedicato all'indipendenza) viene testimoniata grazie alle mappe più aggiornate, ma nessuno ne parla, dato che è privo di riconoscimento internazionale e possiede le caratteristiche delle entità politiche che possono essere comprese nella categoria degli “Stati falliti”. La scommessa di questi neostati è uscire dall’ombra in cui versano. Il Somaliland con la sua capitale Hargeisa, hanno puntato sul consolidamento politico ed economico anche per lasciare alle spalle anni di dure e sanguinose repressioni sotto il regime di Siad Barre. La vicinanza alla Somalia, che nonostante sia inserita in Programmi di sviluppo internazionali, vive una guerra continua e funesta e sprofonda sempre più nel baratro, costringe il Somaliland a lottare con tutte le sue sole forze non solo per cercare di affermare la propria autonomia e solidità, ma soprattutto per sfidare e difendersi dalle proiezioni negative dei vicini.
NIGERIA – Le elezioni sono trascorse, il neo-eletto presidente Jonathan si è insediato, ma le violenze non cessano. Nella Nigeria occidentale una bomba è esplosa provocando decine di morti e ancor più feriti, senza che al momento ci sia stata alcuna rivendicazione. Lo sguardo del nuovo presidente dovrà andare oltre, trovandosi dinanzi il più popoloso stato africano e una rabbia latente pericolosa.

SUDAN – Ottenere la stabilità in Darfur sembra un traguardo irraggiungibile soprattutto se si pone lo sguardo al passato e agli innumerevoli tentativi di pervenire ad un accordo di pace. Dopo le ultime vicende che hanno portato all’occupazione del distretto petrolifero, si è tentata l’ennesima bozza di accordo approvata in Qatar e guidata dal ministro per gli Affari Esteri Ahmad bin Abdullah al-Mahmoud, che vorrebbe l’immediato cessate il fuoco. Le basi sembrano più solide rispetto ai precedenti accordi, ma bisognerà vedere se i ribelli che combattono il governo di Khartoum, siano disposti ad abbandonare le loro riserve. Tale accordo andrà ratificato tra tre mesi, ma lo scetticismo che ciò avvenga è molto alto.
MAROCCO – Continuano le proteste in Marocco in cui si chiedono una ventata di cambiamenti in nome di una costituzione democratica e che il re limiti i suoi poteri. Dal 15 Maggio però si è inasprita la violenza con cui il governo reprime le manifestazioni che soprattutto nella capitale sembrano pacifiche e numerose. il governo, che fino ad oggi aveva mantenuto un'immagine moderata, teme di ritrovarsi dinanzi la violenza delle rivolte dei paese nordafricani.
Nei prossimi giorni dovrebbero essere presentate delle riforme costituzionali che modificherebbero l'attuale status quo e l'intero apparato del potere.
ETIOPIA – E’ stata rinviata la convalidazione del trattato (Cfa) che ridurrebbe la cubatura d’acqua per il Cairo, e la cui ratifica faceva temere una reazione violenta da parte dell’Egitto. La questione delle acque del Nilo resta ancora un nodo difficile su cui bisogna lavorare nonostante il rapporto tra Addis Abeba e Il Cairo riprenda meno aspro. La forza viene soprattutto dall’aumento degli investimenti egiziani in Etiopia. In questo quadro, non bisogna dimenticare la posizione e la funzionalità strategica del Sudan e l’importanza di rivedere i precari equilibri dopo la proclamata indipendenza del Sud Sudan.
Adele Fuccio