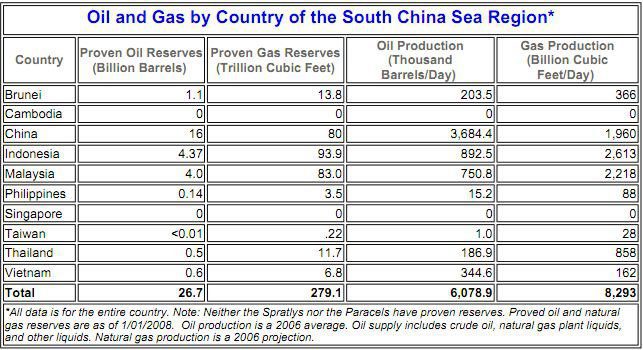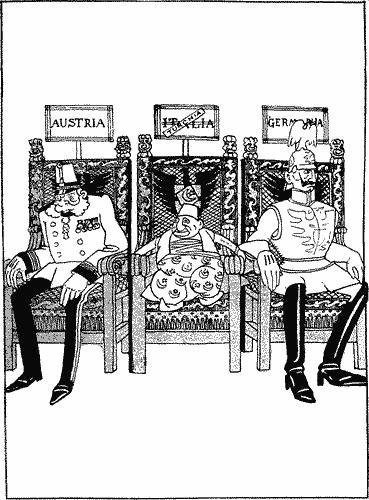Caffè Nero – Ecco il nostro consueto appuntamento che vi propone le notizie più importanti in arrivo dall'Africa. Purtroppo la parola “violenza” sembra essere ancora all'ordine del giorno: sono molti gli Stati dove il rischio di una guerra civile è molto alto. Dalla Costa d'Avorio al Sudan, passando per la Somalia, l'instabilità politica è una costante che sembra non abbandonare mai il martoriato continente africano
COSTA D'AVORIO – Alassane Ouattara alla fine è riuscito ad insediarsi come nuovo Presidente, ma deve rispondere alle sempre più pressanti richieste sia della Corte penale Internazionale che del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di far luce sulle violenze perpetrate durante e dopo le elezioni. Ancora è alto il numero degli sfollati e le forze di Ouattara continuano a commettere abusi e violazioni.
SUDAN – La pace sembra sempre più lontana in Sudan,nonostante proseguano negoziati e moniti internazionali. Piccoli e grandi focolai di violenza si estendono su tutto il territorio In Darfur aumenta l'ondata di violenza soprattutto contro i civili. Nella Juba che aspetta la proclamazione della definitiva indipendenza il prossimo 9 luglio, sono forti i contrasti negli stati dell'Upper Nile e di Unity dove si verificano omicidi e disordini. Intanto si sta decidendo della sorte della regione petrolifera di Abiyei ancora occupata dall'esercito di Omar al Bashir. I leader del Sudan e sud Sudan si sono incontrati ad Addis Abeba per giungere ad una soluzione e per ottenere il ritiro completo dei militari dall'area,ormai completamente sfollata. Ancora una situazione allarmante in Kordofan dove gli scontri tra i soldati di Khartoum e quelli di Juba stanno causando molti morti, al punto da parlare di genocidio e pulizia etnica. E' un momento in cui il secolare potere sudanese deve fare i conti con i cambiamenti geopolitici imminenti e l'ipotesi terribilmente vicina di una nuova guerra civile.
KENYA – Se si legge della pena di morte, si pensa ad un reato grave e non certo alla soluzione per eliminare gli omosessuali. In Kenya però tale richiesta, avanzata dagli esponenti musulmani, sta andando avanti pubblicizzata come unica e giusta punizione per i gay che con il loro orientamento sessuale infrangono la legge islamica.
NIGERIA – Sono aumentati in questi giorni attacchi terroristici da parte di sette islamiche e per alcuni ultimi attentati sono stati accusati gli adepti della setta di Boko Haram. Le violenze si stanno indirizzando non solo ad istituzioni locali, ma anche verso quei leader islamici considerati poco propensi all’uso massiccio della violenza perpetrato dalla setta.
SOMALIA – Il 9 Giugno scorso a Kampala, capitale dell’Uganda, si è raggiunto un accordo che dovrebbe rimarginare una vecchia ferita tra le due massime istituzioni a Mogadiscio, e cioè tra il presidente della Repubblica e quello del parlamento. In base a tale accordo slitta di un anno la data delle prossime elezioni presidenziali e del presidente del Parlamento, allungando cosi di ulteriori 365 giorni l'attuale mandato di governo. Si voterà nell'Agosto del 2012. Quello che bisogna analizzare è la criticità della politica somala con le sue lacune e le sue drammaticità in una Mogadiscio dove si continua a combattere. Non deve mancare di attenzione anche la forza che hanno assunto Uganda ed Etiopia in questi anni, incidendo addirittura nelle valutazioni della comunità internazionale.
BURKINA FASO – Blaise Campaorè, confermato Presidente, si gode la sua vittoria e si è anche proclamato ministro della difesa, ottenendo anche l’appoggio della popolazione. Ma da quando è stato eletto si è già trovato dinanzi a molte questioni da risolvere e in questi giorni ha fatto ricorso, per la prima volta, all'uso della forza per fermare gli ammutinamenti di alcuni militari, che dilagano nel paese.
ZIMBABWE – Robert Mugabe dovrà cedere la poltrona, ma l'instabile vita politica del paese è sempre argomento all'ordine del giorno. Ci sono le visibili opposizioni tra il partito di Mugabe e quello del premier Tsvangirai, ma ciò non deve distogliere l'attenzione dal fronte interno al partito di stato dove gli uomini di partito stanno lavorando per far si che il successore sia il più vicino alla loro corrente. Le prossime elezioni dovrebbero avvenire l'estate del 2012, ma già iniziano a trapelare tensioni e brogli in un clima per nulla disteso e in continua agitazione.
Adele Fuccio