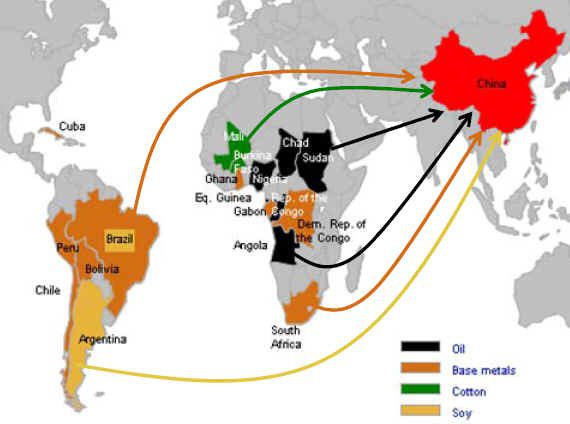La politica estera turca del secondo governo AKP e del suo Ministro degli Esteri Ahmet Davutoğlu è da molti considerata come totalmente alternativa rispetto alla tradizionale politica estera turca. Essa infatti avrebbe compiuto uno spostamento del suo asse (shift), da posizioni atlantiste, fondate su una forte alleanza con gli Stati Uniti d’America, ad una concezione multilaterale e poliedrica del ruolo della Turchia nel suo contesto regionale, indicata come “Neo-ottomanismo”
UN NUOVO IMPERO? – Col termine “Neo-ottomanismo” si vorrebbe definire quindi una rivitalizzazione dei tradizionali legami storici, culturali, economici e geopolitici fra la Turchia e i suoi vicini, in particolar modo Mediorientali, che porterebbe alla ricostituzione di un blocco geopolitico simile a ciò che è stato l’Impero Ottomano. La dirigenza turca respinge in toto sia l’idea di un cambiamento dei tradizionali orientamenti della politica estera, sia la volontà di ricostituzione di un blocco internazionale che agisca come perno della regione mediorientale, caucasica e balcanica, come fatto per quasi cinque secoli dall’Impero ottomano.
Analizzando l’idea dello shift della politica estera turca in primis ci si dovrebbe chiedere verso dove questo spostamento sia stato attuato. Indubbiamente si possono rintracciare due grandi aree nelle quali tale spostamento appare evidente. La prima è l’orizzonte ideale della classe di governo turca: seppure essa non manchi di fare riferimento continuamente alla figura del fondatore Mustafa Kemal, la sua concezione storico-politica è tutta tendente a recuperare i legami della nuova Turchia con la sua storia ottomana, agendo implicitamente in contrasto con la ratio che aveva portato Ataturk a fondare la Turchia repubblicana. Questo recupero non solo riguarda una maggiore enfasi sulla religione, ma determina una rivitalizzazione di una concezione geopolitica di perno sia della regione mediorientale sia della totalità del mondo musulmano sunnita. La seconda area riguarda le relazioni internazionali e in particolare l’indebolimento della tradizionale alleanza con gli Stati Uniti, una minore enfasi del ruolo turco nella NATO e un maggiore dinamismo in politica estera, basato su una concezione apertamente multilaterale delle relazioni internazionali. Il processo di integrazione della Turchia nell’UE può essere ricondotto a questa nuova sensibilità multilaterale.
QUALI EFFETTI – Ci si potrebbe ora chiedere se questi cambiamenti dei tradizionali orientamenti della politica estera turca abbiano effetti marginali, siano in qualsiasi modo trascurabili, oppure abbiano una valenza di fondo nel modificare le strategia politiche della Repubblica turca. Mentre molti osservatori indicano come indubbiamente la Turchia stia voltando le spalle all’Occidente, pare in assoluto più corretto dire come la Turchia resti, nei suoi orientamenti più profondi, ancora strettamente legata all’Occidente in particolare in ambito economico. Infatti, mentre molti analisti non fanno che sottolineare i rapporti economici fra Ankara e i Paesi del Golfo e l’Iran, tralasciano come buona parte dell’interscambio commerciale, degli investimenti diretti esteri provenga da occidente e in particolare dai Paesi europei. (Nel grafico: ammontare degli investimenti diretti esteri (IDE) in Turchia ad ottobre 2010 – tratto da www.invest.gov.tr)
Oltre a ciò è necessario ricordare come l’entrata della Turchia nella NATO e il suo processo di integrazione comunitaria facciano parte di un tradizionale orientamento della politica estera prima ottomana e poi turca iniziata con l’era Tanzimat, il cui fine era duplice: colmare il ritardo militare ed economico della Sublime Porta con le potenze europee e ottenere da esse un completo riconoscimento dello status di potenza europea dell’Impero ottomano.
UN RAPPORTO NECESSARIO – Su questi elementi si può indicare come la Turchia, data la sua posizione geografica, si veda obbligata a perseguire una politica europeista a patto di non voler rinunciare alla sua massiccia crescita economica. Infatti, seppure lo volesse, la Turchia non potrebbe voltare completamente le spalle all’Occidente e dovrebbe continuare a guardare, come un Giano bifronte del Bosforo,sia ad oriente che ad occidente. Infatti le modifiche che la classe di governo turca sta imponendo in politica estera fanno parte di un disegno coerente che mira a riproporre la Turchia come un attore internazionale di prima grandezza. Tale disegno si basa su una ambiguità di fondo, data dal perseguimento di due politiche apertamente in contrasto: l’integrazione nell’UE, infatti non appare in qualunque modo compatibile con il rafforzamento del ruolo internazionale della Turchia, che ha manifestato ad esempio la volontà di ottenere un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Tale ambiguità si dovrà prima o poi scontrare con la realtà economica della Turchia e la sua necessità di mantenere stretti legami con i Paesi europei. Infatti sia il rafforzamento a livello internazionale della posizione turca, sia il consenso elettorale dell’Adalet ve Kalkinma Partisi si fondano su una massiccia crescita economica data da ingenti investimenti esteri e dalla partecipazione all’area doganale UE. Senza tali elementi la Turchia ritornerebbe alla marginalità che l’ha contraddistinta durante la Guerra Fredda. La domanda che ci si dovrebbe porre dunque non è se l’Occidente abbia perso la Turchia, ma se la Turchia possa permettersi di perdere l’Occidente.
Antonio Cocco