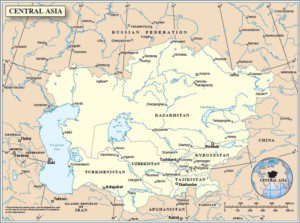Il 4 maggio Panama ha scelto un nuovo presidente: Juan Carlos Varela. Il candidato dell’opposizione ed ex vicepresidente ha guidato una campagna che promette crescita economica e riduzione della povertà. L’elevato tasso di crescita del Paese saprà redistribuire la ricchezza tra l’intera popolazione?
LE ELEZIONI – Lo scorso maggio quasi 2,5 milioni di panamensi sono stati chiamati alle urne per le elezioni generali esprimendo le loro preferenze per il Presidente e il vicepresidente, i settantuno membri dell’Assemblea Nazionale, i venti membri del Parlamento centroamericano (PARLACEN), insieme a centinaia di uffici comunali. Panama ha scelto così la classe politica che guiderà il paese dal 2014 al 2019, ma i riflettori sono puntati senza dubbio sul nuovo presidente Juan Carlos Varela. Una vittoria inaspettata rispetto le previsioni dei sondaggi elettorali che davano come favorito il candidato di Cambio Democratico José Domingo Arias, scelto personalmente dal Presidente uscente Ricardo Martinelli. Arias in caso di vittoria avrebbe guidato il Paese con l’aiuto dell’attuale first lady, ovvero la moglie del presidente Martinelli Marta Linares, candidata alla vicepresidenza. Questo, non a torto, ha fatto pensare a una rielezione occulta dell’ex Presidente, impossibilitato alla candidatura secondo le previsioni costituzionali che limitano il mandato elettorale. Arias ha così ottenuto il 32% dei voti mentre al terzo posto con 491.035 preferenze (27,46%) si è piazzato Juan Carlos Navarro del Partido Revolucionario Democratico. I panamensi hanno scelto come nuovo presidente il leader dell’opposizione Juan Carlos Varela, candidato del Partito Panameñista (PPa), in alleanza con il minoritario Partido Popular, che ha ottenuto 689.720 voti, in altre parole il 39%. La tornata elettorale, che ha registrato una partecipazione pari al 75%, denota la volontà di cambiamento da parte della società civile che cerca di riscattare i propri interessi per troppi anni sacrificati in nome della crescita economica.
IL PRESIDENTE – Juan Carlos Varela rappresenta davvero l’uomo del cambiamento nella politica panamense? Varela è attualmente vicepresidente della Repubblica di Panama, incarico che ricoprirà fino al 1 luglio quando inizierà il suo mandato elettorale. Salito al potere con le scorse elezioni grazie alla coalizione tra il Partido Panameñista e Cambio Democrático, presieduto da Ricardo Martinelli, è stato destituito dal suo incarico di Ministro degli Esteri nel 2011. Le forti divergenze in tema di giustizia, e le accuse mosse a Martinelli di scarsa trasparenza ed eccessivo dirigismo hanno portato alla rottura dell’accordo di colazione del 2009. L’imprenditore panamense ha così deciso di concorrere alla carica presidenziale come rappresentante del partito di opposizione con il Partido Panameñista, ottenendo il 99% dei voti alle primarie. Varela è stato quindi nominato il candidato dell’Alianza “El Pueblo Primero”, formata dal Partido Panameñista e dal Partido Popular con l’appoggio del movimento politico “Los Gallos de Verdad”. Varela ha basato la sua campagna elettorale sulla lotta alla corruzione, rivolgendo pesanti accuse al suo predecessore; la sua vittoria è stata favorita dal dialogo che ha cercato di instaurare con i cittadini panamensi, stanchi degli scioperi e delle manifestazioni tenutesi i giorni precedenti alle elezioni che hanno paralizzato l’industria edilizia del Paese, bloccando anche i lavori per l’ampliamento del Canale di Panama.
TRA CRESCITA E DISUGUAGLIANZA – Panama sotto la guida di Martinelli ha conosciuto una forte crescita economica, di circa l’8% annuo, trainata dai lavori e dagli investimenti esteri per l’ampliamento del canale; Martinelli però non è riuscito a diffondere il benessere tra popolazione di cui il 27% vive in condizioni di povertà e a ridurre le forti diseguaglianze economiche. La campagna elettorale di Varela ha posto al centro dell’attenzione le necessità della popolazione: punti cardine del programma sono, infatti, benessere e sviluppo umano, rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto, sviluppo economico sostenibile. I cinque pilastri su cui si fonda il piano di governo dell’alleanza “El pueblo primero” sono un minor costo della vita, città sicure, un piano di sanità nazionale, educazione bilingue per tutta la popolazione e il diritto alla salute per tutti. Un piano che evidenzia le profonde spaccature della società nei confronti di Martinelli accusato di aver usato il suo potere di governo per il proprio tornaconto personale senza considerare gli interessi della popolazione, come nella gestione della zona di Còlon. Il periodo precedente alle elezioni è stato caratterizzato da forti agitazioni nella società civile panamense legate a tensioni sul piano lavorativo e sociale. Il settore più colpito è stato quello dell’edilizia, traino dell’economia che nel 2013 ha contribuito al 12% del PIL, con proteste a favore dell’aumento salariale. Le tensioni nascono dalla consapevolezza che la distribuzione della ricchezza non è avvenuta in modo ugualitario, il costo della vita negli ultimi anni è aumentato del 41%, mentre i salari degli operai sono aumentati solo del 18%.

OLTRECONFINE – La vittoria di Varela è stata ben accolta dal capo di Stato venezuelano Nicolas Maduro. Le relazioni diplomatiche tra i due paesi si erano rotte unilateralmente lo scorso 5 marzo dopo che Martinelli era intervenuto presso l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) a favore dell’opposizione venezuelana. Varela ha assicurato che la ripresa dei rapporti con il Venezuela sarà una delle priorità del governo, dimostrando una linea di politica estera contraria a quella di Martinelli che aveva preso le distanze dai governi di sinistra del continente. Altra priorità sarà portare a compimento il progetto di ampliamento del Canale di Panama, fissato inizialmente ad agosto 2014, il cui ritardo potrebbe portare delle ingenti perdite economiche al paese. Panamá gode di una posizione geografica particolarmente strategica, congiunge, infatti, due subcontinenti e due oceani rappresentando uno dei punti di transito navale più importante al mondo e per questo ha destato da sempre l’attenzione degli Stati Uniti sul controllo della zona. Il nuovo corso politico panamense dovrebbe dare impulso alla conclusione dei lavori che sotto il governo di Martinelli hanno subito pesanti ritardi a causa dell’aumento del costo dei lavori, lievitati di 1,6 miliardi di dollari. Gli scandali di corruzione che hanno coinvolto Martinelli, come l’ultimo che vede coinvolta anche Finmeccanica, hanno sicuramente pesato sulla’andamento dei lavori e sul giudizio critico di Washington nei confronti dell’ex Presidente. L’interesse per il canale da parte degli Stati Uniti non riguarda solo un progetto di crescita economica sostenibile ma sembra essere più uno strumento per il controllo dei loro interessi particolari in questa zona strategica. Intanto progetti concorrenti come quello del presidente del Nicaragua Daniel Ortega, in accordo con il magnate cinese delle telecomunicazioni, Wang Jing, proprietario della società cinese Hknd, di realizzare un canale marittimo che consentirebbe alla Cina di scardinare il rapporto commerciale privilegiato tra Stati Uniti e America Latina, rendono sempre più pressanti le richieste di conclusione dei lavori. Sarà interessante quindi vedere se Varela riuscirà a garantire l’esigenza degli Stati Uniti e rendere Panama un Paese sicuro su cui investire, riuscendo al tempo stesso a tramutare la ricchezza in benessere condiviso.
Annalisa Belforte