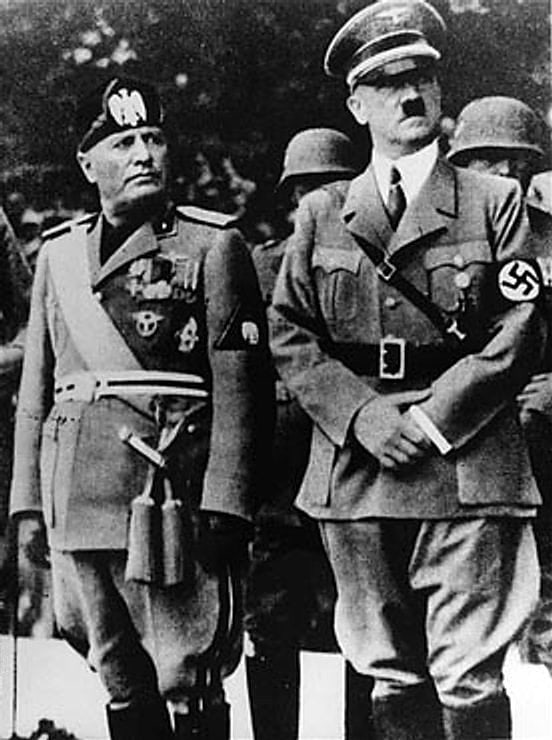L'Egitto sta considerando di approvare una legge sulla libertà di informazione: si tratterebbe di un bel passo in avanti sulla strada della democrazia per uno Stato che fino a pochi mesi fa era governato da un regime autoritario. Tra il dire e il fare, come sempre, la distanza è sempre ampia. Ecco dunque i dubbi e le perplessità sulla reale efficacia che avrebbe l'implementazione di tale progetto
Tratto da Notizie Radicali
VIA IL BAVAGLIO? – Per la prima volta nella storia del suo sistema legale e dopo vari tentativi falliti, nelle prossime settimane l'Egitto potrebbe finalmente elaborare la bozza di una legge sulla libertà d'informazione. La legge proposta dovrebbe istituire un procedimento volto a permettere ai cittadini egiziani di accedere alle informazioni del governo, a cui è richiesto tra l'altro di render pubblico un maggior numero di informazioni. La proposta di legge che l'Egitto sta considerando è stata elaborata da Toby Mandel, esperto di legislazione sull'informazione, Presidente del Centro per il Diritto e la Democrazia con sede negli Stati Uniti e consulente della Banca Mondiale.
Attualmente, il Centro per l'Informazione e il Sostegno alle Decisioni del governo (IDSC) sta esaminando la bozza insieme ad attivisti dei diritti umani, accademici e giornalisti.
Mohamed Ramadan, direttore dell'IDSC, ritiene che i recenti sviluppi siano positivi ma, al tempo stesso, prevedibili: “nel 2000, soltanto 19 Paesi avevano delle leggi sulla libertà d'informazione. Da allora al 2010, circa 90 Paesi si sono dotati di una legge in materia”. Sulla scena internazionale, le leggi sull'informazione sono state spesso utilizzate come misure anti-corruzione, soprattutto in quei Paesi in cui tale pratica è particolarmente radicata: basti pensare alla Legge Federale su Trasparenza ed Accesso alle Informazioni Pubbliche del governo in Messico (2002) o alla Legge sul Diritto all'Informazione in India (2005).
Secondo Ramadan, la legge attualmente in esame si inserisce perfettamente nella fase di transizione democratica che l'Egitto sta vivendo. “Dal punto di vista del governo, garantire l'accesso alle informazioni potrebbe rivelarsi il modo migliore per mostrare responsabilità e gestire le aspettative”, afferma.
LA BOZZA – Ramadan spera che si possano finalmente cogliere i frutti di questi sforzi di collaborazione, dopo gli almeno 10 tentativi falliti di elaborazione di una legge in materia.
“Si nota una predisposizione generale del governo a coinvolgere la società civile che va valutata positivamente”, afferma Amr Gharbeia, responsabile dei progetti su tecnologia e informazione dell'Iniziativa Egiziana per i Diritti della Persona e personalmente coinvolto nel processo di stesura della bozza.
La bozza, che consta di 38 articoli, disciplina il procedimento tramite il quale i cittadini possono accedere alle informazioni del governo. È divisa in 9 sezioni che si occupano di definizioni chiave, diritto di accesso, pubblicazione regolare delle informazioni, il procedimento necessario per richiedere e ottenere informazioni, eccezioni al diritto di accesso, meccanismi di promozione e sanzioni.
Per quanto riguarda la prima sezione della legge, i membri della società civile coinvolti nella stesura della bozza hanno insistito sulla definizione di alcuni termini che, altrimenti, la legge avrebbe soltanto citato, lasciando così la possibilità di restringere arbitrariamente l'accesso alle informazioni.
“Abbiamo lavorato sulla definizione di 'sicurezza nazionale', esercizio importante anche al di fuori del ristretto ambito di tale legge. Il 28 gennaio, ad esempio, le comunicazioni sono state interrotte ricorrendo alla scusa della 'sicurezza nazionale'”, ricorda Gharbeia.
Nell'emendamento proposto, i membri della società civile hanno definito la sicurezza nazionale in relazione alle informazioni militari, come quelle sull'acquisto e la produzione di armi, i piani militari e le minacce straniere alla sicurezza del Paese.
Per quanto riguarda le eccezioni, che istituiscono limiti legali al diritto di accesso alle informazioni, le parti coinvolte nella stesura della legge hanno cercato di minimizzarle. Fra le eccezioni previste, val la pena di citare: informazioni che potrebbero danneggiare indagini di polizia; informazioni private su un terzo; questioni di sicurezza nazionale così come definite nella prima sezione della bozza; informazioni che potrebbero danneggiare alle politiche di sviluppo del governo.

DUBBI – Sebbene molti concordino nel ritenere che questa bozza sia promettente e ambiziosa, permangono comunque alcuni dubbi e preoccupazioni sulla sua implementazione. Le istituzioni governative, ma non solo, non hanno mai applicato un sistema di gestione della documentazione che permetta un facile accesso. “Abbiamo alle spalle una lunga storia di inefficienza nel sistema di gestione della documentazione che non ne facilita l'utilizzo e la circolazione”, aggiunge Gharbeia.
Un altro possibile ostacolo all'implementazione della legge consiste nell'attuale sistema normativo, potenzialmente in contrasto con quanto previsto da questa bozza. “Stiamo lavorando basandoci sul presupposto che la legge recente abroghi quella precedente”, afferma Ahmad Ezzat, avvocato dell'unità legale di Libertà di Pensiero e di Espressione, ONG che si occupa di queste questioni. “Ciò che conta è prevedere un meccanismo costituzionale che protegga la legge”.
Ezzat aggiunge che, nella Costituzione del 1971, il diritto all'informazione era limitato ai giornalisti a discapito della gente comune. Ciò vuol dire che gli attivisti per i diritti umani potrebbero trasferire la battaglia per la libertà di informazione al dibattito sulla nuova Costituzione, la cui stesura dovrebbe cominciare dopo le elezioni di settembre.
Ezzat nutre dei seri dubbi sulla possibilità che la proposta di legge sull'informazione, comprendente tutti gli emendamenti aggiunti, venga accettata dal governo e dal Consiglio Militare attualmente al potere. “Lo Stato, a partire dall'ultimo impiegato nella scala gerarchica fino ad arrivare ai livelli dirigenziali, tratta ancora le informazioni alla stregua di armi ed esplosivi. È un'eredità che ci portiamo dietro da tanto tempo e che potrà essere cambiata solo con una reale volontà politica in tal senso”, afferma.
La volontà politica di cui parla Ezzat non è scontata. L'adozione di una legge sulla libertà di informazione è stata da più parti associata alla volontà dell'Egitto di ricevere i fondi di sviluppo e di investimento di organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Perché questi fondi vengano erogati, la responsabilità del governo nei confronti dei cittadini è un prerequisito indispensabile.
“Cose come una legge sulla libertà di informazione dovrebbero essere viste come una condizione positiva”, afferma Amy Ekdawy, manager del programma regionale al Centro di Informazione Bancaria basato negli Stati Uniti e supervisore delle politiche della Banca Mondiale. “La gente è molto sensibile ai temi della condizionalità e della sovranità nazionale. Ma in questo caso si parla solo di responsabilità”.
Ekdawy aggiunge che i prestiti allo sviluppo della Banca Mondiale consistono in una forma di finanziamento che confluisce direttamente nel bilancio statale quindi l'esborso non può essere attribuito ad un progetto concreto. “Con un governo in transizione come quello che si vede oggi in Egitto, i donatori necessitano di misure straordinarie per assicurare la trasparenza e la responsabilità, soprattutto laddove si consideri che il debito ricadrà sulle spalle delle generazioni future”.
Sabato scorso, il Ministro delle Finanze Samir Radwan ha dichiarato che, dopo aver rivisto il bilancio e ridotto le previsioni di debito, l'Egitto non chiederà alcun prestito alla Banca Mondiale o al Fondo Monetario Internazionale.
Resta da vedere se questa mossa avrà ripercussioni sull'adozione della bozza di legge sulla libertà d'informazione che, come già sottolineato, potrebbe essere un incentivo all'approvazione di questi prestiti.
Lina Attalah Sun (per www.almasryalyoum.com ) – traduzione di Federica Favuzza