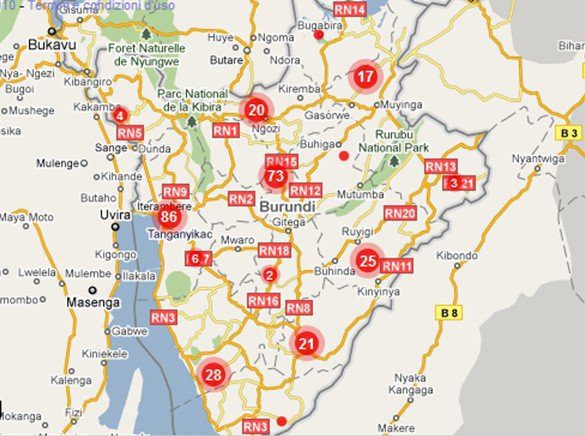La morte improvvisa di Néstor Kirchner, leader della scena politica argentina, apre scenari molto ampi ed incerti in vista delle elezioni presidenziali che si terranno nel 2011. In questo articolo ripercorriamo le vicende della carriera di Kirchner, che dal 2003 al 2007 è stato Presidente dell’Argentina prima di lasciare il posto alla moglie Cristina, attualmente in carica.
IL MATRIMONIO KIRCHNER – Il 27 ottobre la morte improvvisa per infarto di Néstor Kirchner ha risvegliato negli argentini le peggiori recenti paure di instabilità politica e crisi. Marito della Presidente in carica, Cristina Fernández, ex Presidente in un dei periodi più duri per la storia di questo Paese, Kirchner ricopriva ora il ruolo di capo del Partido Justicialista, il più forte sulla scena politica. Ma non solo. Perché in realtà Kirchner faceva molto di più: era il principale consigliere del governo di sua moglie, diretta continuazione del proprio (tanto che si parlava di governo del “matrimonio K”), prendeva, decisioni cruciali per l’economia e soprattutto sceglieva gli uomini chiave a tutti i livelli, dal locale al nazionale. Eccellente negoziatore, Kirchner era anche un punto di riferimento della politica di integrazione sudamericana, in veste di presidente dell’UNASUR, e insieme a Chávez e Lula costituiva i pilastri della sinistra al potere nel continente.
FATTORE “K” – I tre giorni di lutto nazionale decretati da sua moglie hanno visto una partecipazione popolare enorme alle sue esequie, come in nessun altro caso eccetto probabilmente quelli di Perón ed Evita. Escluse le personalità politiche dissidenti dalle visite ufficiali, il modello K ha continuato sulla sua linea, in un bagno di folla di Cristina Fernández di populista e peronista memoria. La ragione di tale partecipazione di massa, totalmente spontanea, è da ricondursi alle condizioni in cui Néstor Kirchner prese iL potere nel 2003: un Paese a pezzi, a livello economico e finanziario, ma anche stremato da decenni di gestione politica volta allo sfruttamento e alla corruzione. La grande abilità di questo presidente fu quella di saper ridare fiducia alla gente in una fase storica nella quale tutto, dopo la crisi del 2001, sembrava perduto. E al di là dei difetti del suo modello produttivista, è innegabile che l’Argentina sotto il suo mandato sia cresciuta a livelli sostenuti, e abbia visto un riavvicinamento dei giovani all’interesse politico. Il “pinguino” – così chiamato perché era stato per molto tempo governatore della Provincia di Santa Cruz, vicino alla gelida Terra del Fuoco – aveva inoltre riunito intorno a sé, in una gestione poco incline alla formalità e al protocollo, moltissimi movimenti e associazioni civili per i diritti umani, per la sua clamorosa decisione di ritirare la Ley de Obediencia Debida ai militari della dittatura del ‘76, e così porre in marcia un’epurazione dei corpi di polizia che fino a pochi anni fa nascondevano molti assassini e torturatori impuniti. La stessa speciale relazione con las Abuelas de Plaza de Mayo è testimonianza di quanto fatto da Kirchner per i familiari dei desaparecidos.

PROSPETTIVE – Adesso si aprono scenari interessanti: mentre la popolazione si sente orfana, e teme un crollo del governo, la Presidente ha voluto dare forti segnali di continuità del modello economico. Ma le elezioni sono nel 2011, e Kirchner era il principale candidato di un PJ diviso da correnti interne e alleanze scomode – come quella con il sindacalista Moyano- che solo lui riusciva a mantenere unito. Mentre già si parla di ricandidare Cristina Fernández (anche se la Costituzione non lo consente), entra in gioco Máximo, figlio della coppia e militante a Santa Cruz, e c’è chi si divide le spoglie di un impero politico capillare, esteso e complesso. Finora nessuno dei dirigenti sembra in grado di cogliere questa ingombrante eredità.
Clara Marrone